|
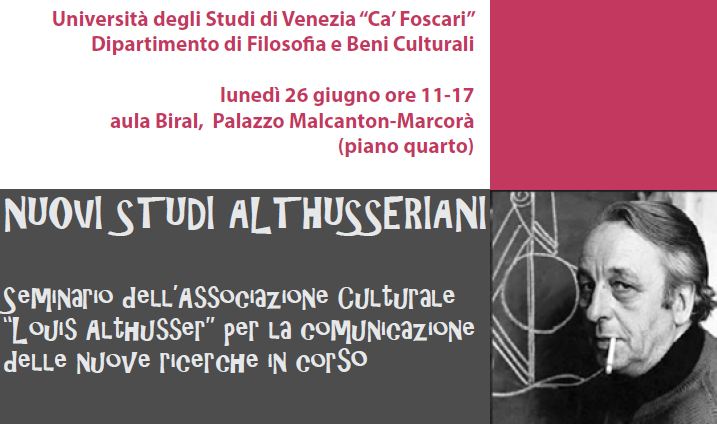 |
Materiali del seminario "Nuovi studi althusseriani"
- Venezia, 26 giugno 2017
|
Il terzo grado di conoscenza:
Althusser tra Gorthe e Simondon
Guido Mangialavori
La pianta
primitiva diventa la cosa più sorprendente del mondo, per la quale la natura
stessa mi invidierà. Con questo modello e con la sua chiave si potranno
inventare piante all'infinito, che saranno conseguenti, vale a dire che, anche
senza esistere nella realtà, potrebbero tuttavia esistere; che non saranno ombre
o parvenze pittoriche, ma avranno una verità e necessità interiori.
J. W. Goethe, Lettera a Herder, Napoli, 17.5.1787, in Viaggio in Italia.
In teoria,
seguendo questo metodo potremmo addirittura generare dei modi di produzione mai
esistiti prima come formazioni indipendenti, e che dunque come tali non
appartengono a alcuna "periodizzazione" [...] o, ancora, concepire modi di
produzione di cui è possibile solo prevedere le condizioni generali, come ad
esempio il modo di produzione socialista.
Etienne Balibar, Sui concetti fondamentali del materialismo storico, in Leggere
il Capitale.
I
La pioggia di Malebranche, Althusser
ne parla più di una volta[1],
quella che non cade sulle coltivazioni ma scende sul mare, sulle strade, sulla
sabbia, perduta, inutile: una pioggia provvidenziale, o piuttosto
controprovvidenziale. Goethe, in un altro tempo e in un altro luogo, prendeva le
distanze dall'uomo che misura gli oggetti in base alla propria natura e
disposizione, colui che va ragionando su utile, funzione, scopo pensando, solo
per fare un esempio, che quello del cane sia raccogliere la selvaggina[2].
Nella natura non si danno Fini, e dunque, seguendo Althusser, nemmeno Origine[3].
Bisogna sempre partire dalla situazione in cui ci si trova, guardarsi intorno,
puntare a ciò che già c'è, al fattuale[4].
Entrambi avevano incontrato Spinoza e avevano frequentato i suoi testi.
L'incontro aveva fatto presa. Come quello con Marx, per Althusser, e con
Machiavelli, soprattutto[5].
Goethe lo metteva tra coloro che più l'avevano influenzato, insieme a
Shakespeare e Linneo[6].
Quello di Linneo è un sistema formale, che propone una
classificazione delle forme basata sulle strutture degli organi riproduttivi
delle piante[7].
Questo sistema sessuale aderisce a un principio di subordinazione dei caratteri,
che consiste nel considerare secondari tutti i caratteri fisiologici, ambientali
e comportamentali, e primari solo una piccola parte di quelli
morfologico-anatomici. In campo vegetale, va privilegiata la considerazione di
numero, forma, posizione e proporzione degli stami nell'individuazione delle
classi, e dei pistilli nell'individuazione degli ordini.
Un metodo che Goethe avverte come un limite: per quanto le forme delle
creature organizzate siano distanti le une dalle altre, troviamo tuttavia che
esse hanno in comune determinate proprietà, e che certe parti possono essere
poste a confronto tra loro[8].
Agli occhi di Goethe, tra
quelle maglie tutto si muove, non vi è oggetto che possano tenere fermo e saldo,
le demarcazioni si confondono, le irregolarità rimangono inspiegate. Il metodo
di Linneo era troppo rigido e non portava a nulla.
Credetti di
riconoscere che Linneo e gli studiosi venuti dopo di lui si erano comportati
come legislatori i quali, meno preoccupati di ciò che è, che di ciò che dovrebbe
essere, non tengono nessun conto della natura e dei bisogni dei cittadini, e si
sforzano piuttosto di risolvere il difficile problema, come tanti esseri
indisciplinati e per natura intolleranti di confini possano, in qualche modo,
convivere[9].
Quando
Althusser, nel commentare i primi dodici capitoli del Principe, chiarisce il
metodo machiavelliano di ordinamento dei principati, comincia col dire che si
presenta come "una rassegna esaustive delle specie possibili, dei casi
possibili perché reali[10]",
un metodo, aggiunge, che
fa pensare a quello del Sofista di Platone, ma che invece, e questo è molto
importante, va in tutt'altra direzione, poiché "non si tratta affatto
di una enumerazione generale astratta dei casi possibili ottenuto per divisione,
valida per tutti i tempi e tutti i luoghi, ma al contrario del riassunto di
esempi concreti, di situazioni concrete che costituiscono la congiuntura
italiana contemporanea, e [quella dei] paesi vicini, Francia, Spagna. C'è anche
qualche esempio preso dall'antichità, ma solo per confermare gli esempi italiani
contemporanei[11]".
Machiavelli, dice
Althusser, "non applica casi generali alla storia[12]",
"non ci consegna nient'altro che una descrizione empirico-fattuale,
congiunturale in senso forte, dello stato di fatto attuale di tutti i principati
e di tutte le repubbliche italiane[13]".
Nei "Discorsi sopra la
prima Deca di Tito Livio" Machiavelli analizza sinotticamente repubbliche e
principati. Pone gli uni affianco agli altri alla ricerca di qualche determinato
tratto comune.
Non
è dunque la loro distinzione che interessa Machiavelli, ma è ciò che può esserci
in comune nella loro storia. E questo elemento in comune, questa invariante, è
un preliminare assoluto, è, nella prospettiva di un Principato nuovo adatto a
unificare l'Italia, il rifiuto di ogni dominio straniero, l'indipendenza
dell'origine e il carattere delle leggi[14]
II
Un individuo è sempre una
molteplicità. Quella che a noi pare una unità individuale è in realtà composta
da elementi molteplici, disposti in determinati rapporti reciproci, in una forma
determinata. Goethe lo sosteneva già nei Lavori
preliminari per la morfologia del 1788-89; è un concetto che torna in
una serie di appunti del 1800 sulla Morfologia come
scienza:
Il concetto
di individualità ostacola la conoscenza delle nature organiche. Si tratta di un
concetto banale. [...]
Nature organiche che sono palesemente delle pluralità[15].
Lo ribadisce
qualche anno dopo, precisandolo, nelle Idee sulla formazione organica
scritte tra il 1806 e il 1808:
Ogni essere
vivente costituisce non un essere singolo, ma una molteplicità; anche quando
esso ci appare come un individuo, resta tuttavia una riunione di esseri viventi
autonomi, simili quanto all'idea e alla disposizione, ma che possono presentarsi
all'apparenza esteriore come identici o simili, diversi o dissimili. Tali esseri
sono in parte riuniti insieme già all'origine, in parte invece si trovano e si
riuniscono solo in un secondo tempo, per poi duplicarsi e cercarsi di nuovo,
causando in tal modo una produzione infinita, che avviene secondo tutte le
modalità e in ogni direzione[16].
Ma come
avvengono quelle variazioni della struttura che danno luogo alle miriadi di
forme differenti che caratterizzano gli "individui apparenti"[17]?
Poiché una
pianta non costituisce una sola unità, ma è una creatura composta da più unità,
troviamo che le diverse unità nella loro successione, mutano forma e funzione
tramite modificazioni prevalenti delle loro parti[18].
La natura
produce forma perché agisce proprio su quelle parti: un numero estremamente
elevato di elementi. È quello che Goethe ripete più volte nei suoi scritti[19],
[...] a causa della grande quantità di parti e delle molteplici possibilità
della loro modificazione, i mutamenti della forma possono diventare infiniti[20].
III
Le forme,
pensate fuori dal paradigma sostanzialista aristotelico, e dunque dalla diade
concettuale forma e materia[21],
sono relazioni tra elementi, relazioni non rigide ma mobili, che si
dispiegano panoramicamente su di un piano sinottico. È di queste forme dinamiche
che la morfologia si occupa, per questo Goethe pone un importante discrimine tra
il termine Gestalt e il termine Bildung:
Il
tedesco indica il complesso dell'esistenza di un essere reale con la parola
Gestalt. Con tale espressione si fa astrazione da ciò che riguarda il movimento,
e si assume che un insieme coeso sia anche stabile, isolato e fisso nel suo
carattere.
Ma se consideriamo tutte le forme, e in particolare quelle organiche, notiamo
che non si presenta mai qualcosa che semplicemente sussiste, in quiete e
isolato, ma che piuttosto ogni cosa oscilla in un movimento costante. Perciò la
nostra lingua è solita far uso a buon diritto della parola Bildung sia a
proposito di ciò che è stato prodotto, sia riguardo a ciò che si sta formando[22].
Gli
elementi, nel momento in cui reciprocamente si ingaggiano, danno luogo a una
forma[23],
e si subordinano alla relazione cui danno vita. Potremmo forse dire che la forma
funziona in regime di apres coup, e la Bildung altro non è che la
"forma dell'incontro, la struttura dell'incontro; da qui, una volta
effettuato l'incontro (ma non prima), il primato della struttura sui suoi
elementi; da qui infine ciò che possiamo chiamare un'affinità e completezza
degli elementi in gioco nell'incontro, la loro "capacita di coesione", perché
questo incontro "faccia presa", cioè prenda forma, dia infine nascita a delle
Forme e nuove[24]".
Proprio in
virtù della predominanza di una parte sull'altra, la forma ha margini
virtualmente innumerevoli all'interno della stessa specie, o tra specie diverse,
lo vediamo ad esempio nella giraffa, dove la crescita del corpo è subordinata a
quella di collo e zampe, il contrario di ciò che avviene nella talpa, con le sue
estremità corte e il corpo in posizione dominante[25].
La forma si dà dunque come disposizione di elementi, i quali stanno in relazione
reciproca secondo una struttura a dominante[26].
L'estensione
di una parte è causata dall'annullamento di un'altra parte. Alla base di questa
legge sta la necessità a cui è vincolata ogni creatura, che non può eccedere la
propria misura. Dunque non è possibile che una parte aumenti senza che un'altra
diminuisca, o che una parte divenga pienamente dominante
senza che l'altra sia completamente
annullata[27].
Prendiamo ad
esempio un modo di produzione, esso è una combinazione data dall'incontro dei
'mezzi di produzione', dei 'rapporti di produzione' e degli elementi che li
articolano. Un modo di produzione 'corrisponde a un centro di relazioni'[28],
è una forma che prende
vita dall'incontro di una serie di elementi che ad essa si subordinano. Nel
gioco di metamorfosi dei modi di produzione possiamo individuare delle
invarianti.
"[...] la
grande lezione della pratica è che, se la struttura a dominante resta costante,
il gioco dei ruoli vi cambia: la contraddizione principale diventa secondaria,
una contraddizione secondaria prende il suo posto, l'aspetto principale diviene
secondario, l'aspetto secondario diventa principale. Ci sono comunque sempre una
contraddizione principale e delle contraddizioni secondarie, ma cambiano ruolo
nella struttura articolata a dominante che, invece, rimane stabile.[29]"
Pensiamo ora
all'incontro degli elementi volpe, leone, uomo e alla serie delle loro
variazioni all'interno della forma Principe[30].
Pensiamo poi a una sequenza di incontri aleatori: di nuovo, quello tra la volpe,
il leone, l'uomo che variano nella forma-misura del Principe, poi quello tra il
Principe e la Fortuna-congiuntura, e ancora, pensiamo alla congiuntura stessa,
essa stessa un incontro, che rimanda a sua volta alla serie di incontri
precedenti la sua produzione[31].
Queste forme sono già centri relazionali, che incontrandosi o meno possono
entrare o non entrare in nuove relazioni, e queste relazioni possono durare o
meno: nulla è detto.
Quello che é
importante in questa concezione non è tanto il dispiegarsi di leggi, dunque di
un'essenza, quanto il carattere aleatorio della 'presa' di questo incontro che
dà luogo al fatto compiuto, di cui si possono enunciare delle leggi. [...]
È il caso della
nascita, nello specifico, del modo di produzione capitalistico, prodotto
dall'incontro tra 'il proprietario di denaro' e il proletario provvisto solo e
solamente della sua 'forza-lavoro", un incontro fortuito, dice Althusser, che
può aver avuto luogo più di una volta nella storia, ma che poi ha fatto presa in
occidente, nella forma che conosciamo. Un incontro che è durato "ed è
diventato un fatto compiuto, il fatto compiuto di questo incontro, che provoca
dei rapporti stabili ed una necessità il cui studio fornisce delle leggi,
beninteso tendenziali [...].[32]"
In altre parole, "perché
un essere sia (un corpo, un animale, un uomo, uno Stato, o un Principe) bisogna
che l'incontro abbia avuto luogo al trapassato prossimo[33]."
Ci si trova presi nelle regole dell'incontro, quelle che dettano la misura entro
la quale si articolano le determinazioni della struttura che esso ha istituito,
per così dire, alle spalle degli elementi che ne vengono investiti a posteriori,
e dei quali saggia le possibilità di tenuta.
IV
"tutto
ciò che è fattuale è già teoria. Non si cerchi nulla dietro ai fenomeni, essi
stessi sono la teoria"[34].
È in questo contesto che si evidenzia la peculiarità del suo pensiero
morfologico: che i fenomeni siano la teoria non significa che in essi sia
contenuta una qualche teoria scientifica, ma che i fenomeni manifestano sempre
ed inevitabilmente al nostro sguardo la rete delle relazioni che li connette sia
reciprocamente sia ad altri fenomeni, rivelandoci l'ordinamento o la sequenza
dei nessi di prossimità e di parentela in virtù dei quali ognuno di essi
acquista una collocazione entro il sistema della natura[35].
Il tipo, l'
Urphänomen, è un nesso relazionale ricorsivo che corre tra le forme. È
grazie a questo nesso che le forme possono essere messe in serie. La
serializzazione ha un valore predittivo tendenziale e strutturale, non
ontologico e prescrittivo. Può dire, date determinate premesse, come sarà un
caso nella serie, mai dire che dovrà esserci, prima o poi, un tal caso così e
così. È in questa virtualità della serie che la natura non fa salti, ma la
fattualità è nell'ordine della discontinuità[36],
si possono infatti trovare le condizioni sotto le quali può aver luogo tutta la
serie tesa tra il leone e il gatto, ma non è affatto necessario che si diano
fattualmente tutte le specie che stanno sulla linea seriale individuata. La
necessità si dà solo in quel determinato incontro, con quei determinati
elementi, che derivano dall'infinità degli antecedenti incontri aleatori. È la
necessità che si sottomette alla contingenza[37]
installandosi nelle singolarità.
[...] nella
vita individuale e sociale non vi sono che singolarità (nominalismi), realmente
singolari - ma universali - poiché queste singolarità sono come attraversate e
pervase da invarianti ripetitive o da costanti, non da generalità, ma da
costanti ripetitive che si possono ritrovare nelle loro variazioni singolari in
altre singolarità della stessa specie e genere[38]
Per
sgomberare il campo da ogni equivoco occorre ribadire la presa di distanze da
ogni interpretazione platonizzante di queste costanti, dell'Urphänomenon
e della Bildung. Seguendo Deleuze, il metodo platonico della divisione ha
come scopo ultimo quello di "selezionare stirpi"[39].
Quello di Platone è dunque un intento selettivo: individuare un modello in base
al quale operare una selezione e ordinare in una serie del tipo Idea, copia,
simulacro, dove la copia è immagine dotata di somiglianza e il simulacro è
immagine senza somiglianza; esso produce sì un effetto di somiglianza, ma
è un effetto d'insieme, esteriore; un inganno, infine, che l'osservatore non può
dominare, quasi un trompe l'oeuil e che, proprio come questo, non può
funzionare se osservatore e osservato non si trovano presi nel medesimo gioco,
sotto il medesimo giogo.
Il metodo morfologico
di Goethe non stabilisce gerarchie, se sfrutta le somiglianze è per articolarle
su un piano sinottico, omogeneo. Il tipo non è mai un'Idea cui segua una copia e
un simulacro, né implica una ipotesi evolutiva. L'Ur-,
la forma del tipo, non segna un origine, e non determina nulla di
sostanziale, perché ciò che la morfologia ci permette di cogliere è, nel
movimento incessante delle forme, non la legge sotto cui
deve
cadere
la serie, ma la regola, ovvero la ricorsività
di un dato rapporto nella
serie[40]
con l'ausilio del quale questa può essere ordinata.
Così Spinoza
ritrova in modo del tutto naturale nella storia singolare del popolo ebraico una
costante che egli ha trattato "in generale" nell'appendice del libro I a
proposito della religione in generale; eppure non vi è mai religione in generale
in Spinoza.
[...] costanti o invarianti generiche che dir si voglia, le quali affiorano
nell'esistenza dei 'casi', costanti, non leggi, che non sono evidentemente
oggetto di verificazione in un dispositivo sperimentale astratto e ripetibile,
come in fisica o in chimica, ma la cui insistenza ripetitiva permette di
reperire la forma della singolarità in presenza e dunque il suo trattamento[41].
Poiché in fondo nel 'Terzo genere di
conoscenza' non abbiamo mai a che fare con un nuovo oggetto, ma sempre con una
nuova forma di rapporto di appropriazione (l'espressione è di Marx) di un
oggetto che è sempre-già-là a partire dal 'Primo genere di conoscenza': il 'mondo',
la lebenswelt, del primo genere, si eleva pur restando lo stesso[42]
V
Nella sua integrità, il "normale" nel
regno delle piante è, a ragione, una cosa sana, una purezza fisiologica; ma
l'"abnorme" non è immediatamente considerabile analogo a "malato" o a
"patologico". In questo senso si potrebbe eventualmente annoverare il
"mostruoso". In molti casi non è perciò giusto parlare di "errori": così come
anche accenna la parola "imperfezione", cui manca qualcosa, infatti ci può
essere un eccesso, oppure uno sviluppo senza equilibrio o contro lo stesso
equilibrio. Così anche parole come sviluppo sbagliato, deformazione,
storpiatura, deperimento dovrebbero essere usate con prudenza, perché in questo
regno la natura, pur operando con la più ampia libertà, non può tuttavia
allontanarsi dalle sue leggi fondamentali.
Se la natura fornisce la regola alle innumerevoli particolarità, allora dà forma
in modo normale, determina e condiziona; i fenomeni diventano invece abnormi,
quando le particolarità divengono soverchianti e si distinguono in modo
arbitrario e apparentemente casuale.
Ma poiché entrambi, il normale e l'abnorme, sono parenti stretti, e sia ciò che
è regolato sia ciò che è senza regola è animato da uno stesso spirito, sorge
perciò una oscillazione tra il normale e l'abnorme perché cambia sempre la
formazione e la trasformazione, cosicché l'abnorme sembra divenire normale e il
normale abnorme.
[...] La natura oltrepassa i confini che essa stessa si è posta, ma proprio per
questo raggiunge un'altra completezza; perciò noi ben facciamo qui a servirci il
meno possibile di espressioni negative[43].
Ci si trova in una zona di
indiscriminabilità dove, attraverso la proliferazione delle forme, private
dell'ideale, del paradigma, non può che cogliersi la regola nella suo prodursi.
"[...] la
legge non prevede solo i casi normali, ma anche i casi-limite, momenti di
fluttuazione e di apparente confusione, che risultano comprensibili se li si
riporta alla regola generale che governa il processo."[44]
Così
Althusser: "bisognerebbe forse chiedersi in che cosa consista l'eccezionalità
di questa 'situazione eccezionale', [la situazione rivoluzionaria in Russia]
e se, come ogni eccezione, essa non illumini la propria regola, – cioè se
essa non sia, all'insaputa della regola, essa stessa la regola. Perché
finalmente, non ci troviamo sempre in stato d'eccezione?[45]"
Per questo è
possibile installarsi al limite, perché al limite non c'è l'abisso, ma si è
sull'abisso, quell'instabilità radicale da cui le forme e il loro limite sono
pervase[46].
Il caso-limite non è il punto di minima tenuta della regola, anzi, ironicamente
si ritrova ad essere il suo punto di massima forza, e di massima tensione tra
gli elementi, punto culmine di tenuta dell'incontro, momento di suspense:
durerà? Si è colti, al limite, dalla vertigine di un incontro che potrebbe
finire da un momento all'altro.
"C'è una
donna immobile sotto la pioggia, segno che il suo amante l'ha lasciata. Lei non
ce l'ha fatta, ecco il punto, a legarlo a sé. L'amore costa fatica, proprio
vero. Si è liberi soltanto nelle limitazioni. E non c'è cosa più terrificante
dell'aver paura del terrore. Detto altrimenti: essere lasciati non ti fa
piombare nella solitudine come quando si è presi dall'angoscia che sta finendo;
perché quell'angoscia evoca un clima in cui hai addosso l'angoscia del terrore[47]"
VI
L'incontro,
dice Althusser, deve avere luogo tra affinissables, elementi che possono
divenire affini pur senza esserlo di per sé. Sono affinissables quei
termini che si modificano nell'incontro, che l'incontro stesso modifica nel
farsi della relazione, ma questo non offre nessuna garanzia sulla tenuta
dell'incontro[48]:
l'incontro
può aver luogo come non aver luogo. Nulla decide, nessun principio di decisione
decide in anticipo di questa alternativa, che è nell'ordine del gioco dei dadi.
"Un colpo di dadi non abolirà mai il caso". Eh sì! Non è mai garantito che un
incontro riuscito non sia breve ma duri, durerà ancora domani senza dissolversi[49].
Ma
è della massima importanza comprendere che, se la forma non preesiste
all'incontro dei suoi elementi, gli elementi non hanno che un'esistenza virtuale
prima del loro incontro in una struttura.
Per i
rivoluzionari non si possono separare le classi dalla lotta delle classi. La
lotta delle classi e l'esistenza delle classi. Costituiscono un'unica cosa.
Perché vi siano delle classi in una "società", occorre che la società sia divisa
in classi: questa divisione non si produce
a posteriori, è lo sfruttamento di
una classe da parte dell'altra, e perciò è la stessa lotta di classe che
determina la divisione[50]
Torniamo
all'inizio. La pioggia. La caduta degli atomi nel vuoto, una deviazione
infinitesimale: sono questi gli elementi che precedono l'incontro[51].
Althusser specifica che l'esistenza degli atomi non sopraggiunge loro che dalla
deviazione dell'incontro[52].
Prima del compimento del mondo, il non mondo che precede la costituzione di un
mondo non è se non l'esistenza irreale degli atomi[53].
È l'incontro che conferisce realtà agli atomi, senza questi sarebbero solo degli
elementi astratti[54]
che conducono niente più che un'esistenza fantomatica[55].
Inesistenti,
irreali, astratti, fantomatici, figure semplici dell'individualità[56]:
questi, ricapitolando, gli
attributi che descrivono gli atomi
prima che facciano presa in un incontro.
Ebbene,
se ogni individualità è sempre frutto di un incontro, tutto lascia pensare che
non si possa mai, regredendo, giungere a un individuo, ma si abbia sempre a che
fare con elementi plurali già formati da una molteplicità, e così via
all'infinito. Per questo è così importante sottolineare che Althusser parla
della filosofia dell'incontro come di una filosofia "più o meno atomistica"[57].
Egli non può ignorare che nell'atomismo "Le stesse forze di coesione, in cui
si potrebbe ravvisare il principio di individuazione dell'individuo composto,
sono ricondotte alla struttura delle particelle elementari che esistono da
sempre e sono gli autentici individui. Nell'atomismo, il principio di
individuazione coincide con le stessa esistenza di infiniti atomi[58]".
Sembra evidente dalla sua
esposizione della filosofia dell'incontro che Althusser non si colloca affatto
nei pressi dell'atomismo sostanzialista degli antichi, con le sue
caratteristiche di identità, assolutezza e indipendenza strutturale, in cui
"l'urto può modificare lo stato di quiete o di movimento di un atomo, ma non i
suoi caratteri propri, come ad esempio la massa[59]".
Ci troviamo piuttosto in
un ambito in cui l'essere non è distinto dall'operazione, e la relazione è
dell'ordine dell'essere: essa non lo esprime, bensì lo costituisce[60].
"L'incontro casuale, totalmente fortuito, intacca la sostanza. [...] poiché
ogni modificazione della relazione di una particella alle altre consiste altresì
in una modificazione dei suoi caratteri interni, non esiste una vera e propria
interiorità sostanziale della particella. Il vero e proprio individuo fisico,
anche in questo caso, come in quello del cristallo, non risulta concentrico ad
un limite di interiorità che costituisce il dominio sostanziale dell'individuo,
bensì giace sul limite stesso dell'essere. Questo limite si configura come
relazione, attuale o potenziale[61]".
Per questo non esiste
qualcosa come l'essenza di un individuo, la quale esprimerebbe definitivamente e
una volta per tutte i limiti del suo essere, in accordo con il rifiuto
althusseriano di "ogni filosofia dell'essenza (Ousia, Essentia, Wesen), vale
a dire della Ragione (Logos, Ratio, Vernunft), dunque dell'Origine e del Fine
[...] a vantaggio di una filosofia che, rifiutando il Tutto[62]
e ogni Ordine, rifiuta il Tutto e l'ordine a vantaggio della dispersione [...] e
del disordine. Dire che all'inizio non c'era niente o il disordine, significa
installarsi al di qua di ogni connessione e disposizione ordinata, rinunciare a
pensare l'origine come Ragione o Fine, per pensarla come niente[63]".
VII
Se gli elementi non precedono la
relazione, e la relazione non precede gli elementi, ma entrambi si danno nel
loro incontro, allora questo vuol dire che si è da sempre nell'esito, nel
risultato dell'incontro già avvenuto tra una totalità di elementi assenti,
fantasmatici, virtuali. Sia per Althusser che per Goethe
le forme si danno sempre in un "secondo tempo", a precederle c'è un fondo
indifferenziato: il nulla, il vuoto.
"Alla
vecchia domanda 'qual'è l'origine del mondo?', questa filosofia materialista
risponde con: 'il niente?' – 'nulla' – 'io comincio da nulla' – 'non c'è
cominciamento, perché non è mai esistito nulla prima che ci fosse qualcosa[64]".
Un tutto-nulla, informe e
caotico, "luogo germinativo di infinite forze complesse che si combinano in
aggregati più o meno estesi più o meno duraturi[65]".
"Nulla
vedrai nel vuoto eterno abisso,
non sentirai il suono del tuo passo,
nulla di saldo avrai, dove posare[66]".
VIII
Siamo alla
fine, l'incontro è avvenuto, e come nell'ultima scena di Casablanca Bogart si
rivolge a Claude Rains, così mi pace immaginare che Goethe si rivolga ad
Althusser, "Louis, credo che questo sia l'inizio di una bella amicizia".
[1]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p55, Cfr. anche L. Althusser,
L'avvenire dura a lungo, Guanda, 1992, p.196
[2]
J. W. Goethe, Teoria della forma, della trasformazione e della
comparazione (1788-1794), in Morfologia, Aragno, 2013, p.190
[3]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.93: "dato che l'origine
non è che l'anticipazione del fine nella ragione o ordine primordiale,
cioè nell'ordine, che esso sia razionale, morale-religioso o estetico".
[4]
Sul fattuale cfr.
L. Althusser, L'unica
tradizione materialista, in Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000,
p.162
[5]
L. Althusser, L'unica tradizione materialista, in Sul materialismo
aleatorio, Unicopli, 2000, p.143 "È sicuramente con Machiavelli che
dovevo provare la fascinazione delle fascinazioni".
[6]
J. W. Goethe, Storia dei miei studi botanici, in La metamorfosi delle
piante, Guanda, 1983, p.48
[7]
Cfr. F. Moiso, Goethe tra arte e scienza, Cuem, 2001, p.7
[8]
J. W. Goethe, Teoria della forma, della trasformazione e della
comparazione (1788-1794), in Morfologia, Aragno, 2013, p.139
[9]
J. W. Goethe, Origine del saggio sulla metamorfosi delle piante, in La
metamorfosi delle piante, Guanda, 1983, p.53
[10]
L. Althusser, Machiavelli e noi, Manifestolibri, 1999, p.115
[13]
L. Althusser, L'unica tradizione materialista, in Sul materialismo
aleatorio, Unicopli, 2000, p.155
[14]
L. Althusser, Machiavelli e noi, Manifestolibri, 1999, p.99
[15]
J. W. Goethe, Saggi
per una metodologia della scienza del vivente, in Morfologia, Aragno,
2013, p.337
[16]
J. W. Goethe, Idee
sulla formazione organica (1806-1807), in Morfologia, Aragno, 2013, p.360
[17]
Cfr. J.
W. Goethe, Saggi per
una metodologia della scienza del vivente, in Morfologia, Aragno, 2013
p. 323
[18]
J. W. Goethe, Teoria della forma, della trasformazione e della
comparazione (1788-1794), in Morfologia, Aragno, 2013, p.96
[19]
F. Moiso, Goethe tra arte e scienza, Cuem, 2001, p.131
[20]J.
W. Goethe, Abbozzi per
un tipo osteologico (1795-1796), in Morfologia, Aragno, 2013 p.212
[21]
Sul concetto di forma compiuta in Aristotele, P. Giacomoni, Le forme e
il vivente, Morfologia e filosofia della natura in J. W. Goethe, Guida,
1993, p.163,164 "il concetto aristotelico di
entelecheia non sembra interpretabile in senso dinamico, ma è da
considerare come conclusione del processo di trasformazione o come suo
presupposto: entelecheia ha per Aristotele anzitutto il significato di
perfezione, di compimento, di completa soddisfazione formale e non tanto
quella del processo che porta a essa, benché il termine venga usato di
conserva con quello di energheia. Se per Aristotele il movimento, il
mutamento ha origine dalla privazione e avviene nella materia,
l'entelechia è assolutamente sottratta ad esso, al divenire".
[22]
J. W. Goethe, Idee
sulla formazione organica (1806-1807), in Morfologia, Aragno, 2013, p.360
[23]
Cfr. P. Giacomoni, Le forme e il vivente, Morfologia e filosofia della
natura in J. W. Goethe, Guida, 1993, p.16, "Forma
come elemento composto, non come atomo semplice e indifferenziato, ma
come risultato, come esito di una relazione complessa e non reversibile
tra le parti."
[24]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p98. Sul primato dei
rapporti sui termini e sul concetto di individuo cfr. L. Althusser, Il
caso Tiblisi, in Sulla psicanalisi, Raffaello Cortina Editore, 1994, p.219.
[25]
J. W. Goethe, Abbozzi
per un tipo osteologico (1795-1796), in Morfologia, Aragno, 2013, p.212
[26]
L. Althusser, Per Marx, Mimesis, 2008, p.175 e seguenti.
[27]
J. W. Goethe, Teoria della forma, della trasformazione e della
comparazione (1788-1794), in Morfologia, Aragno, 2013, p.96
[28]
Crf. L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo
dell'incontro, in Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.114
[29]
L. Althusser, Per Marx, Mimesis, 2008, p.184
[30]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.65,66
[32]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.107
[34]
J. W. Goethe, Massime e riflessioni, n.488, in La metamorfosi delle
piante, Guanda, 1983, p.163
[35]
M. Andronico, Antropologia e metodo morfologico. Studio su Wittgenstein
La città del sole, 1998, p.144
[36]
F. Moiso, Goethe tra arte e scienza, Cuem, 2001, p.88, "Se
si costruisce attraverso una formula la parabola di un colpo di cannone,
oppure l'orbita di un pianeta [...], non si ha un concetto-classe sotto
il quale vengano ordinati altri sottoconcetti o altre sottoclassi, ma
una descrizione matematica di tutti i casi individuali che possono
cadere all'interno di tale descrizione del fenomeno." p.88
Cfr.
anche R. H. Brady, Form and Cause in Goethe's Morfology,
"After
all, a
mathematical differential, however predictive of future forms, is not a
productive power but a specification of relations. It shows us how the
finished product is structured, but not how it was caused."
p17
[37]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.60
[38]
L. Althusser, L'unica tradizione materialista, in Sul materialismo
aleatorio, Unicopli, 2000, p.131
[39]
Cfr. G. Deleuze, Simulacro e filosofia antica, in Logica del senso,
Feltrinelli, 2005, p.224
[40]
Cfr. P. Giacomoni, Le forme e il vivente, Morfologia e filosofia della
natura in J. W. Goethe, Guida, 1993, p.17 "Ciò
che esiste effettivamente sono solo i singoli dati concreti, effettuali,
le singole specie viventi, l'invariante è solo la possibilità di vederli
in sequenza, individuandone così il mutare continuo, il graduale passare
da un esemplare all'altro di uno stesso modello, di una stessa struttura
o composizione caratteristica di parti. [...] la varietà della natura
rimane l'unico dato effettuale, nessun'altra realtà ulteriore viene
ipostatizzata o aggiunta a esse, ma è possibile una visione stilizzata,
non astratta nel senso di separata o residuale, ma sicuramente
organizzabile secondo una regola, definibile secondo un criterio che non
è a priori."
[41]
L. Althusser, L'unica tradizione materialista, in Sul materialismo
aleatorio, Unicopli, 2000, p.132
[43]J.
W. Goethe, La metamorfosi delle piante,
Guanda, 1983, p.117
[44]
P. Giacomoni, Le forme e il vivente, Morfologia e filosofia della natura
in J. W. Goethe, Guida, 1993, p.22
[45]
L. Althusser, Per Marx, Mimesis, 2008, p.95
[46]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.104
[47]
R. W. Fassbinder, Se hai l'amore in corpo, in I film liberano la testa,
Ubulibri, 1988, p.21
[48]
Cfr. L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo
dell'incontro, in Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.99, nota
57
[49]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.67
[50]
L. Althusser, Risposta a John Lewis, in I Marxisti non parlano mai al
vento, Mimesis, 2005, p.46
[51]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.58
[58]
G. Simondon, l'individuazione psichica e collettiva, Deriveapprodi, 2001
p.27
[59]
G. Simondon, L'individuazione alla luce delle nozioni di forma e
informazione, vol.1, Mimesis, 2011, p.173
[60]
G. Simondon, L'individuazione alla luce delle nozioni di forma e
informazione, vol.1, Mimesis, 2011, p.174
[61]
G. Simondon, L'individuazione alla luce delle nozioni di forma e
informazione, vol.1, Mimesis, 2011, p.174
[62]
Trovo singolare che Althusser utilizzi in questo contesto il concetto di
"Tutto" e non quello di "Totalità", dal momento che quest'ultimo
sembrerebbe il più indicato. Insisto su questo punto in virtù di quanto
Althusser dice a proposito del "Tutto" in Spinoza, cfr. L. Althusser,
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.72, e sulla differenza tra
i due concetti in Hegel e Marx, cfr. L. Althusser, Per Marx, Mimesis,
2008, p.177
[63]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, in
Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.94
[64]
L. Althusser, La corrente sotterranea del materialismo
dell'incontro, in Sul materialismo aleatorio, Unicopli, 2000, p.93
[65]
Maurizio Guerri, L'infinito nella forma, in F. Nietzsche, La
teleologia a partire da Kant, Mimesis, 1998, p.43
[66]
J. W. Goethe, Faust II, Atto primo, 6246-6248