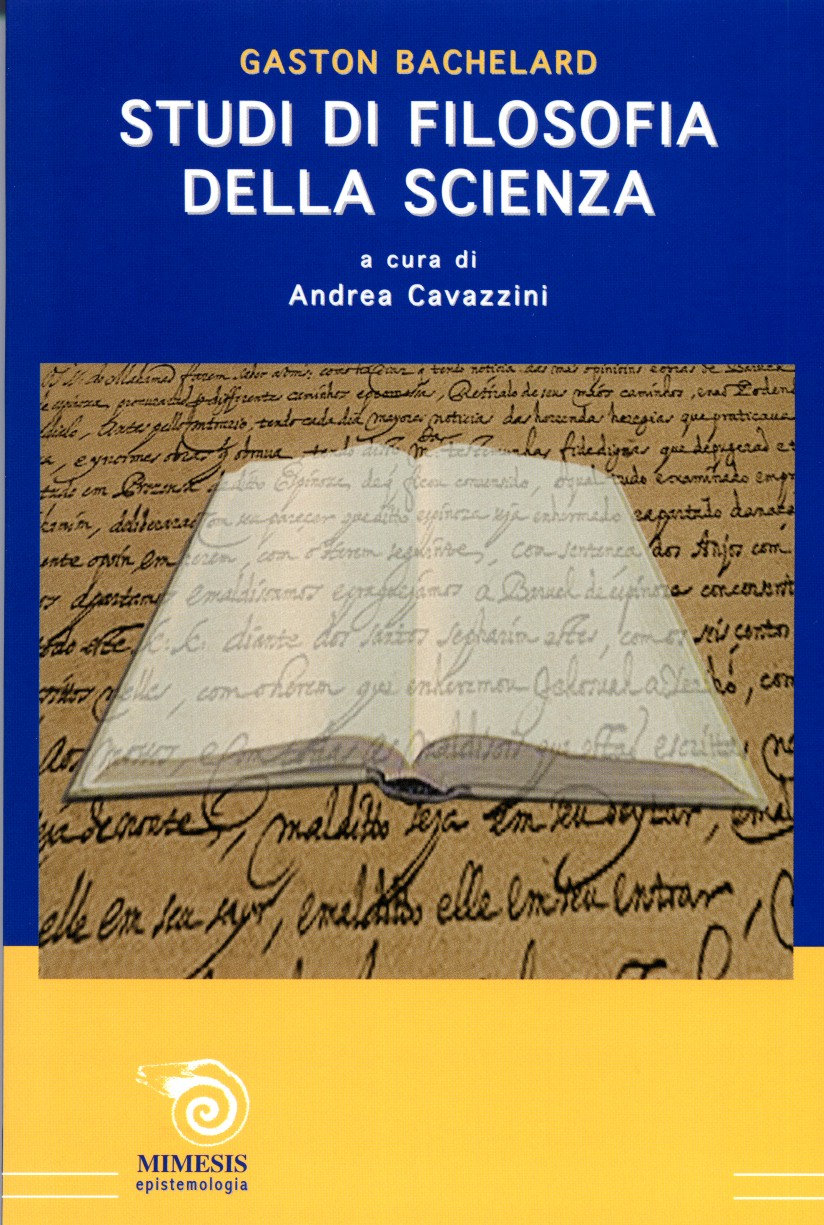
4
Gaston Bachelard
Studi di filosofia della scienza
MIMESIS, Milano 2006
a cura di Andrea Cavazzini
pp. 116 € 12 ISBN 88-8483-485-6
Il primo degli studi riuniti nella raccolta di Vrin introdotta da Georges Canguilhem risale al 1932, e l’ultimo è stato scritto nel 1935. I saggi mettono a fuoco, con una maggior perspicuità del consueto ed una maggior compenetrazione delle due “facce” dell’opera del filosofo, le tipiche tematiche bachelardiane: la reverie, il superamento dei complessi che l’immaginazione pone in guisa di ostacoli epistemologici allo sviluppo del pensiero, la crescente astrazione dall’immaginazione sensibile del pensiero discorsivo. In particolare, nell’ultimo saggio, Idealismo discorsivo, è affrontato (forse in polemica tacita con il pensiero husserliano) il tema della sostituzione dell’intuizione con la discorsività, ed è rifiutata ogni presupposizione di una datità pura all’origine del sapere: la distinzione delle idee, che si dà solo all’interno di una rete di nessi concettuali, si separa da e si contrappone all’evidenza immediata. Lo sviluppo del pensiero scientifico implica il costituirsi della scienza in un mondo, un mondo razionalizzato e astratto. Un altro importante tema è quello della relatività dei limiti della scienza: in realtà, non è possibile limitare apriori le possibilità delle scienze per far posto all’enigma, alla fede, o alla morale. I limiti di una problematica scientifica hanno senso solo all’interno della dialettica di approssimazione e rettificazione che governa lo sviluppo storico e normativo delle scienze. In genere, tutti questi studi focalizzano i temi centrali del pensiero bachelardiano sulla specificità del campo scientifico e sulla sua capacità di costituire, ad un tempo, le determinazioni del soggetto e dell’oggetto, della mente e del mondo.
Introduzione di Andrea Cavazzini