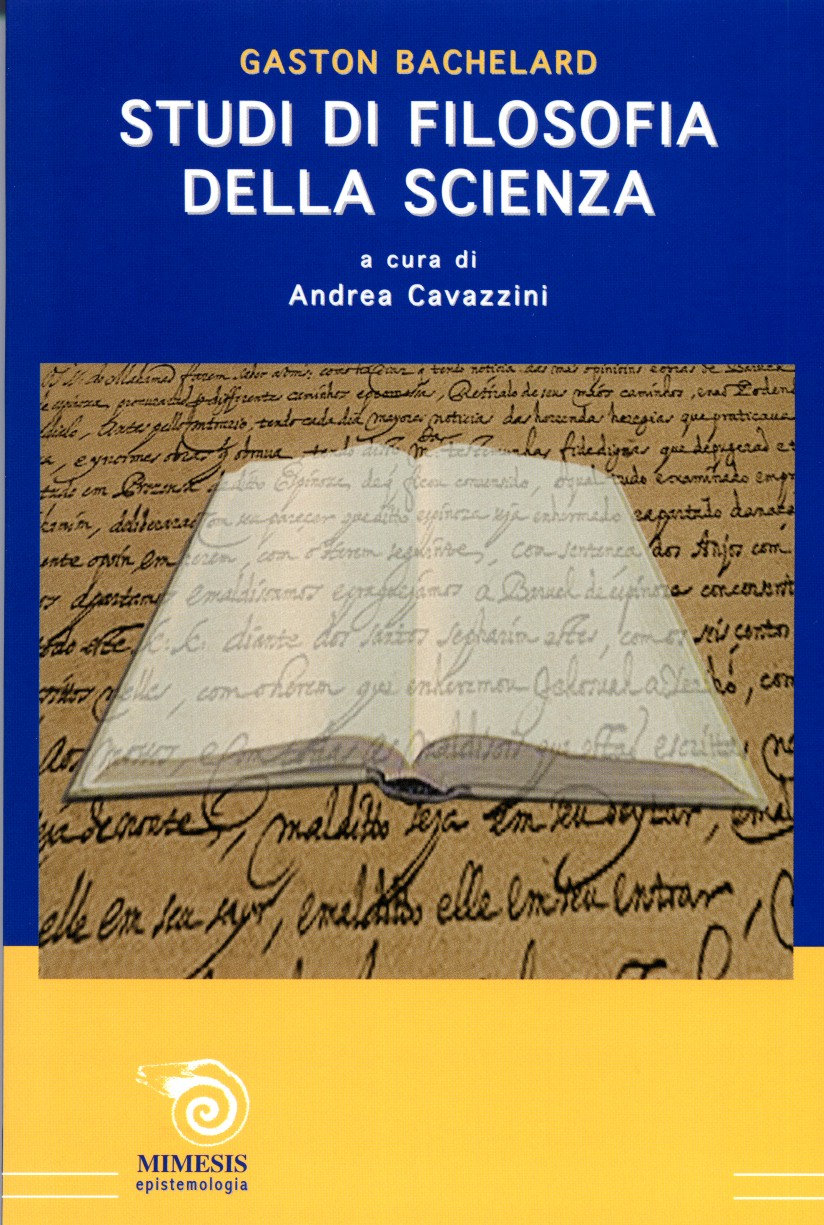
Studi di filosofia della scienza
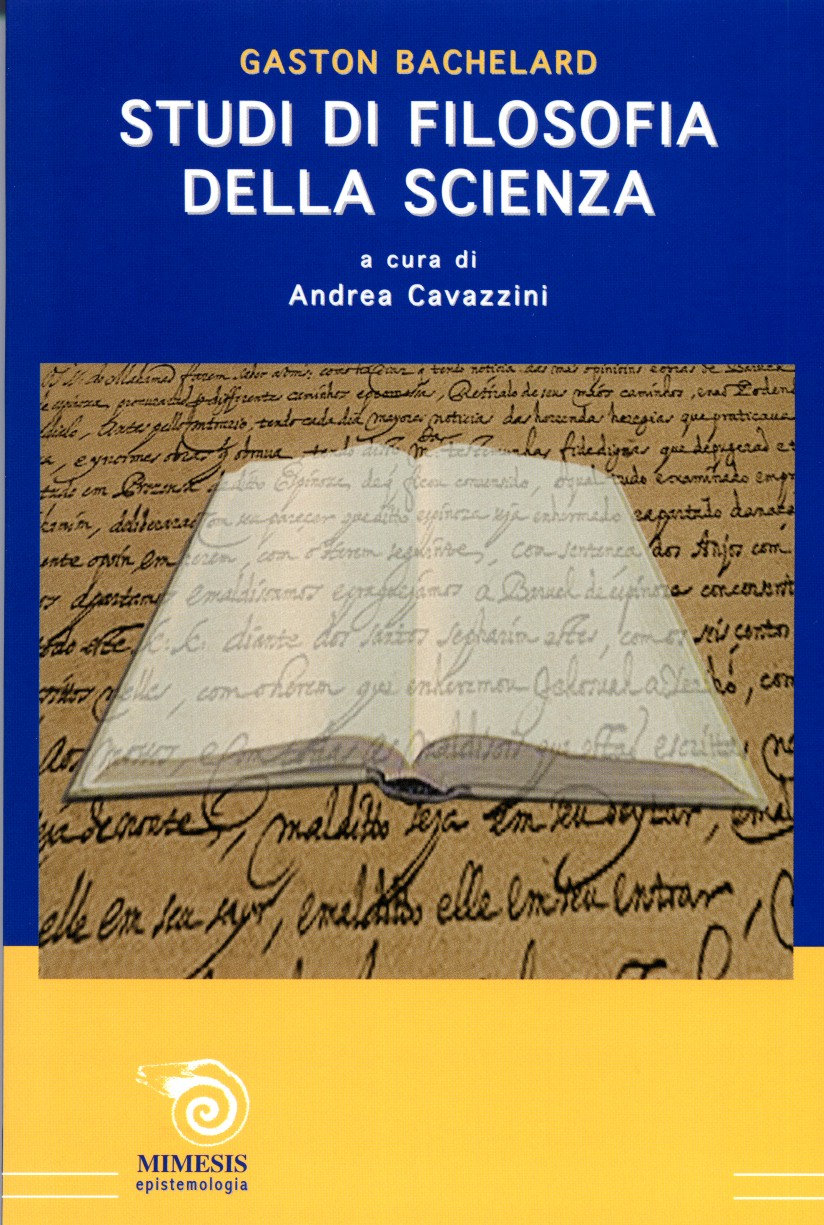 |
Gaston Bachelard Studi di filosofia della scienza |
Secondo Gaston Bachelard, lo sviluppo dello “spirito scientifico” moderno ha conseguenze decisive tanto sull’obiettivazione teoretica dei fenomeni quanto sul disciplinamento e la costituzione di una corrispondente soggettività. Tanto più esatto ed obiettivo è il pensiero rivolto alla determinazione del mondo esterno, tanto più consistente, razionale e organizzata sarà la mens del pensante. Tra questi due poli non c’è peraltro una reale separazione. La soggettività pensante è definita dal mondo pensato, così come – in virtù di una simmetria fondamentale che unisce obiettivazione e soggettivazione - quest’ultimo non può sussistere fuori dagli atti e delle procedure che lo restituiscono in un reticolo di pensieri. La genesi del soggetto e dell’oggetto, dell’essere e del pensiero, è contemporanea e simultanea. Si tratta, però, appunto di una genesi, di un divenire entro un processo bipolare, secondo un movimento produttivo la cui direzione, e i cui esiti, sono essenzialmente duplici - ma la portata di questo legame può venir colto solo qualora lo si rintracci nel divenire di questa costituzione bivalente: tale coappartenenza non è un dato statico, esiste solo in una storicità della conoscenza. In Idealismo discorsivo è svolta la tesi centrale dell’epistemologia “rettificativa” di Bachelard: le intuizioni primarie, l’origine, il punto di partenza del lavorìo obiettivante, sono sempre condizioni di incertezza e di non-verità, di opacità in cui non posso attribuire né coerenza al mio io né stabilità alla realtà: è solo il movimento di abbandono di questo stato a far emergere la certezza obiettiva e soggettiva[1]. Ciò cui si attribuisce la massima prossimità e dunque la suprema evidenza, è in effetti il luogo dell’assoluta distanza del sapere dalla verità, che solo nel corso di un processo possono tendere a coincidere. Il luogo iniziale, in cui ci si trova all’inizio, è precisamente il luogo che deve essere abbandonato: la conoscenza è la reiterazione di questi atti di abbandono, in cui il soggetto del sapere diviene certo di sé e del suo oggetto a misura che si allontana dalle posizioni in cui si trovava. La certezza è il correlato di una rottura, si diventa certi per negazione e per distruzione delle certezze antiche: idea paradossale che fa dell’evidenza un’attività, e che lega evidenza e distruzione, mentre è proprio l’opacità ad avere i caratteri statici della conferma affrettata e della permanenza. Se con “idealismo” Bachelard intende il ruolo attivo del pensiero nella costruzione della conoscenza, la “discorsività” significa che la conoscenza non è analisi o svolgimento di ciò che è dato originariamente all’intuizione, non è mai esplicitazione di ciò che sta già compiutamente nell’in sé dell’Inizio e dell’Origine, ma frutto di un atto, e quindi possiede uno spessore temporale, un’originalità che è quella di una separazione assoluta tra due condizioni, un ritmo peculiare che separa irriducibilmente il prima dal poi secondo un criterio di passaggio irreversibile dal meno al più di coerenza e di sapere certo. La “discorsività” si riferisce a questa impensabilità dell’atto di obiettivazione/soggettivazione aldifuori della sua temporalità interiore, in virtù della quale il prima del non-sapere è per sempre separato e abbandonato dal poi dell’esattezza. Il discrimine è tra il punto di vista che vuole cogliere la certezza nella simultaneità di un’Origine pura, e quello che non conosce certezze se non come risultato di un atto, dunque di una storia, per cui la certezza sia inseparabile dalla temporalità del divenire-certo. La discorsività si oppone all’immediatezza dell’origine. Il risultato del processo conoscitivo, l’esito dell’abbandono delle prime intuizioni, incorpora la dimensione temporale della propria genesi a partire dallo strato di ciò che la conoscenza ha abbandonato per sempre.
La polemica contro l’immediatismo, e la parallela valorizzazione della costruzione della certezza, quindi della densità temporale e produttiva di tale costruzione, sono un topos bachelardiano. Ma il contrasto tra intuizione e costruzione può essere facilmente equivocato. Per capirne le implicazioni, è forse opportuno tentare un confronto tra queste tesi bachelardiane e la fenomenologia di Husserl. Molte formulazioni contenute nel saggio citato possono infatti apparire come attacchi all’approccio fenomenologico. Nel 1931 compaiono presso Armand Colin le Méditations Cartésiennes, in una traduzione cui ha lavorato Lévinas e rivista da Alexandre Koyré, direttore delle Recherches Philosophiques, ove apparirà Idéalisme discursif. Si potrebbe ipotizzare che questo saggio bachelardiano configuri un confronto critico da parte di Bachelard con la filosofia da poco introdotta in Francia dal suo ospite. In questo caso, qui ci troveremmo di fronte alla principale disamina bachelardiana nei confronti del pensiero di Husserl, che è facile cercare dove in effetti non si trova. La stessa nozione di “fenomenologia” opposta talvolta da Bachelard a quella di “fenomenotecnica” non va intesa, o almeno non principalmente, sebbene si possano dare sovrapposizioni, come fenomenologia husserliana. Essa infatti è semplicemente la presunta ricognizione passiva dei dati empirici in quanto “fenomeni naturali” offerti ad un’osservazione impregiudicata, cui Bachelard contrappone la costruzione attiva di tutte le risultanze sperimentali. Non si tratta di un metodo filosofico generale, volto a fondare una teoria della ragione, ma di un settore della filosofia delle scienze naturali. La polemica contro una concezione intuizionistica del pensiero e della conoscenza, cui viene solitamente ridotta la fenomenologia di Husserl, sarà invece contenuta in questo saggio, ove il termine “fenomenologia” non compare. L’equivoco tra i due sensi di fenomenologia non è dissipato nemmeno da un libro recente: Bachelard critique de Husserl di Bernard Barsotti[2].
Ciò detto, sul piano della struttura filosofica (e perfino della valutazione dell’antecedente storico di Descartes), l’opposizione sembra netta e determinata. Al progetto husserliano pare centrale infatti l’idea che la sfera dei vissuti immanenti della coscienza costituisca il suolo dell’evidenza indubitabile e primaria, della certezza precedente ogni operazione intellettuale ed ogni prestazione teoretica. La negazione bachelardiana di questa tesi è puntuale: il terreno del primario e dell’iniziale è sempre il terreno dell’errore. La certezza di essere nel vero è sempre un suolo conquistato a fatica al termine di un’attività, mai uno stato guadagnabile da un ripiegamento sull’intimità a sé del pensiero[3]. Limitandomi a prendere in se stessi i vissuti, come mi sono intuitivamente dati in modo puro, non vivo nella certezza: al contrario, trovo solo brandelli incoerenti e fugaci di impressioni, di rapporti affettivi con le cose, trovo l’opacità del vissuto, e nessuna struttura intelligibile a reggere il pensiero o la realtà. Dunque, l’evidenza iniziale è il non-pensiero, la non-verità: è un’evidenza accontentarsi della quale significa rinunciare alla riflessione. Bachelard nega anche che noi possiamo intuire la nostra identità in un atto semplice ed immediato. Anche l’identità personale è dubbia sul piano delle intuizioni iniziali. L’inizio non è mai autentico, è solo incoerente – l’autenticità sta nel suo oltrepassamento polemico. Un altro punctum dolens fenomenologico è lo statuto dell’intuizione eidetica. L’intuizione di un’“idea”, di un’unità intelligibile data immediatamente ed interamente nella propria autoidentità, appare a Bachelard un’altra chimera. L’identità di un concetto è anch’essa risultato di un processo di complicazione: si sa cosa è e cosa significa un’unità intelligibile solo allorché la si è posta in una relazione onnilaterale con tutti gli altri concetti di un campo teorico, quando si è fatta la prova delle sue virtualità intelligibili. Senza applicazione, sviluppo, trasformazione, messa alla prova, correlazione, in breve, senza uscire da sé, nessun’idea può significare realmente una conoscenza: la conoscenza di cui un concetto è capace è immanente ed identica a questo processo di espansione e coordinazione del concetto stesso – e la conoscenza che un concetto può produrre coincide con la sua unità e identità[4].
La complicazione costitutiva dei concetti contro l’intuizione delle essenze – la costruzione storica del sapere contro l’intuizione diretta dell’evidenza intima: tutto ciò sembra separare definitivamente Bachelard dalla prospettiva husserliana. Ma tanto la monoliticità delle essenze quanto la trasparenza ed autosufficienza dell’intuizione dei vissuti coscienziali sono aspetti che non esauriscono l’orizzonte fenomenologico. Un momento di complicazione, di mediatezza costitutiva, si ritrova nell’intuizione dei vissuti e delle idee. L’analisi dei vissuti immediati trapassa in quella del flusso temporale come forma di tutte le relazioni che complicano e compromettono già-da-sempre ogni presunto dato immediato: ciò che propriamente viene tematizzato come strato originario non è più un dato autosufficiente, ma una trama di relazioni mai del tutto presentificabile, in virtù della quale ogni presunto “dato” riceve il proprio senso dall’intorno di datità parziali che costituiscono il mondo cui appartiene. Ed è questo “gioco” di luci ed ombre ad individuare l’oggetto cui i vissuti si riferiscono intenzionalmente. Spiega Enzo Melandri: «Ogni percezione ha un suo oggetto, o meglio: ogni percezione “si riferisce a”, “prende di mira”, “intenziona” un oggetto (…) Come “polo trascendente di identificazione”, questo oggetto ha la paradossale proprietà di rimanere lo “stesso e medesimo” per tutti gli atti percettivi parziali diretti a coglierlo e a constatarlo. Ciascuno di questi atti apprensivi, che insieme coordinati e unitariamente fusi costituiscono la percezione globale dell’oggetto, coglie uno solo dei suoi infiniti aspetti. Qualsiasi cosa possa dirsi “trascendente”, è chiaro infatti che non può mai esser totalmente data in un solo atto apprensivo. Questo non può che cogliere una sola delle infinite prospettive di cui quella è capace»[5]. L’oggetto non è mai esauribile da un’intuizione immediata e totale - è una totalità inesauribile di relazioni il cui significato complessivo può venir attinto solo “percorrendo” col pensiero i differenti fasci di tali relazioni costitutive: l’intuizione husserliana appare come una sorta di intuizione discorsiva, cioè strutturalmente complicata, non data d’émblée all’intelligenza, ma lungo le cui articolazioni questa deve dis-correre. Tra le relazioni costitutive di ogni ente c’è l’appartenenza al flusso temporale irreversibile che costituisce l’oggetto di tante analisi husserliane. Anche questa problematica va in direzione di una complicazione originaria del dato: “L’importanza delle ricerche fenomenologiche sul tempo risiede nella possibilità cui esse danno adito di tematizzare proprio quel presupposto temporale che, sebbene in maniera anonima, passiva e semiconsapevole, è tuttavia sempre implicitamente contenuto in ogni sensazione, anche se atomisticamente concepita. La critica fenomenologica diventa decisiva perché mostra come già al livello infimo del cosiddetto dato “puro” sussistano proprietà relazionali e strutturali determinabili analiticamente. L’analisi fenomenologica dimostra poi l’impossibilità di una riduzione meramente estetica e con ciò la vanità di ogni tentativo di isolare un’esperienza estraendola dal contesto. Non c’è una sola esperienza concreta che possa dirsi a rigore indipendente. Nel momento in cui viene vissuta, essa acquisisce necessariamente un’attualità temporale. Ciò significa che, anche se più tardi potrà esser considerata atomisticamente, in tale esperienza è già implicito tutto l’orizzonte trascendentale del tempo”[6]. Poiché ogni oggetto è strutturato dal proprio esser-parte di un campo tematico, risultando mediato da quest’ultimo, l’immediatismo husserliano sembra allora essere solo una lectio facilior. Lo stesso si potrà dire dell’imbarazzante cosalità dell’essenza? In effetti, il problema di capire cosa sia l’eidos husserliano e come possa venire adeguatamente interpretato è un problema annoso. La critica di Bachelard alla monoliticità e semplicità originaria delle essenze intuitivamente date colpisce il Wesen fenomenologico solo qualora se ne dia una lettura, scontata, in termini “aristotelici”; cioè qualora lo si concepisca sostanzialisticamente, come un oggetto “tutto d’un pezzo”, stabile, permanente, circoscritto, la cui accessibilità all’intuizione diretta si radicherebbe nella propria semplicità ontologica. L’essenza di cui parla Husserl può essere meglio interpretata “platonicamente”, come una relazione dinamica di strutture intelligibili, come un sistema di relazioni razionali, la cui evidenza non può essere disgiunta dal sistema delle connessioni che legano sistematicamente ogni unità ideale a tutte le altre. L’intuibilità di una simile “essenza” allora cambierebbe statuto. Innanzitutto, l’intellezione avrebbe una natura sistematica, e, quindi, discorsiva: intuire un’essenza non significherebbe più possederla nella sua immediata completezza, ma equivarrebbe al fatto di coglierne i legami con un campo teorico, con uno o più sistemi di metodi, leggi, problematiche. L’intuizione, in un contesto discorsivo, dovrebbe essere compresa per contrasto con la riduzione del pensiero matematico a manipolazione regolata di simboli stipulati convenzionalmente. L’intuizione eidetica rimanda, non tanto ad un immediatismo ingenuo, o ad un sostanzialismo metafisico, ma alla possibilità per l’intelletto di inserire i contenuti intelligibili in una struttura razionale, cioè all’esistenza di un contenuto razionale proprio della matematica, o in genere del pensiero esatto, di contro ad una sua riduzione pragmatica a mero simbolismo convenzionale. La simbolicità del pensiero razionale non è una semplice comodità: i rapporti tra i simboli strutturano i rapporti tra i concetti, è il simbolismo a manifestare l’unità del campo teoretico. Quindi, il simbolismo manifesta una necessità razionale, non una convenzione a scopi pragmatici, e l’uso dei simboli coincide con l’intuire un contenuto intelligibile vincolante. Nel libro husserliano, Melandri prospettava questa lettura: “In sé il Wesen non è in Husserl un concetto descrittivo, ma operativo. L’essenza non è una rappresentazione statica, ma un complesso dinamico di relazioni. Essa si potrebbe definire come l’operazione attraverso cui il dato empirico viene pensato come oggetto sub specie universalis, ovvero sussunto al concetto”[7]. L’intuizione dell’essenza è semplicemente l’operazione –non intuitiva, ma metodica e pratica – mediante la quale le relazioni vengono assunte come contenuti. E le relazioni non sono altro che la struttura, o il “reticolo”, intelligibile mediante cui “le cose” sono pensate. L’essenza dunque non è altro che la forma intelligibile che consente ad un “fatto” di essere un “fatto scientifico”, cioè ideale e razionale, una forma portata in se stessa a tematizzazione. E sappiamo già come questa forma sia “compromessa” dalla totalità delle relazioni che le conferiscono l’attributo intrinseco della mondanità o orizzontità. Successivamente, Melandri ha ricordato come appunto nelle oggettualità matematiche si possa trovare l’esempio più perspicuo di applicazione dell’intuizione dell’essenza: “Noi possiamo intuire in maniera cieca, rivolta al caso individuale, che 2+1=1+2, ma siamo anche in grado di capire perché la cosa stia così e non altrimenti. Questa è l’evidenza apodittica, che si adempie non nell’intuizione dell’individuale, ma nella comprensione dell’essenza e cioè della necessità e universalità del senso corrispondente”1. L’intuizione eidetica, se riferita ad un simile correlato, non può essere un accesso immediato e puntuale all’oggetto, ma piuttosto una conoscenza di esso discorsiva e strutturata, una penetrazione razionale in una struttura espressa nelle relazioni tra simboli. Questa conoscenza di una relazione ideale è conoscenza di una necessità razionale immanente a tale relazione: ed è questa comprensione determinata del contenuto intelligibile ad essere “offerta” nell’intuizione delle essenze. È chiaro dunque che essa non ha nulla di immediatistico, e che non vi è in essa, se letta in questo modo, nulla di contraddittorio con il principio dell’intellezione discorsiva delle oggettualità ideali. Come il vissuto fenomenologico è privo di significato se considerato al di fuori della sua complicazione temporale, allo stesso modo l’essenza fenomenologica è priva di significato se intesa al di fuori della sua natura discorsiva e strutturata. Non diversamente per Bachelard la verità è sempre temporalizzata, in quanto non può esistere verità se non come rettificazione, come rottura con posizioni precedenti riconosciute erronee, e ciò implica che l’atto rettificativo sia sempre temporalmente complicato, ritenendo il passato con cui si è operata la cesura, e protendendosi nell’anticipazione di nuovo sapere. Analogamente, l’aspetto oggettivo della verità è costituito da una trama di contenuti ideali, la cui intelligibilità è data nelle relazioni necessarie che ne compongono la struttura. Per Husserl ogni ente, per Bachelard ogni verità scientifica, possiede senso solo in base alla sua posizione in un sistema ed in un divenire orientato, in una struttura ed in un processo. Ma queste due prospettive possono tanto meglio convergere se si considera che nell’orizzonte delle analisi fenomenologiche un ente non è una cosa fisica-reale, ma un costrutto intenzionale, un significato, una pura struttura di senso che determina i “casi” reali ad essa sussunti. Perciò il modello di ogni ente è l’oggetto matematico, che esiste solo come puro significato ripetibile nella molteplicità di “casi” delle sue occorrenze. Ciò che identifica un ente matematico sono i suoi rapporti con l’insieme del campo del sapere matematico e la storia delle trasformazioni di questi rapporti. Quindi, l’oggetto matematico è interamente tempo e relazione. Ma è dai rapporti col campo matematico e dalla rielaborazione di questi rapporti che un entità matematica viene verificata, cioè perde il carattere di mera possibilità ideale per diventare teoreticamente produttiva, per diventare una verità. Se le condizioni di identificazione di un oggetto matematico coincidono con le sue condizioni di verificazione, allora l’ente matematico è essenzialmente una verità. È quindi la verità la condizione dell’entità, dell’apparire di un ente – e ciò coincide con la tesi bachelardiana per cui ogni fenomeno è un apparire prodotto teoricamente. L’opera di Bachelard potrebbe allora rappresentare una depurazione estrema della fenomenologia da ogni tentazione psicologistica in favore di una fenomenologia della costituzione dell’obiettività. Si noti che l’idealismo bachelardiano – la tesi dell’identità tra ente e significato – subisce una curvatura decisamente attivistica. Dire che una nozione è individuata dalla storia delle relazioni in cui è inserita significa che la sua identificazione dipende da quegli atti e da quelle pratiche teoriche che tali relazioni costituiscono e trasformano incessantemente. L’oggetto ideale riceve la propria identità dal lavoro infinito che la pratica scientifica esercita su di esso – poiché è questo lavoro che rende verità una nozione, si dirà che la verificazione, coincidente a sua volta con l’identificazione, è un’attività infinita. Quindi, l’obiettivazione di un ente ideale dipende essenzialmente da una pratica, dalla sua intenzionalità e tendenziosità – non è un oggetto, ma il correlato di un’attività finalistica. Lo stesso però vale nell’approccio fenomenologico, già nelle sue origini brentaniane. La “psicologia” di Brentano era chiamata all’esterno della sua scuola “psicologia dell’atto”, in opposizione alla psicologia dell’Erlebnis di Wundt, che riduceva il contenuto psichico ad un fatto, cioè ad una cosa intesa sostanzialisticamente, data passivamente ad una “coscienza” altrettanto poco problematizzata. Brentano invece concepisce il fenomeno psichico come un atto, dunque come dotato di una tendenza, di un “punto di vista”, in breve, di un ruolo produttivo nella costituzione del significato. Ciò è espresso in termini di grammatica speculativa dal fatto che il contenuto di coscienza di Wundt corrisponde al sostantivo, ed è pertanto oggetto di un indice di reificazione, mentre il fenomeno psichico di Brentano si esprime con un verbo transitivo: vedere, sentire, volere, ecc[8]. Ciò significa che è impossibile eliminare dalla dimensione ideale, “psichica” nel linguaggio di Brentano, l’attività: il significato, di cui constano i fenomeni ideali, è sempre il correlato di un atto, quindi di un fare, di un produrre, e di una finalità implicita, cui essi devono appunto il proprio specifico significato. Altrettanto vale per l’intenzionalità husserliana – anzi, tanto più quanto più lo psicologismo brentaniano ha lasciato il posto ad una tematizzazione diretta delle entità ideali logico-matematiche come correlati di atti intenzionali. Insomma, tanto per Bachelard che per Husserl le formazioni ideali non possono venire rappresentate o intuite alla stregua di cose, perché dipendono dalla vis performativa di un atto che le costituisce: e non è difficile vedere come sia appunto a tale atto che si ricollega la necessaria compromissione cosmologica e temporale delle entità ideali.
Bachelard e Husserl sembrano separarsi radicalmente sulla concezione del tempo, la cui essenza è il flusso continuo per il filosofo tedesco, mentre per il francese è l’istantaneità di un presente assoluto. Jean-Michel Salanskis afferma che per Husserl il flusso dei vissuti è un «tessuto, ciò che significa che i vissuti intrattengono relazioni non indifferenti, caratteristiche del flusso. La designazione il flusso, con l’articolo determinativo, evoca il collettivo dei vissuti nella sua totalità (…) Husserl (…) descrive dunque la sintesi della totalità del flusso come qualcosa che si opera (…) secondo due principi (…): da un lato, ricondurre ad ogni parte del flusso le parti che (…) vi aderiscono nel fluire, cioè, in breve, la prossimità temporale della parte considerata; dall’altro, ogniqualvolta si sia “incluso” nel flusso un collettivo di vissuti, autorizzarsi a prendere in considerazione (…) come membro del flusso ogni parte di questo collettivo; appartiene dunque al flusso dei vissuti tutto ciò che può esserne estratto come parte nel senso più ampio, ciò che significa anche tutta la struttura del flusso, tutte le sue forme. Questi due principi di estensione (…) promettono una proliferazione all’infinito del flusso»[9]. Come si vede, qui Salanskis non fa altro che riformulare i due principi della complicazione temporale e della compromissione cosmologica, i due principi cioè della costituzione di ogni “sostanzalità” a partire da tempo e relazione, esplicitando il carattere “fluente” di questo quadro ontologico: «Husserl si richiama infatti ad una delle più antiche tradizioni del pensiero scientifico e filosofico per nominare (…) questa ricchezza illimitata, eccessiva, del flusso: egli dice – costantemente – che il flusso dei vissuti è continuo (…) che la molteplicità, sostrato e deposito del vivere nel suo fluire, deve essere intesa dalla fenomenologia come un continuo (…) il continuo del flusso dei vissuti, certamente, è un continuo aristotelico: qualcosa che è una virtualità capace di includere in sé ogni molteplicità concepibile, e che rifiuta di risolversi nell’aggregazione di attualità puntuali o nella concatenazione di parti attuali. I punti e le parti sono in effetti solamente virtuali, solamente marche possibili nel continuo e non i suoi elementi costitutivi isolabili e autentici»[10]. Il flusso è quindi un continuo, una totalità unitaria e indecomponibile, densa, in cui si mescolano e da cui emergono tutte le determinazioni. E questa totalità coincide con lo spessore temporale: «il tempo è il flusso e il flusso è il tempo per Husserl»[11]. Allora, se il tempo è questa continuità veramente abissale, come poter conciliare la temporalità husserliana con le tesi di Bachelard contenute in L’intuizione dell’istante? Quest’opera, che oppone la filosofia della durata di Bergson alla filosofia dell’istante di Gaston Roupnel (e di Bachelard stesso), è tutta dedicata all’illustrazione di un istante assoluto, anomalo, unico, e umbratile, sempre in corso di sparizione, ben diverso dalla compatta indissipabilità del flusso bergsoniano. E quest’ultimo viene criticato in termini che lo apparentano strettamente al flusso husserliano descritto da Salanskis: «Per Bergson, che cos’è l’istante? Non è altro che una cesura artificiale (…) l’intelligenza, nella sua inettitudine a seguire il vitale, immobilizza il tempo in un presente sempre fattizio. Questo presente, è un puro niente che non arriva nemmeno a separare realmente il passato e il futuro. Sembra in effetti che il passato porti le sue forze nell’avvenire, sembra anche che l’avvenire sia necessario per trovare uno sfogo alle forze del passato e che un solo ed unico slancio vitale solidarizzi la durata (…) la filosofia bergsoniana riunisce indissolubilmente il passato e l’avvenire. Bisogna pertanto prendere il tempo tutto in blocco per afferrarlo nella sua realtà. Il tempo è alla sorgente stessa dello slancio vitale (…) se l’istante è una falsa cesura, il passato e l’avvenire diventano molto difficili da distinguere poiché sono sempre separati artificialmente. Bisogna allora prendere la durata come un’unità indistruttibile. Da cui tutte le conseguenze della filosofia bergsoniana: in ognuno dei nostri atti, nel più infimo dei nostri gesti, si potrà dunque cogliere il carattere compiuto di ciò che è abbozzato, la fine nell’inizio, l’essere e tutto il suo divenire nello slancio del germe»[12]. La continuità della durata bergsoniana, che Bachelard rifiuta, è un’unità indifferenziata, un continuo privo di fasi, di sviluppo e di articolazioni. In essa, la fine è contenuta nell’inizio, e l’inizio non è che l’anticipazione della fine: alla fine, questa impossibilità di praticare differenze nella compattezza di un tutto omogeneo sempre-già-dato sfocia nella cancellazione stessa del tempo. Il tempo, il tempo dei mutamenti e degli eventi, non esiste per la durata, perché in essa non c’è che riconferma dell’identico. Un tempo realmente produttivo, segnato dalla discontinuità, non potrebbe che essere incentrato sull’assolutezza del presente: «Dopo aver trionfato provando l’irrealtà dell’istante, come potremo parlare dell’inizio di un atto? Quale potenza sovrannaturale, posta fuori della durata, avrà dunque il privilegio di marcare con un segno decisivo un’ora feconda che, per durare, deve innanzitutto cominciare? (…) Senza dubbio, a voler prendere la vita attraverso il suo ambiente, nella sua crescita (…) si ha l’occasione, con Bergson, di mostrare che le parole prima e dopo non hanno che un senso orientativo, perché tra il passato e il futuro si succede un’evoluzione che nel suo successo generale sembra continua. Ma se ci si porta nel dominio delle mutazioni brusche, in cui l’atto creatore si inscrive bruscamente, come non comprendere che un’era nuova si apre sempre con un assoluto? Ora, ogni evoluzione, nella misura in cui è decisiva, è puntuata da istanti creatori»[13]. Bachelard qui abbozza una teoria del tempo come innovazione: non c’è tempo se non dove si dà una discontinuità, un imprevisto, qualcosa che non può essere determinato dal passato, che, anche se trova in quest’ultimo le proprie condizioni di apparizione, non ha condizioni che non siano negative: la condizione costituita da un passato rifiutato, dimenticato, la cui legalità è per sempre assente dall’eterogeneità della nuova apparizione. Ma dove, in quale attività, possiamo trovare all’opera questo gesto nativo con cui una realtà originale conferisce a se stessa la norma del proprio sussistere abbandonando ogni dipendenza dal già-dato? Secondo Bachelard, il paradigma stesso di questa novità radicale è la conoscenza: «Questa conoscenza dell’istante creatore, dove la troveremo in modo più certo che nel sorgere della nostra coscienza? Non è forse là che lo slancio vitale è più attivo? Perché cercare di tornare a qualche potenza sorda (…) quando si svolgono sotto i nostri occhi, nel presente attivo, i mille casi della nostra propria cultura, i mille tentativi di rinnovarci e di crearci? Ritorniamo dunque al punto di partenza idealista, accettiamo di prendere per campo d’esperienza il nostro proprio spirito nel suo sforzo di conoscenza. La conoscenza è per eccellenza un’opera temporale (…)Lo spirito, nella sua opera di conoscenza, si presenta come una serie di istanti nettamente separati (…) Nel fondo di noi stessi, in cui la gratuità ha un senso così chiaro, noi non cogliamo la causalità che conferirebbe forza alla durata ed è un problema accademico e indiretto quello di cercare cause in uno spirito in cui non nascono che idee»[14]. Bachelard ritorce contro Bergson la polemica contro l’artificialismo: l’evidenza non è la durata, ma l’istante. Secondo Bachelard, l’istante ha l’evidenza conferitagli dalla natura temporale dell’esperienza. L’esperienza è temporale, dunque la durata non è esperita: è solo una costruzione. La durata non è esperienza perché non è tempo, e non è tempo perché in essa tutto è già dato, non può esistere novità, né mutamento. Il tempo si dà solo dove qualcosa di nuovo sorge: dunque l’esperienza della temporalità è esperienza dell’innovazione imprevista, o meglio, l’esperienza è temporale solo in quanto è esperienza di un sorgere originale. L’innovazione e l’imprevisto si dànno solo nell’istante, che è quindi la matrice del tempo. Ma l’innovazione e l’imprevisto, il sorgere di qualcosa che non è determinato dal passato, sono esperiti in un campo peculiare di esperienza: la conoscenza. Perché la conoscenza è così strettamente determinata da questa struttura dell’innovazione, dell’imprevisto e dell’istante? Perché ogni conoscenza è una presa di coscienza del non-sapere che essa dissipa; ogni conoscenza è apparizione di una nuova verità che si distacca da ciò che, in virtù di questa apparizione stessa, sarà dichiarato errore. La conoscenza è una successione di istanti, ed è riflettendo sull’esperienza della conoscenza che noi possiamo capire la natura dell’istante. L’istante è istante, cioè presente assoluto, perché è separato da un’eterogeneità qualitativa e invalicabile tra se stesso, il passato che non è più, da cui l’istante presente si è distaccato, e il futuro che è un Oltre inimmaginabile e impensabile. A differenza che per la durata di Bergson, in cui l’omogeneità dell’essere unisce il passato, il presente e il futuro, l’istante presente è separato dal passato e dal futuro in virtù dell’eterogeneità tra essere e non-essere. Il presente è assolutamente eterogeneo ai due non-essenti passato e futuro. Eppure, questa assoluta separazione è ancora una forma di condizionamento: il presente è ciò che è in quanto non-passato e non-futuro. Esso è ancora condizionato da passato e futuro, ma nel senso che questi due non-essenti, l’uno ormai del tutto caduto nell’oblio, l’altro ancora avvolto nell’inconcepibile, delimitano, come limiti puramente negativi, la positività del presente. È l’incomunicabilità ontologica tra passato, presente e futuro a chiudere il presente in se stesso, e, perciò, si può dire che questa incommensurabilità del presente al passato ed al futuro è ancora una forma di relazione, paradossale, tra essi. Ora, questa paradossalità è visibile nell’esperienza della conoscenza. Una conoscenza non può che essere un presente assoluto, in quanto sorge negando un passato (la non-conoscenza), e un futuro, per la quale sarà ciò che ora è presente a rappresentare un non-sapere, e, pertanto, sarà indeducibile dall’attuale presente quanto questo lo è per il proprio passato. Quindi, la conoscenza è un’originalità assoluta, un’innovazione, che sorge in una frattura assoluta: ma è appunto ciò che tale frattura separa assolutamente da essa a determinarla, circoscrivendone l’orizzonte positivo tra due negatività. L’errore passato determina la verità affermata nel presente, ma non in quanto ciò che permane, sopravvive e si perpetua in essa, bensì come ciò che essa ha abbandonato, con cui ha dovuto rompere per sorgere. Si può dire allora che l’istante è reso istante da una relazione con il passato e il futuro, che la sua autonomia e autosufficienza sono tali in virtù di una relazione ad altro nel modo della negatività assoluta di questo “altro”. In altri termini, l’esperienza della conoscenza ci rivela questo: l’istante ha in comune con la durata il fatto che non vi sia presente senza passato e futuro; ma è differente dalla durata in ciò, che il passato e il futuro sono sempre ontologicamente eterogenei rispetto al presente. L’esperienza temporale è condizionata da, e ci rivela, la struttura dell’imprevisto: è l’imprevisto la matrice genetica del tempo, cui abbiamo accesso nell’esperienza del conoscere. Per quanto ciò non sia immediatamente evidente, la struttura del tempo in Husserl è analoga a quella descritta da Bachelard, e non a quella bergsoniana. Anche per Husserl il tempo è organizzato da un primato del presente rispetto al quale passato e futuro non potranno mai ottenere uno statuto paritario di evidenza e di realtà. Il presente è delimitato dalle ritenzioni e dalle protensioni, ma esse non sono mai omogenee al presente: anche per Husserl, il presente originario, il presente impressionale, è certo “vivente”, perché deborda sul flusso, ma è anche assolutamente eterogeneo, in quanto punto sorgivo dell’evidenza, rispetto ai due infiniti del passato e del futuro. Allora, come si deve intendere la tesi per cui ogni “parte” del flusso è artificialmente separata dal continuo? Non certo nel senso bergsoniano, in base al quale il continuo della durata possiede un’omogeneità in cui nulla si disperde. Per Husserl il flusso è una dissipazione continua, un precipitare perpetuo del presente originario nel non-essere. Nessuna parte può essere isolata dal flusso perché ogni istante assoluto cade istantaneamente nel non-essere – ma appunto perciò il presente è assoluto, perché è di fatto introvabile ed inassegnabile all’interno dell’infinità delle datità inadeguate, date come protensioni o ritenzioni, e quindi eterogenee rispetto ad un presente istantaneo che, pur essendo l’unico essere autentico, non può trovare alcuna collocazione nella proliferazione illimitata del flusso. Il flusso è quindi il luogo della perdita perpetua di questo istante impressionale che è nondimeno l’unico essere, da cui tutto il flusso è generato e reso accessibile. Se Bachelard ci descrive un istante che è assoluto in quanto in relazione, Husserl parla di un presente che, in quanto comunica con passato e futuro, è anomalo e introvabile, atopos.
La paradossalità del presente husserliano – presente “impressionale” – è colto da Jean-Toussaint Desanti, il quale parla di un presente che «non sarebbe altro che la propria stessa e perpetua scomparsa (la sua fuga, o la sua caduta nel passato)»[15]. La scomparsa del presente si deve al fenomeno della ritenzione, che costituisce un tratto essenziale della struttura stessa dell’attualità temporale: «La “prima impressione” (il “dato originario”) si è ritenuta essa stessa per il fatto stesso di essersi manifestata (…) ad ogni impressione (“sensazione”) è associata una modificazione immediata che la costituisce in “appena passata”»[16]. La ritenzione è un fenomeno che inerisce a priori ad ogni impressione, il che significa: ad ogni impressione attuale, ad ogni presente, inerisce lo svanire, o meglio, l’esser-sempre-già svanito. D’altra parte, questo presente essenzialmente evanescente è la sorgente di tutto ciò che può esser dato: tutta l’esperienza è essenzialmente non-più-presente, ma al tempo stesso non può non originarsi dal presente “introvabile”. Desanti parte da queste considerazioni per esaminare lo statuto della «”cellula” elementare che si manifesta al cuore della costituzione della “coscienza intima del tempo”»[17]. Questa cellula è costituita dall’unità tra coscienza impressionale e coscienza ritenzionale, cioè dallo svanire necessario della prima nella seconda. Ma la coscienza impressionale è la sensazione, il dato sensibile bruto, che Husserl stesso definisce un prodotto originario, una novità. L’offrirsi originario del dato di sensazione come novità ha la peculiarità di essere estraneo alla coscienza: «Nessuna intenzionalità abita, per costituirla, il dato bruto della “sensazione”, e non può, di conseguenza, abitare il flusso dei dati di sensazione. Questo flusso (che Husserl chiama, in Idee I, flusso iletico) sembra autocostituirsi incessantemente come materiale sempre disponibile per gli atti (…) di una coscienza. Ma la sua costituzione intrinseca non esige alcuna intenzionalità. Ciò che Husserl chiama la “spontaneità della coscienza” non vi opera come momento produttivo»[18]. Il punto sorgivo di ogni cosa è quindi esterno alla coscienza, è costitutivamente spiazzato rispetto ad essa: «C’è dunque alcunché di “misterioso” nella “cellula originaria” (…) La coppia aa’ (a’designa la modificazione ritenzionale di a) unisce un momento di emergenza assoluta, a, estraneo ad ogni produzione di coscienza, ed un momento di spontaneità di coscienza a’ (…) il momento veramente originario sorge, sempre di nuovo, da una fonte di ricettività profondamente sommersa, e che nessun “atto” di coscienza ha costituito»[19]. Questa fonte, il “flusso”, è ciò che «non essendo propriamente “fenomeno”, costituisce tuttavia la fonte di apparizione di tutto ciò che l’esperienza manifesta a titolo di fenomeno». La ricerca fenomenologica mira a enucleare appunto ciò che si manifesta in modo primario, ciò che è dato ad un’esperienza in certo modo pura. Invece il fenomenologo trova che tutta l’esperienza, cioè tutto ciò che è dato come fenomeno ad una coscienza, sorge da un che di estraneo ed irriducibile alla coscienza, da qualcosa di non-fenomenico, che non si manifesta, che è per definizione altro dalla coscienza. Questo è l’esito del profondo scavo fenomenologico degli strati ultimi della coscienza. La cellula originaria dell’esperienza non data a quest’ultima, in quanto l’esperienza è temporale, è un presente istantaneo originario: ma Husserl la definisce anche come “novità”. Ciò che è estraneo alla coscienza lo è in quanto momento sorgivo di un nuovo, di un imprevisto, che si impone nella sua inaggirabilità insensata, cioè tale da non appartenere alle presupposizioni della coscienza. Secondo Desanti il flusso iletico, estraneo alla coscienza in quanto novum è una «legge apriori di costituzione della fonte di ogni esperienza, una legge di costituzione della manifestazione, per una coscienza in generale, di un mondo in generale»[20]. Ma allora tutto ciò che si dà come mondo, come sistema di connessioni nel flusso e nella totalità, presuppone un punto sorgivo esteriore alla propria logica immanente – il sistema si origina e si sostiene in virtù di un’anomalia. Per Husserl, si tratta del presente impressionale, per Bachelard si tratta dell’istante; sia l’uno che l’altro sono refrattari al senso, e, proprio perciò, per entrambi gli autori, questo punto di resistenza all’organizzazione del mondo e della coscienza costituisce una radicale novità, un eccesso sulla forma sistematica del tutto che connette gli enti e le verità. Sia per Husserl che per Bachelard il tempo e la relazione sono le strutture fondamentali di ogni datità, che non potrebbe essere pensata atomisticamente. Eppure, queste strutture non sono uno strato ultimo. Rimandano invece a qualcosa di più positivo, ad una matrice originaria: l’innovazione, l’istante, il presente impressionale. Questa matrice è anomala rispetto alle due strutture, è ad esse irriducibile ed anteriore: e proprio per questo è introvabile. Il presente assoluto genera delle strutture alla cui legalità non può poi sottrarsi, e sparisce in esse, pur non potendo queste essere che seconde rispetto alla sua originalità. Il pensiero, che è appunto tempo e relazione, sembra dunque emergere al di fuori di se stesso.
La struttura della sintesi temporale, il metodo della variazione eidetica, e quella che potremmo definire una lectio difficilior platonica (non-aristotelica) della Wesensschau attestano quindi che la certezza è sempre mediata, che l’evidenza è sempre il risultato di una complicazione originaria. In effetti, tutti questi fenomeni possono essere rubricati sotto un fatto fondamentale, che Melandri chiamava “la compromissione cosmologica del pensiero”. Ogni conoscenza implica un “mondo”, cioè un campo articolato di relazioni che si sviluppa secondo una logica: l’evidenza e la distinzione di un concetto non preesistono all’esplicitazione metodica delle sue possibilità produttive; e la coerenza di una soggettività trascendentale non preesiste alla temporalità qualitativamente determinata del suo processo di sviluppo. Ciò, lo si è visto, può essere detto anche per la struttura della conoscenza scientifica analizzata da Bachelard: ogni conoscenza implica la temporalità irreversibile della rettificazione, ed una rete di intelligibili accessibile a quella che si potrebbe definire, trasgredendo il Verbot kantiano, un’intuizione discorsiva. Queste analogie tra Bachelard e l’ottica fenomenologica possono fungere da indizi per approfondire la stessa posizione bachelardiana: ciò è quantomeno plausibile per quanto riguarda la funzione teoretica della compromissione cosmologica, che, attraverso il significato da essa assunto nell’opera di Husserl, può illuminare alcuni aspetti non ovvi della filosofia di Bachelard stesso. Per Husserl, ciò che dell’Ego e dell’Eidos rimanda costitutivamente ad un mondo è anche ciò che resiste alla riduzione fenomenologica – la messa in parentesi dell’atteggiamento naturale ha successo nel neutralizzare le teorie deduttive e le presunzioni di causalità, ma non può mai neutralizzare la fatticità dell’esistenza, dell’essere-nel-mondo. Il mondo, cioè l’insieme strutturato – anche se non necessariamente coerente – delle relazioni e della temporalità costitutiva di ogni fenomeno, è la matrice di ogni cosa, e come tale continua ad intaccare l’epoché. Quest’ultima dovrebbe schiudere il campo puro della coscienza, ma esso, lo sappiamo, è condizionato, nel punto sorgivo del presente impressionale, dalla pura presenzialità di un mondo trascendente ogni coscienza: il mondo è sempre-già dato ad un livello preintenzionale, prima cioè che l’intenzionalità lo costituisca secondo le proprie leggi strutturali. Abbiamo visto che il tempo e la relazione quali compaiono nell’orizzonte di indagine fenomenologico hanno dei corrispettivi nelle vedute di Bachelard. Ciò vale anche per la messa in parentesi. Il progresso temporale della rettificazione, e la complicazione sperimentale-teorica dei concetti, sono caratteri costitutivi di ciò che resta dopo la “messa in parentesi”. C’è un’epoché bachelardiana, in cui le scienze stesse sono messe tra parentesi quanto ai loro risultati, alle situazioni raggiunte dalle loro indagini, ai loro metodi e concetti. Bachelard vuole portare alla luce il come avvenga, in generale, che la scienza progredisca e si apra nuove prospettive. Per questo, le analisi bachelardiane dedicate alle ultime scoperte, alle ipotesi più innovative, sono in realtà studi condotti su paradigmi, cui si demanda il compito di consentire l’accesso alla genesi del progresso scientifico, delle rotture che lo scandiscono e delle novità che lo costituiscono. Per accedere alle strutture portanti del formarsi dello spirito scientifico è necessario sospendere la validità ingenuamente assunta dei metodi, del corpus delle conoscenze, e delle verità, tenuti per validi in una congiuntura determinata delle scienze alfine di cogliere il mutamento di un campo teorico come puro evento. Ciò che resta dopo la messa in parentesi delle verità date nelle scienze è una pura forma. In modo non dissimile, Husserl ha ritenuto di trovare la pura immanenza della coscienza al termine del processo di riduzione. Ma, come la coscienza pura husserliana implica sempre-già un mondo di contenuti che sorgono a monte della coscienza nell’anomalia del presente impressionale, la forma pura del divenire della scienza implica sempre un’impurità che è la sorgente anomala e irriducibile di questo divenire. Abbiamo visto come il tempo irreversibile della rettificazione e il riferimento ad una totalità di concetti siano i due caratteri irriducibili che ritroviamo al fondo di ogni verità scientifica epochizzata: la relazione tra concetti, ed il tempo in cui queste relazioni vengono stabilite e ristrutturate indefinitamente. Si tratta già di qualcosa che eccede la pura forma: il tempo è determinato secondo lo scarto tra il terminus a quo e il terminus ad quem, secondo quell’interim tra prima e poi che è aperto dall’atto del prender-coscienza, e la relazione secondo i rapporti effettivi tra i concetti, rapporti che costituiscono la verità scientifica affermata dall’atto istantaneo. Entrambi questi parametri formali sono impensabili senza presupporre determinatezze contenutistiche, senza la densità dei contenuti reali del mutamento intellettuale. Ma non è tutto. Il tempo e la relazione si costituiscono a partire da quella dimensione più riposta che li connette reciprocamente, e che in realtà produce la genesi di entrambi: si può dire, forzando un po’ la lettera, che, se per Husserl questa dimensione è quella del presente impressionale, per Bachelard è invece la dimensione del giudizio, in quanto attività produttrice delle formazioni di pensiero.[21] Il giudizio è l’affermazione di una relazione ideale: E = mc², oppure: La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull’ipotenusa. È quindi il giudizio a istituire le relazioni tra nozioni che rendono queste ultime delle verità teoriche, e pertanto è sempre il giudizio a costituire le relazioni interne ad un campo teorico.
È quindi il giudizio quell’atto alla cui vis si demanda di render ragione dell’identificazione degli enti ideali. Ma questo atto costitutivo ha una natura temporalizzata: il giudizio istituisce una verità separando irreversibilmente il prima dal poi – l’affermazione di una relazione ideale è sempre un risveglio, una rettificazione, la nascita del pensiero ad un nuovo orizzonte di significati, l’apertura di nuove strutture delle entità ideali. È quindi il giudizio il dispositivo che genera le entità razionali obiettive, in quanto in esso coincidono il tempo della rettifica e la struttura della relazione: le verità sono sedimenti di giudizi. Il giudizio è quel presente assoluto della conoscenza tematizzato dall’Intuizione dell’istante, quel momento sorgivo produttore di essere, ma contemporaneamente tanto umbratile da ricadere immediatamente nell’indifferenza della continuità. La posizione di una relazione si riassorbe nella relazione stessa: l’atto irriducibile di affermare una verità razionale si occulta istantaneamente nell’architettura obiettiva dei concetti, che, pur esibendo relazioni costitutive che hanno dovuto esser poste, non conservano tracce, nella propria legalità immanente, di questo atto di posizione. La radicale novità dell’istante presente in cui il giudizio pone una verità è, simmetricamente, riassorbita dalla continuità del tempo, da una storia lineare delle scoperte e delle rettificazioni: l’assoluta anomalia della rottura, operata dall’affermazione di una verità, con le proprie premesse è occultata nella storia di una progressiva razionalizzazione. L’attuosità di questa affermazione è un presente assoluto che non ha più posto nelle strutture che ha prodotto. Il giudizio è quindi per il “mondo” delle verità ciò che il presente impressionale è per il “mondo” degli enti– il punto sorgivo di una logica immanente che fuorclude la propria scaturigine, rendendo le idee meri oggetti immemori della propria genesi.
La tematizzazione del giudizio come cellula germinale della razionalità amplia ulteriormente il significato della compromissione cosmologica. Se lo strato risultante dalla riduzione operata sulle verità scientifiche – lo strato del tempo e della relazione – si rivelava sempre contenutisticamente determinato da contenuti effettivi, lo strato ulteriore del giudizio, ottenuto dalla riduzione di tempo e relazione, rivela anch’esso l’inseparabilità delle sue strutture formali da un “mondo” di determinazioni concrete. La forma del tempo è impensabile senza la materia di un divenire irreversibile; la forma della relazione è impensabile senza la materia dei contenuti relati; e di nuovo queste forme sono impensabili senza l’attuosità del giudizio che le istituisce scandendo cesure nella temporalità densa della storia della teoria e riorganizzandone le relazioni seguendo la teleologia di un compito infinito di verificazione. Non diversamente, la forma del giudizio come atto temporale che afferma il sussistere di relazioni è impensabile senza una “materia” ad esso peculiare. Anche l’atto del giudicare è una forma che implica un mondo di contenuti irriducibili. In cosa consiste la hyle della forma-giudizio? In prima approssimazione, possiamo dire che consiste in ciò che Weber e i Neokantiani chiamerebbero una Wertbeziehung. Non c’è giudizio senza riferimento ad un sistema di valori – è la tendenziosità, o il finalismo, dell’atto di cui abbiamo già parlato. Alle radici di questa considerazione sta l’idea che il giudizio costitutivo della razionalità scientifica sia, almeno in parte, una costruzione, e non il rispecchiamento di dati di fatto. Il giudizio è la radice delle scienze, non in quanto riproduce relazioni già date, ma in quanto produce relazioni e ne costituisce la necessità e universalità razionali. Ora, questa produzione, come ogni produzione, possiede, lo abbiamo detto, una valenza teleologica: un produrre è sempre intelligibile a partire dal proprio telos, che, si badi, non è tanto il prodotto finito, quanto il fine cui si mira nel produrlo, o l’impulso che questo produrre deve soddisfare, il cui significato è espresso dal prodotto e dal processo produttivo. In altri termini, un produrre è sempre un esprimere: l’attuazione di un prodotto è sempre espressione di un significato immanente all’attuazione stessa. Il giudizio esprime un rapporto ad un sistema di valori; ed un giudizio scientifico esprime il rapporto con valori razionali. Da qui, l’insistente tesi bachelardiana: il progresso della scienza è scandito dall’opposizione di valori razionali a valori affettivi, immediatistici, sostanziali, ecc. Questi valori regolano i giudizi che, nel corso della storia delle scienze, destrutturano e ristrutturano il quadro di queste ultime secondo la logica di una posizione di valori. E questa posizione è sempre un’op-posizione, una contrap-posizione: i valori sono sempre legati da un vincolo polemico, non esiste valore se non nella sua affermazione contro un dis-valore – così, per Bachelard, non esiste verità senza rifiuto degli errori precedenti, non esiste razionalità senza lotta contro i valori non-razionali che la ostacolano. Non esiste giudizio che non sia affermazione di valori, e quindi che non sia lotta contro valori contrari. Il soggetto giudicante è quindi un soggetto assiologico, valorizzante, e per questo polemico: in ciò sta l’intenzionalità, e dunque la tendenziosità, degli atti da cui l’obiettività delle scienze è istituita. La pura razionalità si può affermare solo contro il non-razionale, cioè come valore, dunque in maniera radicalmente impura – tramite la lotta contro il proprio contrario. È questa polemicità intrinseca ad ogni rapporto al valore ciò che non può essere cancellato dalla forma-giudizio: la “materia” irriducibile del giudizio è quindi la determinatezza del conflitto tra diverse istanze portatrici di diversi ordini assiologici, conflitto in cui ogni giudizio prende posizione, e da cui, attraverso tale presa di posizione, è determinato nell’esser-così della propria struttura e dei propri effetti. Il mondo con cui il giudizio è sempre compromesso in virtù della propria forma è il mondo delle norme in conflitto insanabile, delle affermazioni e negazioni polemiche, delle lotte tra prospettive irriducibili: il giudizio implica e riassume in sé una polemicità originaria. Se gli enti ideali dipendono da un atto, ed un atto è sempre finalistico, non si può misconoscere come un fine sia sempre preso in un gioco di conflitti con altre finalità, e come l’intenzionalità, perciò, sia sempre polemica: appunto, in-tendere è anche affermare una tendenza, il che presuppone che vi siano altre opzioni possibili. L’atto, in quanto intenzionale, è sempre tendenzioso, e perciò l’obiettività ideale sorge sempre dalla parzialità di una polemica.
Dalle scienze, al loro divenire ed alle loro architetture sistematiche, al giudizio; e dal giudizio, ai valori ed alla lotta che è uno strato ulteriore rispetto alla forma della Wertbeziehung, la quale è a sua volta materia della forma-giudizio. Attraverso la progressiva reiterazione della riduzione, si riguadagna il mondo che si è perso nella sospensione dell’atteggiamento ingenuo: tanto in Husserl quanto in Bachelard. Ma questo mondo non è più quello già obiettivato e offerto dalle scienze, oggetto della riduzione. Si tratta di un mondo “nuovo”, altrettanto “spesso”, complicato e cogente di quello ingenuo, ma dal significato opposto: se il mondo ingenuo era il mondo prodotto, ciò che si ottiene mediante la sospensione della sua validità, è la complessità e la cogenza del mondo della produzione. Per Husserl, questo mondo è il mondo-della-vita, l’originario suolo di tutte le obiettivazioni teoretiche, che è sempre-già presupposto alle prestazioni attive dell’intenzionalità. Qual è per Bachelard lo strato ultimo, l’orizzonte pretematico, che resta implicito in tutte le riduzioni, e che esse non possono se non restituire, in quanto sempre-già-là, sempre a monte di ogni riduzione, Faktum originario che precede (ed è implicato da) ogni movimento di sospensione critica? È questo un altro punto in cui l’epistemologia bachelardiana può aprirsi ad una filosofia della pratica, cioè, è qui lo snodo sistematico che può dar ragione dei rapporti tra questa epistemologia ed una certa interpretazione del marxismo (quella althusseriana)[22]. Le pratiche, intese in senso lato come le forme di vita entro cui l’uomo esiste, sono quel “mondo-della-vita” implicito in ogni giudizio, in ogni posizione polemica, in ogni affermazione di valori. La ragione polemica, motore della conoscenza scientifica, è sempre incarnata in sistemi di pratiche in cui si uniscono strutture significative e produzione/riproduzione dell’esistenza, nessi di significato e rapporti di potere: i vincoli e l’efficacia di questo intreccio tra senso e non-senso, tra strutture e forme necessitanti, opache e talvolta incoerenti – un intreccio che è la stessa esistenza umana – costituiscono il luogo della genesi e dello sviluppo dell’attività propria al giudizio scientifico. Il “mondo-della-vita” che resiste alla riduzione e che si ritrova sempre-già dato al cuore stesso degli atti produttori di scientificità, degli atti intenzionali da cui dipende l’obiettivazione delle formazioni scientifiche, perde in tal modo ogni connotazione sentimentale e generica, per rivelarsi come il sistema di condizionamenti che alla pura teoreticità – ed alla posizione assiologica che afferma quest’ultima – sono posti dalla forma dei rapporti sociali, dalla struttura del linguaggio, dai dispositivi del senso, dalla corporeità dell’essere umano ed alla temporalità, alla finitudine, intrinseci all’esistenza. Se la ragione polemica afferma un ordine di valori, non può farlo che in questo “gioco” contraddittorio e indefinitamente problematico, in questo strato opaco in cui si radicano tutti i giudizi e tutti i valori, e tutti i conflitti tra prospettive assiologiche inconciliabili – non c’è valore, né significato (foss’anche quello della pura razionalità), né lotta tra valori (foss’anche una lotta conclusa con la vittoria del valore della pura teoria) che non affondi le proprie radici nella grevità empirica di forme di vita storiche, che possa costituire un’obiettivazione sovraordinata alla esistenza preriflessiva senza rimanere in pari tempo un prolungamento di quest’ultima, senza che il distacco dall’esistenza resti una possibilità dell’esistenza stessa, intelligibile a partire da essa e dalle sue forme. Questa prospettiva però non è senza problemi. Da essa, risulterebbe che la forma-giudizio è caratterizzata da due contenuti materiali: dal riferimento ai valori scientifici, che si tratta di affermare proscrivendone altri e incompatibili, da un lato, e, dall’altro lato, dal mondo delle pratiche, da quello spazio dell’imprecisione e dell’impregiudicatezza in cui i valori sono ancora in uno stato conflittuale non-deciso. Il giudizio sarebbe dunque condizionato sia dall’affermazione del valore del progetto razionale delle scienze moderne, sia dall’efficacia materiale dello strato dell’esistenza extrascientifica in cui questo progetto ancora non può dirsi affermato come valido. Il processo costitutivo della scientificità, il movimento storico del suo divenire, in virtù di questa duplicità del giudizio avrebbe dunque una doppia matrice: il perseguimento dei suoi fini e valori razionali immanenti, e il coinvolgimento nella totalità delle pratiche storiche.
La razionalità implica ad un tempo precisione, esattezza, stabilità e coerenza nella determinazione dell’oggetto, e chiarezza, evidenza, continuità e presenza-a-sé nella determinazione simmetrica del soggetto. Soltanto i valori obiettivanti della ragione possono costituire un mondo coerente abitato da esseri intelligenti. Si noti: da esseri. Poiché solo l’obiettivazione/soggettivazione razionale può garantire l’effettiva comunanza degli intelletti in un mondo condiviso. L’esperienza “sognante” del mondo è necessariamente solipsistica. In essa, il soggetto è confrontato solo ai fantasmi della propria immaginazione, ed esso stesso è simile ad un’ombra, incapace di comunicare, e, quindi, di generalizzare (e poi universalizzare) alcunché della propria esperienza. Il mondo della reverie è necessariamente un mondo privato, che ciascuno possiede esclusivamente: il mondo comune è quello diurno, quello della vita desta e razionale. In esso, gli oggetti sono costruiti secondo regole razionali, ed il soggetto è completamente determinato dalle stesse regole. L’universalità delle forme razionali dell’obiettivazione e della soggettivazione implica la validità generale di tali forme: soltanto tramite esse si realizza la comunità dei soggetti e prende forma un mondo condiviso. Bachelard parla spesso della “città scientifica”, luogo geometrico della razionalità pura, ove si compie la convalida (e la rettifica) delle conoscenze scientifiche. Ma sarebbe un errore interpretare questa tesi nel senso restrittivo di una sociologia degli scienziati, i quali formerebbero l’unica comunità effettivamente retta da quelle regole razionali produttrici di intersoggettività. Il “nuovo spirito scientifico”, com’è noto, non esiste solo nei laboratori e negli istituti: esso si incarna nella tecnologia di uso quotidiano, e in una normatività che va oltre l’ambito particolare dei programmi di scuola. Lo spirito scientifico caratterizza un tipo d’uomo particolare, un uomo “razionalizzato” ad opera dell’Umwelt tecnoscientifico[23] in cui vive, e del dressage impostogli dalla natura sempre più scientificizzata del proprio mondo-della-vita. A differenza di Habermas, per Bachelard il mondo dell’esistenza-in-comune è il mondo della razionalità, non uno spazio primordiale che teme la colonizzazione di quest’ultimo - la costruzione di una Umwelt razionale è inscritta nel destino dell’uomo. L’Umwelt tecnoscientifico è il “fondamento intersoggettivo” - l’unica vera “comunanza della ragione” si dà nel mondo costruito a immagine dello spirito scientifico, non esiste “mondo” se non un mondo di verità razionali, la cui struttura ci coinvolge tutti: l’uomo contemporaneo vive nella “comunità” di un reticolo di relazioni e strutture intelligibili, incarnate nei dispositivi da cui dipendono la nostra sussistenza, le nostre possibilità di comunicare, di agire e di sapere. Non è tutto: l’uomo che vive in questa Umwelt razionale è esso stesso “preso” in relazioni razionali – è l’uomo che figura come una grandezza statistica nelle tecniche di gestione della popolazione, di cui può venire mappato il codice genetico, di cui vengono misurate le attitudini psicofisiche, ecc. Sia come parte dei “grandi numeri”, sia come individualità singolarizzata, ciascuno di noi ormai è uno snodo di relazioni razionali, attraverso le quali soltanto ha accesso a se stesso ed al mondo che ha in comune con altri. Bisogna però evitare di considerare l’apparato tecnoscientifico come un complesso di “cose” anziché come una prospettiva, un sistema di regole e di vincoli per l’azione e il pensiero, dunque, in ultima analisi, come un “punto di vista”, benché totalizzante e facilmente scambiabile per un dato di fatto. Ciò che consente a tale apparato di strutturare un mondo-della-vita è la sua normatività: scienza e tecnica si pongono come regola e criterio della validità e della correttezza del sapere e dell’agire. L’Umwelt tecnoscientifico non è un insieme di oggetti tecnologici, ma un sistema di norme da cui siamo governati e “regolati” in modo ormai spontaneo e inavvertito. Nel nostro vivere quotidiano, nelle nostre Lebensformen, le domande e le risposte decisive sono quelle formulabili secondo il modello di razionalità tecnoscientifico. Abbiamo visto come la verità scientifica non sia un dato, ma un telos per il giudizio. Allo stesso modo, la Umwelt razionalizzata non è nulla di immediatamente materiale, ma deve la propria cogenza al fatto di essere un criterio del giudizio pratico e teorico. Ciò che viene solitamente denominato razionalizzazione, gabbia d’acciaio, o Ge-stell, non coincide con le manifestazioni visibili della tecnologia – la “gabbia” non è d’acciaio, né di nessun altro materiale, perché essa è soltanto la chiusura su stesso dell’ordine dei valori razionali, la sua intolleranza nei confronti di altri orizzonti assiologici, e quindi il suo ergersi ad unico criterio normativo “monoteistico”. Per questo, Bachelard può citare Brunschvicg affermando che l’uomo è “destinato all’intelligenza”. Questa tesi ha in effetti una duplice valenza. Innanzitutto, si può dire che la razionalità e l’intelligenza sono il destino dell’uomo in quanto senza il prevalere dell’ordine assiologico che esse rappresentano, per l’uomo si aprirebbe il baratro del solipsismo, della “fantasticheria” incoerente ed incontrollata, oppure la ristrettezza di orizzonti dell’homo faber, che può superare tali limiti spirituali solo qualora sull’agire tecnico venga innestato l’atteggiamento razionale puro delle scienze moderne. L’uomo è destinato alla razionalità nella misura in cui solo quest’ultima può garantire all’esistenza umana una forma coerente ed un ritmo di sviluppo espansivo, una struttura stabile ed una dinamica trasformativa continua. Secondariamente, l’intelligenza è il destino dell’uomo in quanto la chiarezza razionale è il telos implicito in ogni atto di giudizio. Ritorniamo quindi alla centralità dell’atto giudicante. Esso, in quanto orientato a valori razionali, contiene in sé, come fine intenzionalmente dato, la realizzazione di un mondo razionalizzato. La tensione alla costruzione di una Umwelt tecnico-scientifica, a realizzare oggetti sempre più impensabili senza l’incorporazione di concetti altamente astratti e complessi, a costruire forme di pensiero sempre più astratte e teoretiche, a plasmare quindi in pari tempo il soggetto e l’oggetto, a formulare ogni problema – etico, politico, economico, amministrativo, ecc. – in termini trattabili dalla norma vigente di scientificità, è già data come finalità intenzionale in ogni giudizio che ponga effettivamente nessi razionali. Il telos di un universo razionale non è da intendere come identico al telos di una realizzazione ultima della scienza, e, conseguentemente, di una sua fine. In questo equivoco non è difficile cadere: una teleologia della ragione può sembrare incompatibile con il carattere dinamico e plastico della razionalità bachelardiana. In realtà, l’Idea-in-senso-kantiano della Scienza non ha nulla a che vedere con uno stadio finale cui lo sviluppo delle conoscenze dovrebbe fermarsi. Quest’ultimo è in linea di principio infinito, così come infinito è il riempimento dell’orizzonte regolativo fornito da un’idea kantiana. La permanenza di un telos nel divenire ha un significato di direzionalità di quest’ultimo, non di termine ultimo empiricamente raggiungibile. Peraltro, nell’idea regolativa della razionalità è implicita anche la sua natura diveniente. Il fine cui mira intenzionalmente il giudizio razionale è un fine che comprende organicamente una mutabilità dei quadri della conoscenza e del pensiero esatto. Per Bachelard solo la sensibilità immediata è statica, solo gli ideali dell’immediatismo sono ideali di invariabilità: al contrario, tendere al fine di una razionalità dispiegata significa mirare ad una condizione di più intense mobilità e plasticità del pensiero, ad un dinamismo superiore. Quanto più l’idea regolativa è riempita di contenuti, quanto più la ragione si dispiega e si fa “ambiente”, “mondo”, tanto più il pensiero è mobile e rapido, tanto più è ricco e capace di costruire una molteplicità di rapporti intelligibili e di realizzazioni pratico-teoretiche. Con l’affermazione dei valori razionali non si raggiunge uno stato di immobilità: la ragione che giudica sempre più consapevolmente a partire dai propri valori regolativi immanenti è al contrario una ragione sempre meno fissa e limitata.
Il problema dei “limiti della ragion scientifica” è affrontato apertamente nel saggio sul Concetto di frontiera epistemologica: la tendenza all’essenzialismo applicata alla definizione della razionalità scientifica serve un’esigenza assiologia extrascientifica, fornisce un quadro statico delle scienze per poter mostrare come del tutto pacifico e naturale che i limiti di questa staticità rimandino a valori differenti, estetici o religiosi[24]. Ora, nessuno di questi valori ha legittimità all’interno della ragion scientifica, i cui “limiti” sono sempre provvisori, interni, e richiedono una strategia di superamento del tutto intrascientifica, basata appunto sul fatto che non esiste un quadro statico della ragione, i cui confini eterni e prestabiliti imporrebbero e legittimerebbero un ovvio ricorso ad altre fonti di verità. La ragione scientifica per Bachelard sembra quindi costituire un orizzonte flessibile ma definitivo: essa è in continua trasformazione sotto la spinta di movimenti endogeni, ma nessuna sua mutazione può realmente spingerla oltre se stessa – una volta che sia stata affermata la capacità autorettificativa come essenziale alla conoscenza approssimata, quest’ultima diventa causa ed effetto della propria evoluzione, la quale non incontra mai un limite tale da poterla rinviare alla Religione, alla Morale, alla Sapienza, o all’Arte. Naturalmente, il procedere autorettificativo delle scienze non è automatico, non può essere risolto in un algoritmo, in una procedura automatica di decisione: la rettifica richiede sempre un atto creativo dell’intelligenza, un giudizio, che si faccia carico della ristrutturazione del rapporto ragione/esperienza in vista di una migliore approssimazione. E, come si è detto, il giudizio è sempre effettuato all’interno di un sistema di condizioni, di pratiche e di forme di vita extrascientifiche. Tuttavia, queste condizioni del procedere concreto della ragion scientifica non sono la Verità della Scienza, che è tutto un altro concetto, interamente ideologico. Una volta che una verità scientifica sia stata affermata, essa è una verità in quanto essa stessa si dà i mezzi e le procedure per verificarsi, non in quanto la sua emergenza è stata condizionata dalle pratiche non-scientifiche. Queste ultime spiegano la genesi della verità dalla non-verità, cioè non dalla falsità, ma da ciò che ancora è impregiudicato perché precede l’istituzione dei criteri di verità di cui è questione. “Abbiamo dunque un’idea vera”, che è vera in virtù di se stessa, sebbene il luogo della sua emergenza sia un luogo in cui né l’idea, né dunque il discrimine tra verità e falsità che essa porta in sé e che determina in virtù della propria mera esistenza, esistevano. Le scienze quindi non sono prive di finestre sul mondo, ma in questo mondo ad esse esterno non ci sono verità scientifiche, né tantomeno c’è la Verità della Scienza. Le uniche verità delle scienze sono le verità interne alle scienze, che non si trovano preformate in nessuna condizione extrascientifica, sebbene è a queste che si debba far ricorso per capire l’emergenza dei dispositivi di verità immanenti alle scienze. Cioè: la ragion scientifica non ha esterno, perché ciò che è esterno ad essa non è la ragion scientifica. Per questo la sua attività di oltrepassamento dei limiti non potrà mai portarla oltre se stessa; per questo, quindi, così come il suo sviluppo non è garantito ed orientato da un’Origine extrascientifica di cui essa attualizzerebbe le potenzialità preesistenti, allo stesso modo né tale sviluppo né i suoi blocchi possono legittimare un presunto “necessario sfociare” in una pratica extrascientifica, o magari nella contemplazione del Numinoso. Le origini della scienza sono illocalizzabili, perché vengono continuamente rifuse e riscritte nel suo divenire; ed il fine della scienza non è altro che questo stesso divenire e modificarsi, teleologicamente orientato solo a sé stesso, ad una Verità che coincide con il proprio accadere, come abbiamo già visto, con la storia del processo infinito della verificazione. Se la verità è solo il risultato dell’attività infinita della rettificazione, allora non c’è un Oltre rispetto a questa verità.
La conclusione dunque è che nell’obiettivazione scientifica si realizza la costruzione di un intero mondo, di una seconda natura, indubbiamente articolata in molteplici relazioni e sottostrutture, caratterizzata dalla temporalità immanente del proprio sviluppo, articolata su altri “mondi vitali”, su pratiche, rapporti, extrascientifici: ma nondimeno si tratta di un mondo dotato di leggi proprie, di un proprio sistema di norme. Il giudizio, l’atto mediante il quale questo mondo si sviluppa e si modifica, giudica secondo la norma fornitagli a priori dalle “leggi” di questo mondo, pur nella plasticità e nella varietà che esso contiene. La posizione del giudizio è pertanto anfibia e paradossale. Da un lato, esso è un atto che implica e porta in sé l’insieme delle pratiche e delle forme di vita extrascientifiche entro cui viene compiuto; dall’altro, obbedisce alla teleologia immanente alla razionalità scientifica. Questa duplicità è necessaria nel quadro teorico bachelardiano. Infatti, il giudizio è ciò attraverso cui l’universo delle scienze progredisce e muta. Se quindi ogni nuovo giudizio non facesse che esplicitare contenuti già impliciti nello stato del sapere immediatamente precedente, la creatività delle scienze, la produttività della conoscenza approssimata, non sarebbero che apparenti: lo sviluppo delle scienze non può essere già contenuto dalle scienze stesse come la pianta dal seme. Le discontinuità storiche devono essere essenzialmente anomale, non previste dal quadro già dato della conoscenza. Ma, d’altra parte, data la potenza del pensiero discorsivo, capace di costituirsi in una Umwelt, autonoma e indipendente, un giudizio, per essere scientifico, cioè per stabilire una novità teorica valida come scientifica, deve essere conforme alla norma immanente della razionalità scientifica stessa. In altri termini, le rotture che scandiscono la storia del pensiero scientifico, devono adempiere alla duplice condizione di essere contemporaneamente omogenee ed eterogenee rispetto al campo in cui intervengono, di dover appartenere alla continuità del pensiero astratto-discorsivo e di non poter essere deducibili da esso, di dover valere come valide e vere entro il campo della scientificità pur ristrutturando in profondità i suoi criteri di validazione e di verifica. Questo movimento paradossale si manifesta con la chiusura della razionalità scientifica rispetto al luogo extraterritoriale della sua genesi. Una volta avvenuta una rottura, le sue conseguenze diventano “scienza normale”, si integrano nell’ordine normativo del sapere, rimuovendo così il momento stesso della cesura, un momento in cui tutto è ancora indeciso, e le soluzioni future esistono ancora solo allo stato virtuale di un problema aperto. L’atto del giudizio interviene proprio in questo momento, che le scienze normalizzate non possono vedere per definizione, perché rappresenta la loro “invisibilità interna”, il loro punto cieco - cioè media tra ciò che risulterà conforme alla norma e contenuto nella storia di una rettificazione progressiva, e il momento critico, la crisi in cui tutti i dati della situazione diventano egualmente rilevanti prima di essere di nuovo separati dall’emergenza di una norma di verità. Non si può misconoscere il fatto che è questa capacità di chiusura autoisolante a conferire alle scienze il proprio potere di plasmazione della Umwelt. Le scienze moderne e contemporanee sono in grado di trasformare così radicalmente la vita umana, le abitudini, i modi di pensare, (anche) perché sono in grado di costituirsi in forma di vita autonoma. Esse possono far valere così radicalmente nella polemica tra ordini assiologici i propri valori appunto in quanto sono in grado di dar forma ad una sfera in cui non vi sono altro che problemi, soluzioni, domande, risposte, e orizzonti, esclusivamente scientifici. Il divenire della scienza si attua quindi in uno spazio protetto in cui nulla di esterno può penetrare, ed è questa unilateralità, che però può anche garantire una notevole flessibilità interna, a rendere così agevole l’isolamento della “sfera” scientifica dal restante contesto storico. Il paradosso starebbe in ciò, che proprio la capacità di costituire un “mondo” da parte della scienza si radica nella sua “acosmicità”, mentre, al contrario, è l’autonomia isolazionista delle scienze a costituirsi nel rapporto con il restante ambito dell’esistenza. Il giudizio, in quanto medio tra il “dentro” e il “fuori”, costituisce quello spazio neutro, tematizzando il quale si avrebbe accesso al rapporto delle pratiche scientifiche con le altre pratiche, ed al modo in cui questo rapporto si declina nel non-rapporto della chiusura autoreferenziale. Ma appunto la concepibilità del giudizio si trova allora messa in discussione: è infatti chiaro che la posizione del giudizio è in tal modo propriamente impensabile – le scienze assumono dunque un ruolo cruciale nella vita moderna, ed al tempo stesso diventano un oggetto paradossale, enigmatico, privo di uno statuto definito, poiché la sua genesi e i suoi rapporti col Tutto diventano indicibili. Se la verità è solo interna alle scienze, una volta che queste si siano chiuse nell’autosufficienza della propria storia autorettificantesi, come pensare il momento in cui queste rettifiche sono state rese possibili da un pericoloso contatto, anzi, da una scandalosa indistinzione, con il fuori assoluto, in cui cioè la verità è potuta emergere dalla non-verità, lasciandosela poi alle spalle come la traccia di una rischiosa promiscuità? Come pensare dunque questo momento in cui dall’omogeneità più indiscriminata, a monte di qualunque distinzione categorica, dovrà emergere appunto una tale distinzione, che sostituirà l’omogeneo con l’assolutamente anomalo, la pluralità di istanze paritetiche con lo statuto privilegiato assegnato a ciò che è qualificato come vero?
A ben vedere, questa aporia è già visibile nella caratterizzazione dell’ostacolo epistemologico: naturalmente, in quanto tale ostacolo è superato da un giudizio, da un atto di affermazione di un problema, di un’invenzione, contro un’evidenza immediata, l’aporia non fa altro che specificare le difficoltà interne all’essenza del giudizio stesso. come abbiamo visto, il giudizio afferma i valori immanenti alla ragion scientifica, ma li afferma in polemica, in lotta, contro altri valori – di che genere? La risposta di Bachelard è duplice, e da ciascuno dei possibili modi di formularla può svilupparsi un “bachelardismo”: naturalistico, se si riterrà che questi valori antiscientifici siano fondamentalmente i valori della passività, della sensibilità, dell’immaginario, degli stati psichici in cui lo spirito è “fuori di sé”, alienato nella sussistenza anonima dell’abitudine e dell’immediatezza; storico-materialistico, a voler prendere questa locuzione in un senso non stereotipato, se si vedranno nei valori contro cui il giudizio afferma la razionalità i valori di pratiche extra-scientifiche: la religione, il diritto, l’estetica, l’ideologia in generale, e anche i rapporti di potere politici ed economici. Questa duplicità è palese nella critica che Bachelard muove, ad esempio, a Francis Bacon: la filosofia di Bacon è un ostacolo epistemologico – ma perché? Perché Bacon è l’alfiere della sensibilità, dell’affettività legata alla passività irriflessa delle sensazioni; o perché pensa la conoscenza in analogia con la propria pratica di giurista?[25] Per Bachelard, la polemica intrinseca all’affermazione della ragion scientifica consiste soprattutto nel porsi problemi, nel fare domande, nel distruggere certezze, contro la tendenza ad accettare passivamente soluzioni e risposte di cui ci si senta già “sicuri”. Ma quest’ultima tendenza, che incarna i valori antiscientifici, donde proviene: dall’affettività contrapposta alla risoluzione discorsiva del dato, o dall’efficacia delle pratiche non-scientifiche entro quella scientifica? In effetti, qui ritroviamo il problema dell’antinomia esterno/interno. Se prendiamo per buona la prima risposta, consegue che la polemica tra spirito scientifico e ostacoli epistemologici è tutta interna alla scienza stessa: l’affermazione dello spirito scientifico appare come uno slancio teso a porre problemi, a ristrutturare perpetuamente i quadri del pensiero, e, viceversa, l’ostacolo appare come una caduta della tensione di questo slancio, che però è interna allo slancio stesso. Semplicemente, c’è un cedimento interiore della volontà di razionalità: l’atto di dissolvere le certezze immediate si ripiega su se stesso per un calo della propria immanente spinta propulsiva, e allora lo spirito accetta come realtà, senza problematizzare ulteriormente, ciò che gli si presenta come ovvio e autoevidente. In tutto ciò, non c’è bisogno di ricorrere ad un universo di pratiche extrascientifiche. Se invece pensiamo che lo spirito scientifico sia in polemica contro i valori importati da queste ultime, allora non può non intervenire il “mondo” cui la scienza appartiene. E l’essenza stessa della polemicità del giudizio cambia: nel primo scenario, la polemica è tra due diversi livelli di energia e vitalità all’interno di un unico processo; nel secondo, la polemica che lo spirito scientifico intrattiene è contro un universo eterogeneo di valori, contro ordini assiologici qualitativamente irriducibili ad esso stesso. Nel primo caso, il giudizio è la ripresa riflessiva di uno slancio originario ed autosufficiente; nel secondo, è una lotta contro un avversario altrettanto originario e positivo dello spirito scientifico stesso. In realtà, queste due prospettive non sono inconciliabili. Lo spirito scientifico subisce un’inibizione, quindi un calo del proprio slancio interiore, ad opera dei valori extrascientifici che inibiscono, appunto, la sua tendenza a porre problemi creativamente: la “volontà di sapere” interna alla ragione è limitata dalle pratiche esterne che bloccano la posizione di problemi (e quindi il processo della conoscenza) nella configurazione di cui hanno bisogno perché esso non minacci i loro valori fondanti – è limitata da altre volontà: di sicurezza, di bellezza, di giustizia. La religione, l’estetica, il potere, l’ideologia, possono imporre allo spirito di non ricercare più, di non andare oltre, di non mutare ulteriormente il quadro del pensabile: questo per non minare il loro rapporto determinato con tale quadro. Ma il rapporto si può anche invertire: è allora una certa “pigrizia” dello spirito scientifico, un’insufficiente esigenza di rigore, di creatività e di coraggio intellettuale, a veicolare all’interno della ragione interessi e valori estranei: politici, ideologici, morali, ecc. Se quindi, da un lato, l’efficacia di pratiche esterne produce un prevalere della passività all’interno della ragion scientifica, dall’altro è tale passività interna al pensiero a dare libero corso agli effetti di pratiche esteriori allo spirito scientifico. Allora, il giudizio che afferma il progredire di tale spirito sarà contemporaneamente rivolto all’immanenza ed all’esteriorità, pronto ad affermare l’autonomia dei valori scientifici, la loro autonoma capacità di porsi e di prodursi, e, al tempo stesso, in correlazione polemica con il Fuori delle pratiche sociali: rivolto all’esterno dello spirito per potenziarne lo slancio interiore, rivolto all’interno dello spirito per escluderne gli influssi esterni.
Questo stato del problema coinvolge in realtà la stessa possibilità di una “importazione” virtuosa dell’epistemologia bachelardiana nel materialismo storico, cioè nella teoria delle pratiche storico-sociali, tentata da Althusser. Infatti, l’autonomia della scienza, se diventa chiusura totale, non lascia posto alla concepibilità di una relazione con le altre componenti del “tutto strutturato” dei rapporti sociali. Ed in questo senso uno dei capisaldi del progetto althusseriano rischia di minare quest’ultimo alla radice. Come più volte ribadito nel Cours de philosophie pour scientifiques, il compito di una filosofia “giusta” consisterebbe nell’affermare l’autonomia delle scienze contro l’idealismo, responsabile di sottomettere le scienze stesse ad esigenze morali (cioè ideologiche e politiche) con il pretesto di fondarne l’oggettività[26]. Come si è visto, è precisamente ciò che fa Bachelard negando la pertinenza del discorso sui “limiti assoluti” delle scienze, spostando ogni “limite” nell’orizzonte interno della pratica scientifica: nel saggio sulla frontiera epistemologica possiamo quindi a buon diritto vedere un’anticipazione del Cours althusseriano, che, se non vi è contenuto, nemmeno se ne allontana in linea di principio. Ma la posizione “autonomista” non è priva di difficoltà. Se le scienze sono già autonome dal restante contesto storico, perché mai difenderne l’autonomia? La risposta è che, in realtà, questa autonomia va conquistata sempre di nuovo dal lavoro filosofico. Eppure questo lavoro dovrebbe consistere nel riaffermare un’autonomia sempre-già esistente, che solo l’idealismo negherebbe dall’esterno. Si potrebbe dire quindi che l’autonomia delle scienze è sempre in anticipo rispetto alle sue effettive condizioni di esistenza. Essa ha sempre bisogno di essere istituita da un intervento filosofico il cui scopo è ricordare che non c’era bisogno di alcun intervento. Questo evidente paradosso si scioglie se attribuiamo alla filosofia il compito di tenere un discorso sul divenire-autonome delle scienze, cioè sul chiudersi retroattivo della loro “sfera” a partire da una situazione di relazioni selvagge e indecise tra pratiche sociali – quindi, sulla genealogia delle loro norme istitutrici. Solo allora si può capire come l’autonomia delle scienze debba essere difesa, in quanto essa non è un dato (se lo fosse, non ci sarebbe nulla da temere: ogni suo misconoscimento non potrebbe essere altro che ineffettuale), ma il prodotto contingente di una relazione tra pratiche.
La relazione tra scienze e pratiche non-scientifiche, ed in particolare tra scienze e politica, va oltre la lettera delle tesi althusseriane. Le scienze, nella misura in cui si uniscono alla tecnologia sperimentale e applicativa, costituiscono un mondo, lo si è già detto più volte. Bachelard parla di una “fenomenotecnica” capace di produrre ciò che un tempo erano i “fenomeni naturali”, e correlativamente di una metatecnica che sostituisca la metafisica. Ed infatti non c’è più una physis oltre la quale andare: l’uomo vive in una realtà che si manifesta, si fa cioè “fenomeno”, solo in quanto sia già stata prodotta – non c’è manifestazione senza sollecitazione, la “natura” è sempre provozierte Natur. Il processo di produzione, non solo tecnico, e quindi esclusivamente empirico, ma anche razionale, e quindi tecnico-scientifico, ha sostituito le datità e l’osservazione pura. Le società sono attraversate da reticoli tecnico-razionali, da teorie incarnate e da pratiche pensanti, razionalizzate – il comportamento umano, sia istintuale sia riflessivo, è regolato da ordini razionali, i gesti e le azioni si appoggiano sulle scienze e sulle tecnologie come su un punto di riferimento imprescindibile per regolare scopi, esecuzioni e raggiungimento degli obiettivi. C’è quindi una coincidenza di esperienza e verità, dovuta alla formazione di un mondo razionalizzato – nel quale non possono esservi enti dati in modo “ingenuo”, ma sempre e soltanto come correlato di una verità, di un’operazione razionale: la datità delle cose è condizionata dal sistema di relazioni intelligibili che le individua e dalle operazioni che le producono. La filosofia di Bachelard è quindi definibile come una fenomenologia della realtà tecnoscientifica, divenuta condizione di ogni “presenza dell’Essere”, di ogni apparizione degli enti. La possibilità di considerare gli oggetti come concrezioni di significato e non come “cose”, dunque la possibilità stessa del progetto fenomenologico della riduzione, è dispiegata in modo completo solo allorché la formazione di una Umwelt razionalizzata ha reso il “dato” un prodotto del pensiero, di pratiche dotate di senso, di schemi formali. Ma al culmine di questa riduzione dell’essere al senso scopriamo che è il senso stesso a non poter mai coincidere pienamente con se stesso, a non potersi mai chiudere in una totalità autotrasparente: la sfera delle concrezioni di significato dipende infatti da un esterno, da un “fuori” che essa non può comprendere nelle proprie forme e che può riapparire solo come sintomo, lapsus, emergenza critica del reale opaco e irriducibile nello spazio del puro significare. L’“essere” ritorna dunque nel cuore stesso del puro valere, non più come dato rappresentabile, ma come scarto incolmabile tra il significato e il suo istituirsi, tra il valore ed il processo di valorizzazione, e pertanto come ostacolo non riassorbibile all’autosufficienza di tale processo. È questo l’analogo risultato che i percorsi di Husserl e Bachelard ottengono nei confronti del problema dell’origine dei “mondi” da essi descritti: nel primo caso, il luogo d’origine del “mondo”, il presente impressionale, non è sottoposto alle leggi strutturali interne al mondo stesso e che determinano tutti gli enti che di esso fanno parte – l’origine degli enti intramondani non è dunque ente intramondano. Nel secondo caso, il luogo d’origine del processo di costituzione delle verità scientifiche è esterno alla razionalità scientifica – l’origine dello spirito scientifico non è una verità scientifica. Non c’è quindi scienza della scienza, né norma della norma, se interpretiamo lo spirito scientifico come la norma di razionalità cui è teleologicamente orientato il giudizio produttore di verità. Non c’è dubbio che ciò risulti particolarmente inquietante: la razionalità divenuta mondo, capace ormai di trarre l’Essere dalle proprie procedure, su cui la conduzione delle nostre vite si orienta e da cui è regolata - sarebbe dunque mossa da un impulso cieco, non a sua volta razionalizzabile? Il movimento della razionalizzazione sarebbe orientato da una norma data come tale ma impossibile da sottoporre alla validazione da parte dell’esigenza di razionalità che essa stessa impone al giudizio? La risposta, in prima approssimazione, non può che essere affermativa: la norma di scientificità non può essere normata dall’interno della razionalità da essa istituita, né da principi ultimi a questa esterni. Non c’è una Morale da sovrimporre alla scienza, ma nemmeno la possibilità di trasformare la scienza in Morale – a scapito delle mistificazioni bigotte relative ad una “scienza al servizio della Vita”, come se le maiuscole potessero colmare uno scarto tra la norma e la sua posizione, tra il senso e la sua emergenza, che è dato apriori con la norma stessa. Ogni tentativo di sottomettere la scienza ai valori dimentica che la scienza stessa è un valore, e che nessun valore può valutare la propria valorizzazione. A questo punto, anziché lasciare spazio alle lamentazioni sull’autonomizzazione disumana della tecnica, bisogna riaprire il problema spostandone i termini. Sappiamo già che le norme autonomizzate si formano e si affermano in uno spazio impregiudicato di validità virtualmente paritetica, uno spazio pre-normativo, in cui si dà solo il conflitto tra assiologie inconciliabili. L’unica via per non violare l’autonomia di una norma vigente guadagnando al tempo stesso una distanza critica rispetto ad essa (che è poi la condizione per concepirla appunto come una norma, anziché come un fatto bruto) è un’operazione archeologica di risalita a monte della “decisione” che ha istituito una norma invalidandone altre logicamente equivalenti ma incompossibili con la prima. L’archeologia ricostruisce quindi lo spazio conflittuale da cui sorgerà il mondo obiettivato secondo una norma, e che, dalla prospettiva di questo mondo stesso, appare solo come un’anomalia, come il “punto” introvabile ed evanescente del “presente impressionale”, o dell’istante in cui il giudizio afferma la novità irriducibile di una presa di coscienza che si risveglia dall’errore. Questa operazione che chiamiamo archeologia, pur avendo l’aspetto di un sapere, di una teoria, è più esattamente definibile come una strategia flessibile di disobiettivazione, in cui l’unica norma è data dall’esigenza di mostrare la contingenza e la storicità di ogni norma vigente. Non si tratta di trovare una meta-norma che “normi la norma” ma di prendere un “oggetto” solido e fissato e fragilizzarlo, evidenziarne gli strati e le articolazioni al fine di mostrare il suo sorgere dai giochi di una scena irriducibilmente politeistica. In questo senso, possiamo vedere sotto un’altra luce l’opera di Bachelard. L’autonomia e l’autoprocessualità della ragion scientifica infatti appaiono come una dimostrazione pratica della contingenza di ogni obiettivazione razionale: mostrando come la fisica matematica contemporanea costruisca il proprio oggetto, ne modifichi la fisionomia sul piano direttamente “ontologico”, rettificando tutte le presupposizioni sostanzialistiche che fissano come date le obiettivazioni precedenti, Bachelard mostra come sia questa stessa scienza a fragilizzare l’ovvia sussistenza dell’oggetto – mostra cioè come la scienza non sia discorso su fatti, ma affermazione di valori, posizione di problemi e non analisi di dati. Poiché lo spirito scientifico all’opera nell’astrazione matematica è un potente vettore di obiettivazione, è pure, in virtù di questo stesso dinamismo, un potente fattore disobiettivante - l’innovazione e la rettifica mostrano la provvisorietà di ogni statuto ontologico[27]. Questa prospettiva, lo si vede, è una torsione del pensiero di Bachelard che, come abbiamo detto, può confliggere con il suo naturalismo. Perché la fluidificazione delle obiettivazioni si trasformi in una loro archeologia è necessaria, probabilmente, una maggior chiarezza sulla pluralità irriducibile degli orizzonti normativi – abbandonando l’idea monistica della polemicità della ragione chiamata a lottare solo contro la propria pigrizia. Come Husserl, Bachelard crede ad una semplicità dell’Impulso, alla stregua del Wille schopenhaueriano. È chiaro che un’archeologia può essere motivata solo da una visione pluralistica del conflitto tra diverse volontà– secondo la lezione di Nietzsche. È questo ciò che alcuni allievi di Althusser troveranno in Canguilhem: l’elaborazione di una logica dell’errore in grado di conferire a quest’ultimo uno statuto non unicamente privativo è solidale con l’affermazione di una pluralità di valori. Lungo questo albero genealogico avviene dunque la trasformazione, nell’epistemologia di lingua francese, di una fondamentale esigenza della fenomenologia: far sì che il progresso scientifico, ruotando attorno all’asse sui cui si regge e da cui regge le nostre sorti collettive, coincida col «ritorno della consapevolezza – non più magica, ma razionale – intorno alla parentela che anticamente univa gli uomini e le cose»[28]. Il movimento della razionalizzazione incessante induce un contromovimento che spinge il pensiero through the looking-glass: allora diventa pensabile la scena originaria e conflittuale che, dalla prospettiva dell’élan verso l’affermazione sempre ripetuta dello spirito di razionalità, appariva solo come il momento unico dell’istante dell’innovazione, in cui quest’ultima si afferma nel dissolvimento dell’errore rettificato – condizione dell’imprevisto è il disseppellimento dello strato arcaico su cui il conatus innovatore aveva steso il velo di Maya. La storia dinamica ed abbagliante degli eventi del pensiero creativo rimanda al lavorìo sordo di una vitalità anonima e ostinata.
[1] Questa tesi ha un preciso antecedente nella veduta di Auguste Comte, per cui solo la conoscenza delle leggi della natura, dischiusa dall’avvento dello spirito positivo, conferisce stabilità e ordine alla vita interiore, condannata all’anarchia e all’incoerenza in assenza dell’effetto disciplinante esercitato dalle nozioni scientifiche.
[2] Bernard Barsotti, Bachelard critique de Husserl. Aux racines de la fracture épistémologie/phénoménologie, L’Harmattan, Paris, 2002. Nella prefazione Jean Gayon ricorda che il libro di Barsotti tratta solo delle opere bachelardiane successive al 1934 (dunque gli studi raccolti nel presente volume sono tutti precedenti o contemporanei rispetto al periodo in cui secondo Barsotti avviene il confronto tra Bachelard e Husserl) e afferma: «Nella sua tesi complementare, Etude sur l’évolution d’un problème de physique: la propagation thermique dans les solides (1928), Bachelard aveva in effetti già incontrato la fenomenologia, non quella di Husserl, ma quella dei fisici. In questo libro di storia delle scienze che è una perorazione vibrante della fecondità della matematizzazione delle teorie fisiche, Bachelard concludeva rifiutando senza riserve la concezione secondo la quale le teorie fisiche (matematizzate) non sono che descrizioni abbreviate, riassunti algebrici, delle “classificazioni”, dei dati fenomenici. Per quanto questi autori non siano citati, venivano così respinte le concezioni di Mach, di Pearson e di Duhem, che in effetti Bachelard conosceva assai bene. Le formule utilizzate, i confronti che si possono fare con la tesi principale, sono perfettamente chiari al riguardo. Ora, questa epistemologia “fenomenalista” (o fenomenista come dicono gli anglosassoni), è esattamente ciò che i fisici tedeschi, e in particolare Mach, chiamavano “fenomenologia”. La tesi del 1928 utilizza occasionalmente il termine “fenomenologico” in questo senso. Senza dubbio, non è attraverso la lettura di Husserl che Bachelard ha iniziato a incrociare le spade con la “fenomenologia”. Ad un certo punto dell’opera, la fenomenologia dei filosofi è venuta a mescolarsi a quella degli scienziati-filosofi» (Jean Gayon, Préface a B. Barsotti, op. cit., p. 11 sg). Ipotizziamo che Bachelard abbia potuto assimilare fenomenologia machista e fenomenologia husserliana in virtù di quegli aspetti di quest’ultima che sembrano concordare con la prima sul primato della semplicità e originarietà del dato sensibile. Al contrario il punto di vista di Husserl sulle oggettualità matematiche, del tutto non-machiano, rappresenta un momento di avvicinamento rispetto a Bachelard.
[3] L’immediatismo della fenomenologia è motivato da un’esigenza metodica: è necessario neutralizzare la presunzione di validità ingenua di ogni teoria, ipotesi, ecc., per ritrovare alla base di ogni sapere le operazioni costitutive. È quindi un’esigenza defeticizzante, che mira a rivelare il processo produttivo delle formazioni teoriche occultato nell’ingenua datità di queste ultime. Si tratta quindi di un immediatismo assai problematico, perché, in effetti, lo strato cui si accede metodologicamente tramite la messa in parentesi è appunto mediato da questa opera metodica di regressione “archeologica”, mentre immediato è piuttosto il campo teorico ingenuo da neutralizzare. Il “terreno vergine” liberato dalla messa in parentesi delle formazioni di pensiero allora non è nulla di realmente immediato, ma è il prodotto di un esercizio metodico e regolato – un’ascesi. Si tratta infatti di aprire uno spazio in cui risulti pensabile un “livello”, o uno “strato”, in cui tutto ciò che sappiamo essere una verità scientifica certa o probabile non esista ancora. A questo stesso problema ci conduce il percorso dell’epistemologia bachelardiana.
[4] Tra i testi husserliani che più legittimano la polemica bachelardiana vi è sicuramente questo passo del § 3 del capitolo primo di Idee I: “L’essenza (eidos) è un oggetto di nuova specie. Come il dato della visione individuale o empirica è un oggetto individuale, così il dato della visione essenziale è un’essenza pura. Non si tratta di una analogia esteriore, ma di radicale affinità. Anche la visione dell’essenza è appunto visione, come l’oggetto eidetico è appunto oggetto. La generalizzazione dei concetti correlativi “visione” e “oggetto” non è arbitraria, ma richiesta necessariamente dalla natura delle cose. La visione empirica, in specie, l’esperienza, è coscienza di un oggetto individuale: in quanto è visione, lo porta a datità; in quanto è percezione, lo porta a datità originaria, ossia è consapevolezza di afferrare l’oggetto “nell’originale”, “in carne ed ossa””(Edmund Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologia. Libro primo: introduzione generale alla fenomenologia pura, a cura di E. Filippini e G. Alliney, Einaudi, Torino, 1965, p. 18 sg.). Ma ciò che interessa ad Husserl è la natura “concreta” dei concetti “astratti”, la loro autonomia in quanto unità intelligibili determinate, nodi di relazioni ideali obbliganti per il pensiero che “se le trova di fronte” dotate di autonoma legalità e struttura. Da qui l’analogia con la visione e l’oggetto percettivo. Tuttavia, se in queste espressioni è l’oggetto percettivo a fornire il modello dell’ oggettualità, da un punto di vista generale è l’oggettualità ideale matematica a fornire alla fenomenologia il modello di ogni oggetto, in quanto essa è un “oggetto” di puro significato, determinato unicamente ed interamente dalla propria idealità.
[5] Enzo Melandri, Logica ed esperienza in Husserl, Il mulino, Bologna, 1960, p. 81 sg. L’estensione di principio di questa concezione è resa ottimamente dal seguente passo melandriano, che val la pena di citare per intero: “Ciò che viene messo in luce dall’analisi intenzionale non è l’ente finito e discreto, ma l’ente integrato nel contesto relazionale dell’esperienza. Per ogni ente, esistono delle implicazioni che, se non vengono elucidate adeguatamente, operano in senso negativo e fanno sì che la comprensione dell’ente stesso risulti (…) sfigurata. Così l’ente ci appare finito, e cioè dato in modo discreto, solo perché e fin tanto che non si riflette sulla sua fondamentale connessione con tutto il resto. Con l’analisi intenzionale questa artificiosa limitazione viene infranta e si tematizza proprio quel presupposto anonimo, passivo e semiconsapevole che costituisce la situazione trascendentale dell’esperienza di ogni ente. Prendendo coscienza di questa componente condizionale, l’analisi fenomenologia svela l’orizzonte strutturale di ogni esperienza. Col concetto di Horizonthaftigkeit Husserl indica appunto tutto l’insieme delle implicite componenti strutturali, a carattere prefigurativo, anticipatore e coordinatore, che formano lo Hintergrund o sfondo, di ogni possibile conoscenza di fatto. (…) In sé, il fatto che ogni ente sia inerente al mondo è cosa nota da tempo. La novità che la fenomenologia aggiunge a questa ovvia conoscenza, trasformandola in un principio rivoluzionario, è la coscienza dell’intrinseca necessità di tale inerenza. La “mondanità” dell’ente non risulta dall’aggiunta attributiva del carattere “mondano” alla nozione, presunta come già in sé completa, di ente. Ogni ente è in sé stesso quel che è proprio perché essenzialmente, intrinsecamente, da cima a fondo “mondano”. La mondanità fa parte del contenuto stesso dell’ente. Siccome però il mondo non è a sua volta un ente, ne consegue che ogni ente inerisce a qualcosa che non è propriamente dato. Il mondo infatti può dirsi dato solo nel modo inautentico, inadeguato e immaginativo in cui lo è un’“idea”. Come idea, tuttavia, e nella misura in cui un’idea può essere attuale, il mondo fa parte del contenuto concreto di ogni ente. Ne deriva un curioso e difficile rapporto di doppia implicazione: da un lato il mondo contiene (estensivamente) l’ente e dall’altro l’ente contiene (intensivamente) il mondo, o meglio: la forma del mondo, la mondanità, e ciò tra i suoi caratteri essenzialissimi e primari” (E. Melandri, op. cit., p. 92 sg.). Si noti che, sostituendo alla parola “ente” la parola “concetto”, ed alla parola “mondo” la parola “campo teorico”, questo passo finisce per ricalcare le riflessioni bachelardiane sulla necessaria relazionalità e contestualità delle nozioni scientifiche. La fenomenologia di Husserl può allora trasformarsi in una fenomenologia della ragion scientifica, in cui gli “enti” sono le nozioni, e il “mondo” è il campo teorico, l’inerenza implicita al quale conferisce ad una nozione lo statuto di verità scientifica. Questo passo può essere compiuto sol perché gli oggetti di pensiero, ed in particolare quelli matematici, sono per Husserl il Vorbild dell’oggettualità in generale.
[6] Ibid., p. 129.
[7] Ibid., p. 57.
1 E. Melandri, “Emozione, sentimento e conoscenza dal punto di vista fenomenologico”, in La scuola di Brentano, Suppl. di Topoi VI, n. 1, Reidel, Dordrecht, 1988 p. 102.
[8] Per questi problemi vedi E. Melandri, “Karl Buhler: la crisi della psicologia come introduzione a una nuova teoria linguistica”, in Id., Sette variazioni in tema di psicologia e di scienze sociali, Pitagora, Bologna, 1984, p. 251-269, in particolare le pp. 258 e sg.
[9] Jean-Michel Salanskis, Husserl, Les Belles Lettres, Paris, 1998, p. 20 sg.
[10] Ibid; p. 21.
[11] Ibid., p. 27.
[12] Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant, Stock, Paris, 1992, p. 18.
[13] Ibid., p. 18.
[14] Ibid., p. 19.
[15] Jean-Toussaint Desanti, Réflexions sur le temps. Variations philosophiques I, Grasset, Paris, 1992, p. 93.
[16] Ibid., p. 110.
[17] Ibid., p. 144.
[18] Ibid., p. 145.
[19] Ibid., p. 147.
[20] Ibid., p. 154.
[21] Questa tesi è sviluppata da due maestri riconosciuti di Bachelard: Léon Brunschvicg e Edouard Le Roy, dei quali si vedano in particolare:E. Le Roy, La pensée mathématique pure, PUF, Paris, 1960 (ma si tratta di lezioni del 1919), e L. Brunschvicg, La modalité du jugement, Alcan, Paris, 1899, e La causalità physique et l’éxperience humaine, Alcan, paris, 1922. Entrambi gli autori partono da posizioni idealistiche, kantiane Brunschvicg e bergsoniane Le Roy, finendo però per rendere gli atti costitutivi della conoscenza immanenti alla pratica teorica ed al campo scientifico, cancellando ogni ricorso ad un soggetto trascendente del giudizio e dell’intuizione. Il giudizio è una relazione interna al campo problematico, un atto, certamente, ma un atto che coincide con una trasformazione immanente al campo; mentre l’intuizione non è altro che l’unità del campo teorico riflessa nel campo stesso in quanto prende a tema le condizioni della propria intelligibilità – sarà poi Jean Cavaillès a riferire esplicitamente a Spinoza questa relazione, sancendo così la tesi che la conoscenza è un processo senza soggetto
[22] Althusser ha chiaramente riconosciuto la densità temporale dell’evoluzione scientifica secondo Bachelard, il ritmo irreversibile dello scarto prima/poi, nella teoria della coupure epistemologica: «Ogni scienza ha un inizio. Certamente, essa ha sempre una preistoria e ne deve uscire» (L. Althusser, Elementi di autocritica, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 12). Ma ne esce in due modi intrecciati: «una scienza esce dalla propria preistoria (…) per se stessa: in una (…) maniera che, almeno nella teoria, le appartiene esclusivamente (…) rifiutando cioè in tutto o in parte la propria preistoria, qualificandola come erronea, come errore (…) Una scienza riconosciuta è sempre uscita dalla propria preistoria, e continua (la preistoria le resta sempre contemporanea: come il suo Altro) ininterrottamente ad uscirne con il rifiuto di quella preistoria come errore» (Ibid., p. 13 sg.). questa è una discontinuità interna alla scienza, determinata da una tendenza immanente ad essa, e che si riassorbe nella continuità lineare dello slancio univoco della ragione verso una rettificazione progressiva, o, ciò che è lo stesso, nell’attualità del presente assoluto di un risveglio da sonni dogmatici: è la stessa dialettica tra presente, discontinuità e flusso temporale di cui abbiamo parlato sopra. Ma la coupure avviene anche in un altro senso, in base al quale la rettifica dell’errore non si riduce al mutamento unidirezionale di un processo unitario in cui avvengono bensì degli eventi ma omogenei – una scienza esce dalla propria preistoria nel senso «che una scienza non nasce dal nulla, ma da tutto un lavoro di gestazione, complesso, molteplice, rotto talvolta da lampi, ma oscuro e cieco, perché “esso” non sa a cosa tende, né, se mai giunge ad una conclusione, dove va a sboccare. Una scienza nasce dal concorso imprevedibile, incredibilmente complesso e paradossale, ma necessario nella sua contingenza, di “elementi” ideologici, politici, scientifici (dipendenti da altre scienze), filosofici, ecc., che, in un dato momento, “scoprono”, ma a cose fatte, che si stavano cercando giacché si incontrano senza riconoscersi nella figura teorica di una scienza nascente» (Ibid., p. 12 sg.). In questa folgorante anticipazione epistemologica di ciò che sarà la tarda elaborazione del “materialismo dell’incontro”, Althusser parla dell’incontro tra le condizioni extrascientifiche di un evento interno allo sviluppo delle scienze. E questo significa ricondurre la coupure alle condizioni di esistenza delle scienze nel Tutto delle pratiche sociali: «abbiamo il diritto di parlare anche di “rottura epistemologica” e di utilizzare questa categoria filosofica per designare il fatto storico-teorico della nascita di una scienza (…) attraverso il sintomo visibile dell’uscita di essa dalla sua preistoria, che è il rifiuto degli errori della sua preistoria. A condizione (…) di non prendere dei semplici effetti per la causa, ma di pensare i segni e gli effetti della “rottura” come il fenomeno teorico della nascita di una scienza nella storia della teoria, che rimanda alle condizioni sociali, politiche, ideologiche e filosofiche di questa irruzione»(Ibid., p. 17 sg.). Questa teoria delle condizioni della rettifica, che trasformano la rettifica in un’“irruzione”, è il modello stesso dell’appropriazione materialistica, non solo della “rottura” bachelardiana, ma, tramite essa, delle analisi husserliane sulla sintesi temporale ed il presente impressionale.
[23] L’inseparabilità di tecnica e teoria razionale nella scienza moderna è un luogo comune, ma giova ripeterlo per non tramutare questo rapporto in uno schiacciamento al ribasso sul primo termine della relazione. Abbiamo cercato di delineare altrove l’appartenenza di tecnica e teoria a due distinti ordini assiologico-normativi (ci permettiamo di rimandare a: Andrea Cavazzini, “Scienza e realtà. Lettura di Koyré”, in Alexandre Koyré, Filosofia e storia delle scienze, Mimesis, Milano, 2003, e Id, “La questione del senso. Una critica dell’ermeneutica di Gadamer”, in Glaux, (…). ). Ciò implica un conflitto all’interno della “tecnoscienza”: riteniamo però del tutto vano negare che questi due ordini esistano oggi nell’intreccio di un unico apparato. Koyré è l’autore che meglio ha distinto questi due piani, fornendo al tempo stesso una genealogia della loro fusione all’alba della scienza moderna, allorché si è ritenuto che ai fenomeni del “mondo sublunare”, fino ad allora lasciate alla manipolazione da parte di tecniche empiriche, potesse essere applicata la razionalizzazione della teoria matematica pura.
[24] Raramente un punto di vista religioso ammetterà onestamente di essere in conflitto con i valori razionali: cercherà invece di caricaturare questi ultimi per “dimostrare” che, oltre essi, si apre in modo del tutto naturale, e in virtù di limiti immanenti, un altro Regno – forse anche un altro Sapere, diverso da quello solo mondano. Questo è più o meno lo schema della posizione bellarminiana, e in realtà anche di quel fenomeno di costume vagamente ipocrita che sono i “dialoghi” tra laici e credenti, tra scienziati e teologi.
[25] In un’ottica marcatamente ispirata ad Althusser, così interpreta Roberto Dionigi: «La procedura di scoperta proposta da Bacone, è ricondotta ad un’altra procedura – giuridica – di cui è un adattamento: i concetti che definiscono la seconda fungono da metafora nella definizione della prima (…)Forse che Bachelard voglia dire che Bacone ha tradotto nel suo metodo l’affettività legata alla sua pratica di giurista? Non lo crediamo. Al contrario, crediamo che (…) Bachelard riesca per un momento a reprimere il suo psicologismo e a dimenticare la categoria di soggetto. Bacone è semplicemente il luogo di un’interferenza tra pratiche distinte: nel suo piccolo, egli chiama in causa i rapporti di dominanza e di subordinazione che definiscono la composizione gerarchica dell’ideologia complessiva di quell’epoca determinata. Il termine “psicanalisi” non è qui altro che il nome privilegiato di una teoria di quei rapporti» (R. Dionigi, Gaston Bachelard. La “filosofia” come ostacolo epistemologico, Quodlibet, Macerata, 2001, a cura di Alberto Gualandi, p. 62 sg. ). La psicanalisi invocata da Dionigi non può che essere l’archeologia di cui parleremo più avanti. Tuttavia, per quanto si debba senz’altro condividere le tesi di Dionigi, si deve notare come il problema del vincolo affettivo che lega lo spirito scientifico all’ostacolo non può essere così facilmente evacuato. Lo stesso Dionigi rileva come il metodo baconiano nasca da una metafora, da un’estrapolazione analogica della prassi giuridica la cui efficacia non si gioca sul piano della verifica positiva ma è immediatamente persuasiva, quindi affettiva. In altri termini, perché un’interferenza tra pratiche acquisti un potere di blocco del pensiero, è necessario che sia veicolata da un dispositivo analogico fondato sull’affettività: se, altrimenti, essa fosse sociologicamente riducibile, non servirebbe alcuna psicanalisi.
[26] Louis Althusser, Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati. Corso di filosofia per operatori scientifici, a cura di M. Turchetto e F. Losi, Unicopli, Milano, 2000.
[27] Rimandiamo a queste osservazioni di Melandri, che non concernono Bachelard ma concludono una lettura di Foucault: «è un luogo abbastanza comune dell’odierna epistemologia caratterizzare la scienza mediante la sua indefinita capacità di autocorrezione: capacità che vale non solo nei confronti delle ipotesi su fatti da accertare meglio in seguito, ma anche nei confronti degli stessi principi – logici, matematici o semplicemente fantastici – in base ai quali si formulano le ipotesi. Un modo inverso di dire la cosa – in bianco su nero anziché in nero su bianco – è che la scienza, benché fondata sull’oggettività, tende in virtù del suo stesso progresso a dis-oggettivizzare l’esperienza. Cioè: il sapere scientifico, qualora non cristallizzi in dogmatica, progredisce nell’esatta misura in cui nello stesso tempo regredisce archeologicamente. Esso riassorbe via via le “rimozioni” che, per poter procedere, ha dovuto frapporre tra sé e il mondo. Ma, in virtù del suo stesso successo, la scienza crea le condizioni per il proprio superamento, quale si avrebbe nel trapasso dell’oggettivazione conoscitiva in tecnica terapeutica, attiva cosmogonia, restituzione dell’intero» (Enzo Melandri, “Note in margine all’episteme di Foucault”, in Lingua e stile …).
[28] Enzo Melandri, ibidem.