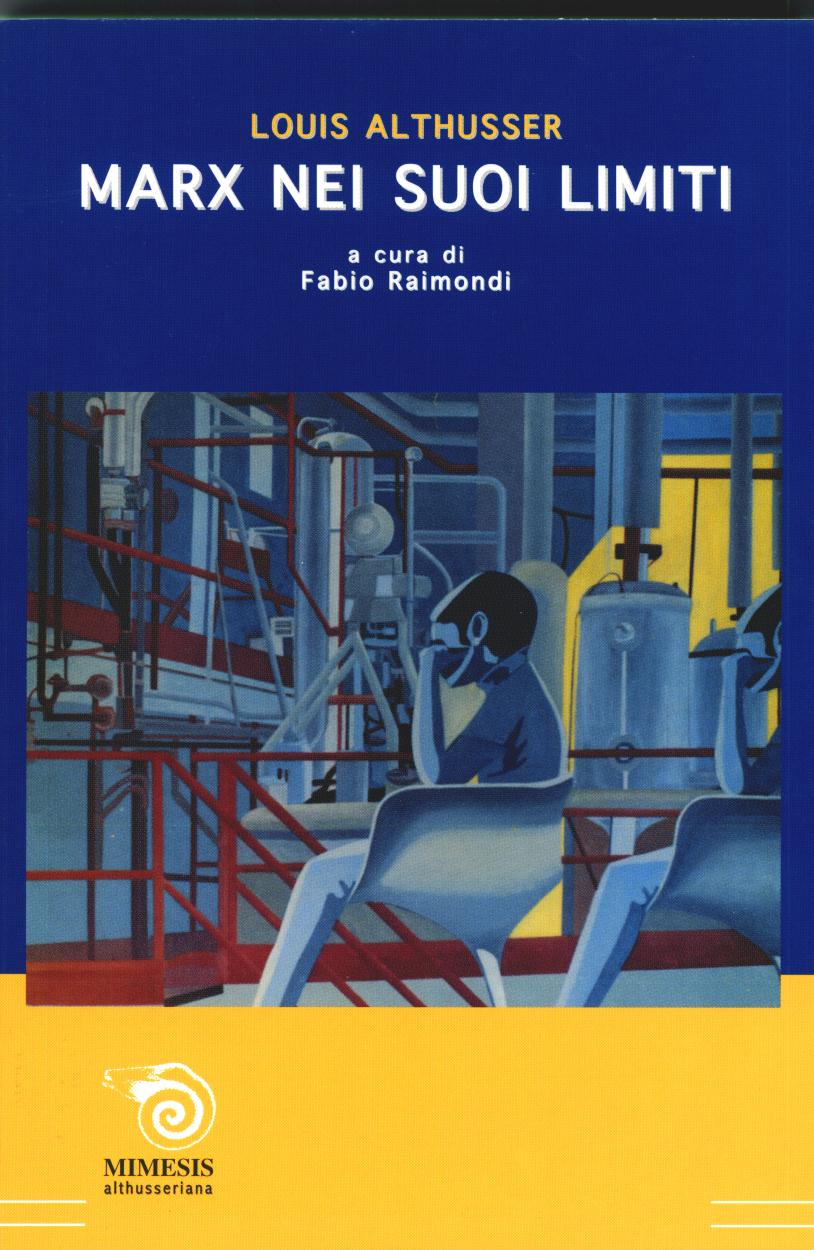
Marx nei suoi limiti
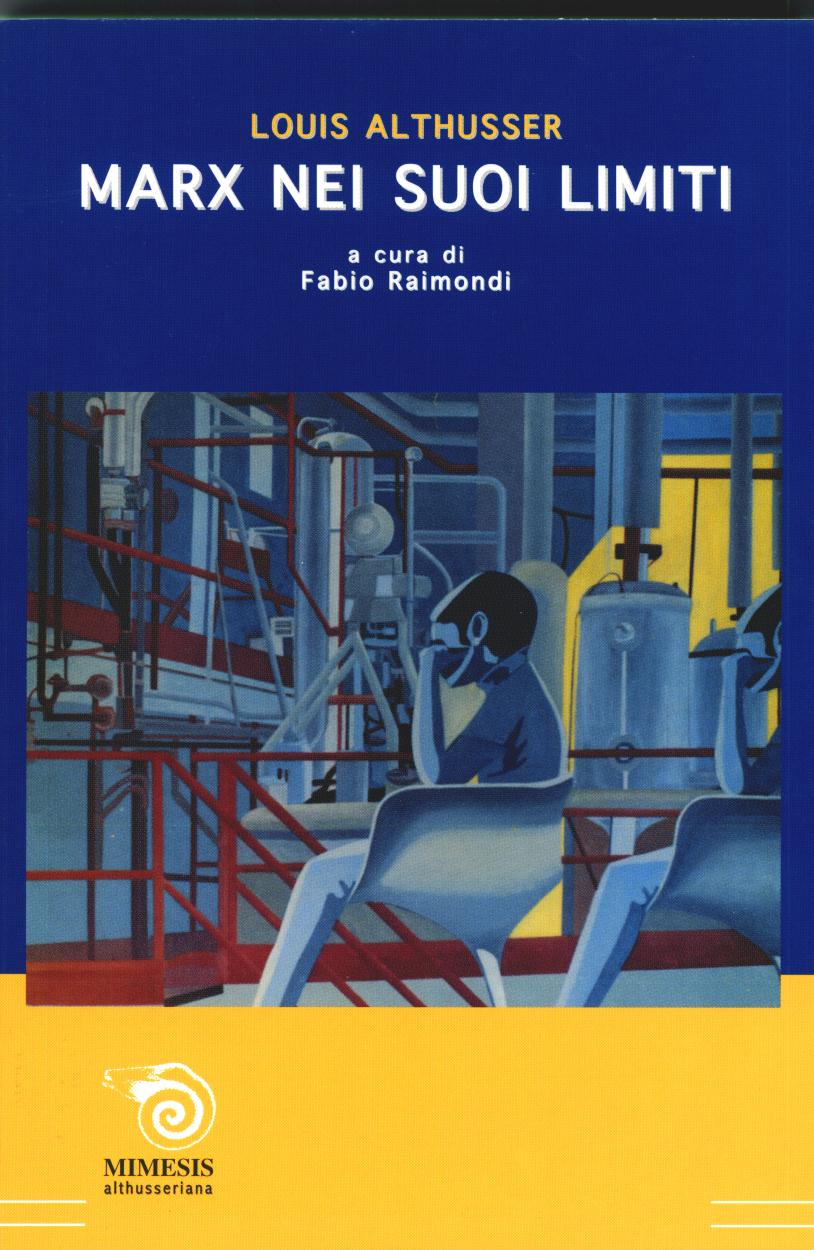 |
Louis Althusser Marx nei suoi limiti |
L'impensabile politica di Althusser
di Fabio Raimondi
Car tout homme qui intervient par l'action - et je tenais alors l'intervention philosophique pour une action,
en quoi je ne me trompais pas - intervient toujours dans une conjoncture pour en modifier le cours
(L. Althusser, L'avenir dure longtemps)[1]Car parler de ce que peut être la politique entraîne à donner son avis sur le parti.
Or que fait-on dans le parti, si ce n'est de la politique?
(Id., Marx dans ses limites)[2]
Testo inedito e quasi certamente incompiuto, Marx nei suoi limiti
(1978) è, probabilmente, uno di quegli scritti a uso interno che
Althusser era solito produrre per discutere le proprie idee con una cerchia
ristretta di amici e allievi, oppure la raccolta ordinata di materiali preparatori
per un testo che, però, non è mai stato pubblicato. Proporne
oggi, a distanza di quasi trent'anni, la traduzione credo possa rispondere
almeno a tre ragioni di fondo: innanzitutto, la possibilità di riflettere
ulteriormente sulla crisi del marxismo; in secondo luogo, affrontare la
necessità di ripensare Marx e il marxismo attraverso l'individuazione
dei loro limiti teorici[3], attraverso
l'applicazione delle regole del materialismo-storico (e non di quello dialettico,
<<questo termine atroce>>[4]);
terzo, cercare di collegare la riflessione dell''ultimo' Althusser con quella
del 'primo', a partire dalla stagione dell'<<autocritica>>[5], per leggere questo testo anche come una
sorta di "Althusser nei propri limiti"[6].
Gli scritti del biennio 1977-78 si inseriscono in una temperie politica
e culturale, ricordata proprio in Marx nei suoi limiti (cfr. cap.
1), che costituisce il quadro di riferimento fondamentale della riflessione
althusseriana[7]. Gli elementi principali,
che condensano l'aria del tempo, fanno capo alla fase di destalinizzazione
dell'Urss, almeno a partire dal XX Congresso del Pcus (1956), durante il
quale Chruöèëv denunciò pubblicamente i crimini
del regime staliniano; proseguono con la rottura, avvenuta intorno agli
anni Sessanta (e formalizzata nel 1963), dell'unico movimento comunista
internazionale guidato dal partito comunista sovietico, a causa della scissione
tra Cina e Urss; si radicalizzano con la contrapposizione tra <<i
partiti cosiddetti "eurocomunisti" e il Pcus>> - basti pensare
ai fatti d'Ungheria (1956), alla "primavera di Praga" (1968) e
alla storia polacca dal '56 all'81 - solo per fare alcuni esempi. Qui cominciano,
per Althusser, le domande e, in modo particolare, quella sul perché
ciò sia avvenuto, ossia sulla capacità dei <<marxisti,
che si proclamano comunisti, di render conto della propria storia>>.
Una capacità che non hanno avuto soprattutto a causa dei limiti della
teoria marxista; limiti con i quali bisogna cominciare a fare i conti, innanzitutto
filosoficamente, anche se va subito messa in luce la reversibilità
tra momento teorico e pratica politica: i limiti teorici sono limiti politici
e viceversa. È da qui che diventa possibile e necessario un <<lavoro
di correzione e di revisione>> che Althusser concepisce principalmente
come lavoro filosofico[8].
Il 16 dicembre 1976, Althusser tiene una conferenza alla Sorbona, presso
l'Unione degli studenti comunisti, pubblicata l'anno successivo, dopo il
rifacimento, col titolo 22éme Congrès (del partito
comunista francese). La situazione internazionale è configurata,
al contempo, dalla debolezza dell'imperialismo, ma anche da quella del movimento
comunista internazionale, mentre forti sono i movimenti di massa popolari
e operai (il riferimento, principalmente, è a quelli sviluppatisi
nei paesi del Sud Europa, dopo la caduta delle dittature: Grecia, Spagna
e Portogallo, ma anche a quelli contro le guerre d'Algeria e del Vietnam,
per finire col '68[9]). Queste forze renderebbero
possibile il passaggio al socialismo (dittatura del proletariato) per via
democratica, cioè pacifica (il XXII Congresso abbandona la dittatura
nel senso staliniano per accoglierla in uno dei sensi già usati da
Marx e Lenin, quello di <<dominazione>>), il che non significa
senza lotte, ma, tutt'al più, senza violenza (a meno che essa non
venga impiegata dalla borghesia per prima): <<la forma politica
di questa dittatura o dominazione di classe del proletariato è
la "democrazia sociale" (Marx), la "democrazia di massa",
la "democrazia portata fino in fondo" (Lenin)>>. Il XXII
Congresso, però, ponendo il problema del passaggio democratico al
socialismo, compie anche un'operazione che ne segna i limiti, ossia identifica
e propone il socialismo come uno stato (un modo di produzione stabile),
negandone, illusoriamente, il carattere di <<periodo di transizione
contraddittoria tra il capitalismo e il comunismo>>, ossia rinunciando
alla prospettiva del comunismo, la sola dalla quale il socialismo può
essere visto come un'utile fase transitoria. Il Congresso, insomma, ha il
merito di aver riposto il problema dello Stato, non solo di quello borghese,
ma anche di quello socialista; ciò che invece non ha fatto è
di non aver ricordato <<una tesi fondamentale di Marx e Lenin: che
non è solo lo Stato borghese a essere oppressivo, ma ogni Stato>>
(dunque anche quello rivoluzionario), incorrendo nell'errore di proporre
lo Stato socialista come soluzione generale e non contraddittoria
di ogni problema del proletariato, della classe operaia e delle masse lavoratrici.
Ma, soprattutto, ha sorvolato su cosa significhi distruggere lo Stato
borghese, fingendo di poter scansare l'ostacolo, semplicemente aggiungendo
<<l'aggettivo "democratico" a ogni apparato di Stato esistente>>,
come se la forma giuridica della democrazia potesse di per sé risolvere
ogni problema (su questi temi si vedano i capp. 11 e 15 della presente traduzione).
Infine, conclude Althusser, il XXII Congresso ha sottaciuto un'altra questione
di non minore importanza: quella del "centralismo democratico".
Il Partito non ne parla e Althusser si limita a segnalarlo, suggerendo che
se il problema è <<l'unità del partito con le masse
popolari>>, allora bisogna interrogarsi sui loro rapporti e, soprattutto,
che il Partito dovrebbe aprirsi a un confronto a tutto campo, senza eludere
anche la rudezza del confronto e accettando le dinamiche conflittuali che
ne possono scaturire: <<è infinitamente meglio che tutto s'esprima,
piuttosto che venga ricoperto dal silenzio>>[10]:
una sorta di accorgimento freudiano. Solo così potrà nascere
un nuovo Partito all'altezza dei tempi.
L'anno seguente, dall'11 al 13 novembre 1977, Althusser è a Venezia
per un dibattito tra esponenti della sinistra europea occidentale e orientale,
organizzato dal quotidiano <<il manifesto>>. Nel suo intervento,
Enfin la crise du marxisme!, Althusser ritorna su alcuni temi già
toccati l'anno precedente, spostando però l'accento sulla crisi teorica
che, a suo modo di vedere, stava alla base della teoria marxista, la quale
non aveva ancora saputo render conto di come e perché <<il
socialismo sovietico avesse potuto condurre a Stalin e al regime attuale>>
(quello breûneviano). Althusser saluta con favore lo scoppio della
crisi del marxismo che, a suo avviso, non è recente (se non nella
sua visibilità di massa), ma risale, per schematizzare, agli anni
Trenta, quando Stalin impose, a suo modo, a tutti i partiti comunisti la
soluzione di alcuni problemi: un'imposizione che ebbe l'effetto di aggravare
la crisi del marxismo, ma anche di bloccare l'esplosione delle sue contraddizioni.
Solo alla fine degli anni Settanta, grazie alla forza dei movimenti di massa
sopra ricordati, la crisi è potuta esplodere in tutta la sua dirompente
portata, lasciando intravedere potenzialità fino ad allora sopite.
La crisi però non è imputabile solo a Stalin e allo stalinismo,
ma anche al fatto che vi sono delle lacune e delle contraddizioni nella
teoria, dato che ogni teoria - tanto più se materialista - non è
mai pura e completa, ma siccome cerca di rompere con l'ideologia
dominante deve sempre lottare per non assimilarne, magari inavvertitamente,
principi o idee, trovandosi così invischiata in ciò che vuole
combattere. In questo scritto Althusser elenca una serie di problemi, che
poi riprenderà, approfondendone la trattazione, proprio in Marx
nei suoi limiti (si vedano, di seguito, almeno i capp. 6 e 12): primo,
l'unità teorica imposta dall'ordine del Capitale è,
in gran parte, fittizia, dato che Marx si è sentito obbligato dal
suo idealismo a cominciare dalla merce e dal valore, ossia dal più
astratto. Ciò ha una conseguenza notevole sulla nozione di plusvalore,
che è presentato solo in termini contabili (<<come la differenza
di valore tra il valore prodotto dalla forza-lavoro e il valore delle merci
necessarie alla riproduzione della forza-lavoro medesima, salario>>),
facendo così <<astrazione sia dalle condizioni di estrazione
del plusvalore (condizioni di lavoro) sia dalle condizioni di riproduzione
della forza-lavoro>>. Questa, dunque, non può essere una <<teoria
"completa" dello sfruttamento>>, anche se bisogna rilevare
che la sua influenza politica è stata notevole nel definire la divisione,
all'interno delle lotte del movimento operaio, tra lotta economica e lotta
politica. Secondo, <<l'enigma della filosofia e, in particolare, della
dialettica>>, sulle quali Marx ha lasciato solo formule troppo schematiche,
che non possono esser prese alla lettera. La lacuna è molto grave
non solo perché ne va del rapporto Hegel-Marx, ma anche perché
concerne la concezione marxiana della storia, la cui rilevanza politica
è nota. A ciò s'aggiunga che proprio i silenzi di Marx sul
tema hanno consentito a Stalin di imporre la sua versione positivistica
e evoluzionistica della storia. Terzo, una teoria marxista dello Stato non
esiste. Marx e Lenin se ne sono occupati a lungo, ma hanno lasciato solo
un'indicazione negativa: bisogna tenersi lontano <<dalle concezioni
borghesi dello Stato>>, alla quale però non segue alcuna analisi
né proposta particolareggiata. Anche in questo caso, le conseguenze
politiche sono rilevanti, perché comprendere lo Stato sarebbe importante
per capire il ruolo del Partito nello Stato e dunque, ad esempio, la situazione
specifica dei paesi dell'Est europeo, dove il problema è l'accesso
al potere da parte delle <<forze popolari>>, affinché
possano agire <<nella prospettiva di una trasformazione democratico-rivoluzionaria
dello Stato, in vista del suo deperimento>>. Quarto, allo stesso modo,
non esiste una teoria marxista <<delle organizzazioni della lotta
di classe e, soprattutto, del partito politico e del sindacato>>.
Certo, ci sono opinioni e pratiche, ma nessuna analisi vera. In particolar
modo, non c'è una conoscenza approfondita del debito che le organizzazioni
del movimento operaio hanno con quelle borghesi, alle quali s'ispirano spesso
e dalle quali, altrettanto spesso, vengono assorbite e neutralizzate. I
due ultimi punti sono particolarmente importanti, perché pongono
alcune <<questioni decisive>> riguardo al rapporto tra Partito,
sindacati e movimenti popolari di massa, ai quali Althusser riconosce un
ruolo <<insostituibile>> sia nelle lotte sia nell'aver reso
possibile l'esplosione della crisi del marxismo, dove "crisi"
vale, in termini medici, come momento in cui si decide se la malattia può
essere curata o no, se si guarisce o si muore. La crisi, dunque, ha davanti
a sé sempre due possibilità: la riuscita o il fallimento.
Di qui le domande:
<<qual è la natura dello Stato e precisamente del tipo di Stato presente nelle nostre società imperialiste contemporanee? Qual è la natura, qual è il modo reale di funzionamento del Partito e del sindacato? Come sfuggire al rischio di entrare nel gioco dello Stato borghese, col rischio di finire poi nella fusione Stato-partito? Come pensare fin da ora, per innescare il processo, la necessità della "distruzione" dello Stato borghese e preparare il "deperimento" dello Stato rivoluzionario? Come rivedere e cambiare la natura e il funzionamento delle organizzazioni della lotta di classe operaia? Come modificare l'idea che il partito comunista si è fatto tradizionalmente di sé, sia come "partito della classe operaia" sia come "partito dirigente", come dunque modificare la sua ideologia perché sia riconosciuta, nella pratica, l'esistenza di altri partiti e di altri movimenti? E, soprattutto, questione delle questioni per il presente e l'avvenire, come stabilire col movimento di massa dei rapporti che, travalicando la distinzione sindacato-partito, assicurino lo sviluppo delle iniziative popolari, che eccede per la maggior parte del tempo la divisione tra l'economico e il politico, così come la loro stessa "somma"?>>[11].
Il punto sul quale Althusser sembra concentrare la sua attenzione è
quello della pensabilità della politica, come ha sostenuto
Alain Badiou in un saggio dedicato a Althusser, perché <<ciò
che attestano questi giganteschi fenomeni storici potrebbe ben essere non
la forza trionfale e sinistra dell'articolazione politica masse/partito,
ma piuttosto l'estrema debolezza politica di un'intera epoca: l'epoca marxista-leninista
o staliniana di cui apparirebbe quanto essa fu, rispetto alle esigenze dell'essere
della politica, l'epoca propriamente metafisica di quell'ontologia perduta
generata dall'evento marxista, cioè l'epoca in cui la politica non
si effettua che come oblio della politica. E la forma concettuale di questo
oblio potrebbe dipendere dal fatto che i suoi significanti chiave, masse
e partito, riorganizzati sotto la figura del legame, sarebbero stati spoliticizzati
e articolati non in rapporto all'essere della politica, ma a ciò
che va riconosciuto come il suo "ente supremo", il suo dio, cioè
lo Stato>>[12]. Il problema, dunque,
è quello del rapporto tra masse, Partito e Stato e del diverso tipo
di legame che le costituisce (si vedano almeno i capp. 4 e 20 della presente
traduzione).
A seguito del colloquio veneziano e, soprattutto, della scandalosa affermazione
althusseriana che in Marx non c'è una teoria dello Stato, il quotidiano
<<il manifesto>>, propone ad Althusser di reintervenire specificamente
su questo punto all'interno del dibattito sviluppatosi in alcuni settori
della sinistra italiana. L'occasione si concretizza il 4 aprile 1978 quando
sul giornale appare un suo intervento dal titolo Il marxismo come teoria
<<finita>>. In questo testo, Althusser spinge un po' più
a fondo la sua analisi, almeno su tre punti: primo, la teoria marxista va
considerata una teoria <<finita e limitata>>: "limitata"
perché circoscrive l'analisi al modo di produzione capitalistico
e alla sua tendenza contraddittoria, <<che apre la possibilità
del passaggio verso l'abolizione del capitalismo e della sua sostituzione
con "altro">>; "finita", perché non è
una filosofia della storia che inglobi, perché davvero riesce a pensarlo,
tutto il divenire dell'umanità, riuscendo così a definire
<<in modo positivo>> il suo approdo ultimo: il comunismo. La
teoria marxista è, invece, tutta inscritta nella <<fase attuale>>
(il tempo di Marx) e ciò che tutt'al più fa è proiettare
la <<tendenza in atto>> (quella verso il comunismo) a partire
dall'osservazione di alcuni fenomeni interni alla società capitalistica
(socializzazione della produzione, ecc.). La tendenza, però,
non è un automatismo, perché è contrastata da altre
tendenze: essa, dunque, può realizzarsi solo attraverso <<la
lotta politica di classe>>. Il risultato finale non è anticipabile,
perché l'esito delle lotte non è mai prevedibile e perché
le forme concrete prendono corpo solo in esse e attraverso di loro. Che
la teoria marxista sia finita, dunque, non significa che sia <<chiusa>>,
anzi, proprio perché finita è
<<aperta alle tendenze contraddittorie che scopre nella società capitalistica e aperta sul loro divenire aleatorio [cors. mio], aperta alle "sorprese" imprevedibili, che non hanno smesso di caratterizzare la storia del movimento operaio; aperta, dunque attenta e capace di prendere sul serio e misurare in tempo l'incorreggibile immaginazione della storia>>.
Secondo, <<il fatto che la lotta tra classi (borghese e proletaria)
abbia lo Stato per posta in gioco (qui e ora) non significa affatto che
la politica si debba definire in rapporto allo Stato>>. E, dunque,
così come Marx ha pensato la critica all'economia politica, ora bisogna
pensare la critica della politica borghese e ciò equivale a mettere
in discussione la distinzione tra Stato e società civile, perché
<<lo Stato ha sempre profondamente penetrato la società civile
(nei due sensi), non solo col denaro e il diritto, non solo con la presenza
e l'intervento di apparati repressivi, ma anche per mezzo dei suoi apparati
ideologici>>, chiamati, qualche riga dopo, <<apparati ideologici
di Stato>>, preferendo questa denominazione alla nozione gramsciana
di egemonia. È l'ideologia che convince dell'esistenza di
una sfera della politica separata da quella della società civile
e, proprio per questo, bisogna liberarsi dall'ideologia borghese e con essa
dall'idea che la posta in gioco della politica sia lo Stato (cioè
i suoi apparati e i suoi giochi: la rappresentanza, i partiti, la lotta
per il potere esistente, ecc.). Se ci si limita a vedere lo Stato in questo
modo, anziché come Stato <<allargato>>, si rischia di
cadere <<nell'illusione giuridica della politica>>, che altro
non è che lo strumento col quale l'ideologia consacra le forme volute
dalla politica borghese, nella vana pretesa di sostituire a uno Stato specchio
dell'alienazione uno Stato 'buono' (l'illusione riformista). È per
questo che il Partito deve porsi all'ascolto della politica <<là
dove nasce e si fa>> e, oggi, sono ancora i movimenti (operaio, femminista,
studentesco, ecologista, ecc.) a produrre <<una grande confusione>>
certo, <<ma che può essere feconda>>, perché <<mette
in causa la forma d'organizzazione del partito stesso>>, ossia la
sua forma borghese. Terzo, per quanto detto fin qui è inaccettabile
l'idea che il Partito si faccia Stato, perché, se così avviene,
<<abbiamo l'Urss>>. Ne consegue, che <<per principio (...)
il partito deve essere fuori dello Stato>>, borghese o proletario
che sia: deve essere lo strumento della <<distruzione>> dello
Stato borghese e uno di quelli che mettono in opera il <<deperimento>>
dello Stato in quanto tale. Ciò, ovviamente, non significa la <<soppressione
di ogni "regola del gioco", ma la trasformazione profonda>>
degli apparati dello Stato.
Per quanto generica, quest'affermazione serve ad Althusser per introdurre
un ulteriore punto: il comunismo <<come tendenza e realtà "interstiziale"
(...) disegna un vuoto nella nostra società>>. Stabilire le
nuove "regole del gioco" non è diverso dal definire il
comunismo. Ma, anche in questo caso, le <<formule idealistiche>>
di Marx, che portano a immaginare il comunismo come <<l'inverso del
feticismo>> (si veda il cap. 18 di questa traduzione) e dove appare
<<la libera attività dell'individuo, la fine della sua "alienazione",
di tutte le forme della sua alienazione: fine dei rapporti mercantili, fine
dello Stato, fine dell'Ideologia, fine della politica stessa [e], al limite,
una società d'individui senza rapporti sociali>>, vanno
criticate materialisticamente, perché immaginano una trasparenza
nei rapporti sociali del tutto irreale. Anche il comunismo, se e quando
sarà, avrà <<i suoi rapporti di produzione e dunque
i suoi rapporti sociali e ideologici>>; sarà <<liberato
dallo Stato>>, ma non dalla politica[13].
Sempre nell'aprile del 1978, tra il 24 e il 27, Althusser scrive anche una
serie di articoli sul quotidiano <<Le monde>>, dopo aver appurato
l'impossibilità di pubblicarli su <<L'Humanité>>,
poi raccolti in un volume dal titolo ]Ce qui ne peut plus durer dans
le parti communiste. Gli articoli, scritti all'indomani della sconfitta
elettorale del 19 marzo e del comitato centrale del Pcf che ne seguì,
di cui invano venne chiesta la pubblicazione degli atti, tendevano a riaprire
il dibattito all'interno del Partito su alcune questioni. Primo, il rifiuto
del metodo dell'<<amalgama>>: <<il grande (e unico) "contributo"
storico dei partiti staliniani all'"arte" della confutazione della
verità>>: un <<vecchio procedimento retorico e politico>>
col quale: 1) <<per screditare quelli che hanno proposto delle riflessioni
serie, si amalgamano le obiezioni serie e quelle volgari, attraverso la
confutazione di un'obiezione immaginaria, [per cui] l'accusa riposa nello
stesso tempo su testimonianze anonime e su false dichiarazioni>>;
2) si fa credere che le scelte del Partito avvengano attraverso un <<confronto
collettivo>> che, in realtà, è del tutto <<immaginario>>,
perché sempre <<predeterminato dalla direzione>>; 3)
si mettono <<i propri errori sul conto degli altri>>. Secondo,
il rifiuto dell'impostazione idealistica della politica del Partito, proteso
a <<impregnare i lavoratori>>, la loro coscienza, con
le idee del <<programma comune>>, presupponendo così
<<che è il partito (la sua direzione) il detentore della vera
coscienza, di fronte alla quale la coscienza dei lavoratori troppo spesso
è in ritardo>>. Terzo, la necessità di <<cambiare
da cima a fondo il modo di funzionare della "macchina" del partito>>,
ancora modellata sugli apparati borghesi del parlamentarismo e dell'esercito
(si vedano di seguito i capp. 9, 10, 12, 13, 17 e 20), ossia la necessità
di modificarne l'ideologia (il collante che tiene uniti i militanti comunisti
nel Partito), che altro non è che la sua teoria (rappresentata, in
Francia, dal "capitalismo monopolistico di Stato"), la quale conduce
a queste conclusioni:
<<1) siamo entrati in una fase che è l'"anticamera del socialismo", durante la quale>> la concentrazione monopolistica penetra nello Stato, che forma con essa "un unico meccanismo"; 2) la Francia è dominata da un "pugno di monopolisti" e di loro funzionari. Sono evidenti le conseguenze politiche di queste due tesi: 1) l'anticamera del socialismo e "il meccanismo unico" "Stato-monopoli" modificano i termini della questione dello Stato. Lo Stato assume tendenzialmente una forma che lo renderà direttamente utilizzabile dal potere popolare. Non esiste dunque più il problema della "distruzione" e, all'orizzonte di questo ragionamento, si profila già "l'abbandono della dittatura del proletariato"; 2) se lo Stato è pronto, vi sono già le forze pronte ad occuparlo, poiché di fronte a questo "pugno di monopolisti" c'è l'intera Francia vittima dei monopoli. A parte una piccola cricca (...) tutti i francesi hanno un obiettivo interesse all'abolizione dei monopoli>>.
Per realizzare l'obiettivo, dunque, la lotta di classe non è necessaria, ma serve solo la coscienza che, di conseguenza, va destata da fuori a colpi di propaganda. La teoria è già data, l'analisi concreta di situazioni concrete, da cui nascono la <<scoperta del reale>> e, nello stesso tempo, le indicazioni da seguire nella pratica politica, è del tutto superflua. Quarto e ultimo, come si esce da questa <<fortezza>>? Innanzitutto, evitando di fare politica secondo la specifica modalità borghese, che consiste <<nel fare in modo che siano gli altri a garantire il potere>>. Mentre la borghesia ha sempre fatto fare le rivoluzioni ai <<propri sfruttati>>, lasciando <<che le loro forze si scatenassero, per attenderli alla svolta del potere e allora abbatterli nel sangue o pacificamente eliminarli>>, il proletariato
<<deve "liberarsi da solo con le sue forze" (...), perché non ha sfruttati da manipolare. E poiché deve necessariamente concludere delle alleanze durevoli, non può trattare i suoi alleati come altri da sé, come delle forze alla sua mercé, da poter dominare a modo suo. Ma deve trattarli come degli eguali nel vero senso della parola, dei quali deve rispettare la personalità storica>>.
Questo significa che, prima di tutto nel Partito, non bisogna <<trattare
i militanti e le masse come altri da sé>>. Di conseguenza,
il Partito deve ritrovare un rapporto con le masse non attraverso le alleanze
elettorali, ma attraverso le lotte politiche: solo così potrà
uscire dal suo ripiegamento nella fortezza[14].
Nel frattempo, tra il febbraio e il novembre del 1978, Althusser mette a
punto un altro intervento dal titolo ]Le marxisme aujourd'hui, diventato
il brogliaccio per la stesura dei capitoli 2-8 e 19 di Marx nei suoi
limiti o, visto che non conosciamo con precisione l'arco cronologico
della stesura di quest'ultimo, un loro riassunto. Il nucleo di questo testo
riguarda il rapporto tra il pensiero di Marx e l'ideologia, uno dei suoi
limiti maggiori (si veda più oltre, in particolare, il cap. 19).
Detto schematicamente: la trasformazione delle idee in azione politica,
richiede, secondo Althusser, <<che le idee si possano ritrovare all'interno
di "forme ideologiche" di massa>> e questo non è
possibile <<attraverso la semplice propaganda, ma richiede delle organizzazioni
della lotta di classe>>. Per Marx (e poi, in sostanza, per tutto il
marxismo), però, <<l'organizzazione non ha mai posto problemi
teorici particolari>>, senza rendersi conto che ciò di cui
<<il movimento operaio deve fare esperienza storica>> è
che <<per durare e assicurare la sua unità di pensiero e azione,
ogni organizzazione si deve dotare di un apparato, che non c'è organizzazione
senza apparato - e che la divisione tra l'apparato e i militanti può
riprodurre la divisione borghese del potere>>. Non ponendosi questo
problema, si elude quello del Partito, rendendo possibile che l'ideologia
borghese penetri in esso nella forma della <<separazione tra "governanti
e governati">>. È a quest'altezza che, per accorgersi
di come l'ideologia borghese possa influenzare il movimento operaio, ci
sarebbe (stato) bisogno di <<una teoria materialista dell'ideologia,
dello Stato e del partito>>[15]:
solo essa avrebbe potuto scongiurare il pericolo sovietico di un Partito
che si fa Stato, idea <<difesa da Gramsci nella sua teoria del Principe
moderno, che riprende, in realtà, un tema di capitale importanza,
ben espresso da Machiavelli, quello dell'ideologia borghese della politica>>[16].
Riassumendo, è forse possibile dire che, secondo Althusser, qualcosa
s'è rotto all'interno del movimento e dei partiti operai,
marxisti e comunisti d'Occidente: qualcosa che non dipende solo dallo stalinismo,
ma è intrinseco alla teoria economico-politica di Marx e del marxismo
(dalla teoria del plusvalore a quella dello Stato). La cassetta degli attrezzi
è ormai insufficiente ed è all'interno di questa <<situazione
di vuoto della pratica e, dunque, della teoria, che la questione di sapere
cosa s'è rotto dev'essere affrontata>>[17].
L'accumulazione della forza necessaria per passare alla dittatura del proletariato,
cioè al socialismo, che pur essendo <<merda>>[18] è comunque necessario, è al
momento impossibile e, dunque, obbliga a una riflessione serrata sia teorica
sia pratica in una condizione di solitudine.
È in quest'impasse che si staglia la figura di Machiavelli,
il politico e il filosofo solitario per eccellenza, secondo Althusser, ma
anche <<l'inventore di una nuova conoscenza>>: quella della
fondazione, della durata e dell'espansione di uno <<Stato nuovo>>,
che <<non può essere compiuta da nessuno degli Stati esistenti>>,
ma solo da un <<principe nuovo>>. Secondo Althusser, Machiavelli
è
<<il teorico delle condizioni politiche della costituzione di uno Stato nazionale (...) in condizioni straordinarie, che sono quelle dell'assenza di ogni forma politica propria a produrre questo risultato. (...) Machiavelli è, forse, uno dei rari testimoni di ciò che chiamerei l'accumulazione politica primitiva, uno dei rari teorici degli inizi dello Stato nazionale. Invece di dire che lo Stato è nato dal diritto e dalla natura, ci dice come deve nascere uno Stato se vuol durare e essere tanto forte da diventare lo Stato di una nazione. Egli non parla il linguaggio del diritto, parla il linguaggio della forza armata indispensabile a costituire ogni Stato, parla il linguaggio della crudeltà necessaria all'inizio dello Stato, parla il linguaggio di una politica senza religione che deve a ogni costo utilizzare la religione, di una politica che deve essere morale ma per poterlo non essere, di una politica che deve rifiutare l'odio ma ispirare paura, parla il linguaggio della lotta tra le classi e quanto al diritto, alle leggi e alla morale le mette al loro posto, subordinate. (...) [Machiavelli è] un uomo che, ben prima che tutti gli ideologi abbiano ricoperto la realtà delle loro storie, è capace non di vivere, non di supportare, ma dipensare la violenza del parto dello Stato. Da qui, Machiavelli getta una luce vivida sugli inizi della nostra epoca: quelli della società borghese. Egli getta anche una luce vivida (...), attraverso l'ipotesi al contempo necessaria ma impensabile che lo Stato nuovo possa cominciare in qualunque luogo, sul carattere aleatorio della formazione degli Stati nazionali>>[19].
In particolare e con una rilevanza specifica per l'ambito filosofico (anche se Althusser non svolge questa sua intuizione fino in fondo), Machiavelli
<<è il teorico della novità solo perché è il teorico degli inizi, dell'inizio [commecement]. (...) La novità dell'inizio colpisce così doppiamente gli uomini: attraverso il contrasto tra il prima e il dopo, tra il nuovo e il vecchio, attraverso la loro opposizione e il loro carattere incisivo, attraverso la loro rottura. (...) Cosa comincia con lui? "Una conoscenza vera della storia... la conoscenza dei Principi", dell'arte di governare e di fare la guerra, in breve tutto ciò che è classico designare come la fondazione di una scienza positiva, la scienza della politica>>[20].
Il Principe è visto come un <<Manifesto politico>>
che mira a produrre un nuovo inizio inserendosi in una congiuntura determinata
e, affinché ciò avvenga, <<bisogna che la teoria che
enuncia sia non solo enunciata dal Manifesto, ma da esso situata nello spazio
sociale dove interviene e dove pensa>>[21].
La prospettiva esposta nella dedica del Principe, assume allora per
Althusser un significato particolare, perché affermare che <<a
conoscere bene la natura de' populi bisogna esser principe, et a conoscere
bene quella de' principi bisogna esser populare>>, vuol dire identificarsi
con la parte popolare[22] e <<invocare
il popolo significa invocare la lotta, che è una lotta di classe
del popolo contro i grandi>>[23].
Ora, secondo Althusser, <<non c'è nessun altro mezzo per
un intellettuale "d'essere popolo" che diventarlo attraverso l'esperienza
pratica della lotta di questo popolo>>[24]:
così ha fatto Machiavelli, ma così hanno fatto anche Marx
e Engels (vedi il cap. 4 di Marx nei suoi limiti)[25].
Ma, in Machiavelli, c'è anche altro.
Nella Soutenance d'Amiens (1975), Althusser aveva evidenziato che
<<la regola di metodo, raramente enunciata, ma sempre praticata>>
da Machiavelli
<<è che bisogna pensare agli estremi, cioè in una posizione nella quale si enunciano delle tesi-limite, nella quale, per rendere possibile il pensiero, si occupa il posto dell'impossibile. (...) Per cambiare qualcosa nella storia del suo paese, dunque nella mente dei lettori, che egli vuole provocare a pensare per volere, Machiavelli spiega, copertamente, che bisogna contare sulle proprie forze, cioè nel caso specifico, non contare su niente, né su uno Stato né su un Principe esistente, ma sull'impossibile inesistente: un Principe nuovo in un Principato nuovo>>[26].
Machiavelli è dunque chiamato in causa da Althusser in quanto la sua pratica filosofica-e-politica[27] può dare indicazioni utili per agire nella congiuntura, non perché i contenuti del suo pensiero possano essere attualizzati né perché in esso giaccia depositato un sapere immutabile, sempre valido, al di là dei tempi. Machiavelli, infatti,
<<è il primo teorico della congiuntura o il primo pensatore che abbia, consciamente, se non pensato il concetto di congiuntura, se non fatto del concetto di congiuntura l'oggetto di una riflessione astratta e sistematica, almeno costantemente, in modo insistente e estremamente profondo, pensato nella congiuntura, cioè nel suo concetto di caso singolare aleatorio. Cosa significa pensare nella congiuntura? (...) Significa, innanzitutto, tener conto di tutte le determinazioni, di tutte le circostanze concrete esistenti, facendone il censimento, la deduzione [décompte] e la comparazione. (...) La congiuntura non è, dunque, il semplice rilevamento dei suoi elementi, l'enumerazione delle diverse circostanze, ma il loro sistema contraddittorio, che pone il problema politico e indica la sua soluzione storica, facendone ipso facto un obiettivo politico, una sfida pratica>>[28].
Ciò che di Machiavelli è vivo, è il suo modo di
rapportarsi politicamente alla crisi. La riflessione machiavelliana
a cui Althusser chiede soccorso è, infatti, tutta intrisa del problema
<<de' principati al tutto nuovi>> (Principe, VI) a cui
corrisponde, specularmente, <<in che modo nelle città corrotte
si potesse mantenere uno stato libero essendovi; o, non vi essendo, ordinarvelo>>
(Discorsi, I, XVIII). La questione che colpisce Althusser sembra,
dunque, esser quella di un agire politico che parte da una situazione di
decadenza e di corruzione, che è quanto di più lontano si
possa dare dalla meta cui si vorrebbe giungere. La regola machiavelliana
consiste nel cercare di occupare "il posto dell'impossibile" e
per fare ciò bisogna sapere che non si può "contare su
niente", ma solo "sull'impossibile inesistente", perché
nulla di quanto esiste è utilizzabile per raggiungere lo scopo. In
altri termini, c'è bisogno di una discontinuità radicale tra
il presente e il futuro e nessuna forma progressiva può portare dall'uno
all'altro (come vorrebbe invece l'illusione riformista).
Machiavelli professa un <<materialismo derivato da Epicuro>>
e la sua è <<"una filosofia dell'incontro", la sola
filosofia materialista di tutta la storia della filosofia>>[29]. Il riferimento all'atomismo, che Althusser
svilupperà in modo particolare in alcuni scritti degli anni Ottanta,
nei quali Machiavelli gioca un ruolo determinante[30],
porta con sé il riferimento a un sistema filosofico in cui le nozioni
di "novità" e di "rottura" possiedono una declinazione
particolare, in relazione allo statuto ontologico degli atomi e della loro
relazione attraverso e con il vuoto.
Quando Althusser afferma che il "principe nuovo" non deve "contare
su niente" (ossia su nulla di ciò che esiste, ma solo sulle
sue forze) e dunque deve <<partire da niente>>[31],
non significa certo ex nihilo, ma nemmeno, come vorrebbe Negri, <<in
assenza di tutte le condizioni della novità. O, meglio, in assenza
di tutte le condizioni di possibilità>>[32],
perché, se così fosse, ci sarebbe puro volontarismo[33]: ideazione e realizzazione di un progetto.
Il "niente" a cui fa riferimento Althusser è il vuoto,
l'occasione, in termini machiavelliani, ossia quanto vi è sempre
di indeterminato all'interno delle situazioni, che non sono altro che i
campi sempre aperti di tensione e di incontro-scontro tra forze determinate,
dato che <<sendo tutte le cose degli uomini in moto, e non potendo
stare salde>> (Discorsi, I, VI) mutano incessantemente. Il
"principe nuovo" è colui che sa inserirsi attivamente in
questi interstizi agendoli in vista del proprio fine. Egli, dunque,
non ritiene che la congiuntura, la situazione, sia definita esclusivamente
dall'esistente, che diventerebbe l'insieme delle condizioni del suo agire,
ma che sia composta dagli esseri e dal vuoto, unitamente: determinata e
indeterminata al contempo; vincolata ad alcune presenze e, allo stesso tempo,
svincolata da esse; obbligata e libera, contemporaneamente. La difficoltà
dell'agire politico principesco sta, dunque, nel tener conto delle condizioni
senza farsi condizionare del tutto da esse; sta nell'agire nel vuoto con
la massima libertà, ma tenendo presenti le linee di forza che caratterizzano
una situazione pur senza costituirla interamente. Insomma, il principe ha
sempre a che fare con una componente della realtà ambigua e aleatoria:
la fortuna, in termini machiavelliani (ma, in Althusser, andrebbe misurata
a quest'altezza anche l'influenza di Nietzsche[34]).
Solo <<se la fortuna si congiunge alla sua virtù, potrà
riuscire>>[35], ma quest'incontro
tra occasione e volontà è del tutto aleatorio, imprevedibile,
non progettabile, come il caso di Cesare Borgia dimostra (cfr. Principe,
VII). L'assenza di condizioni, dunque, non è assoluta, ma relativa
a quelle che dovrebbero garantire la riuscita dell'agire.
Il vuoto non esiste senza il pieno degli atomi e dei loro aggregati (l'essere
e gli esseri), ma l'inizio del nuovo è sempre nel vuoto: senza
garanzie, senza assicurazioni, senza fondamenti, ma solo nel conflitto
(unione-disunione). Il fondatore, dunque, fonda sul vuoto e nel vuoto, cercando
di provocare lo scontro delle realtà esistenti, al fine di distruggerle
o accorparle (nel Principe, ad es., i principati "al tutto nuovi"
e quelli "misti") per edificarne una nuova, ben consapevole
della natura aleatoria (e dunque, secondo il materialismo atomistico, composita)
delle stesse realtà esistenti che lo circondano. La fondazione del
fondatore, dunque, è senza fondamento. Ma, se è
così, è anche senza soggetto, perché il soggetto
o i soggetti sono solo una delle componenti di una situazione e si trovano
in una condizione di radicale uguaglianza gli uni con gli altri, visto che
la fortuna è <<arbitra della metà delle azioni nostre,
ma che etiam lei ne lascia governare l'altra metà, o presso,
a noi>> (Principe, XXV). Ciò, ovviamente, non significa
che non vi siano 'soggetti' (forze, gruppi, individui, ecc.) che agiscono
in ogni congiuntura, ma solo che la loro pluralità è costitutiva
(la differenza cioè è ciò che li costituisce sia in
quanto singoli sia in quanto molteplici unità) e non possono essere
ricondotti a un fondamento unitario[36].
L'impossibilità del fondamento e del soggetto, dunque, non è
altro che il segno dell'ineliminabile storicità della realtà,
del suo incessante divenire e dell'indisgiungibilità, in essa, di
ragione e disragione: ecco la <<verità effettuale della cosa>>
anziché l'<<immaginazione di essa>> (Principe,
XV): <<la formula>> che, secondo Althusser, <<consacra
l'inizio e la rottura>> portati da Machiavelli[37].
Se in questo processo senza fondamento e senza soggetto possa scorgersi
una teoria machiavelliana della rivoluzione mi pare altamente improbabile,
ma quest'impossibilità è forse foriera di qualcosa di davvero
nuovo, che fatichiamo ancora a capire. La rottura, infatti, per quanto
radicale non è il taglio nel continuum dell'essere (concezione
che manifesta tutta la propria dipendenza da Aristotele e dall'aristotelismo),
ma la capacità di inserirsi nel vuoto, che da sempre è al
cuore degli esseri, per fare leva sull'esistente al fine di scardinarlo.
Nell'atomismo classico, insomma, l'essere (l'a-tomo) è proprio ciò
che non è ulteriormente frazionabile, mentre gli esseri possono essere
dissolti, disgregati, spaccati proprio perché non sono continui,
ma composti (dagli atomi e dal vuoto). Costruire ('fondare') qualcosa sull'essere
e nel vuoto non vuol dire soltanto esporlo a una precarietà senza
garanzie né tutele che lo rassicurino (e dunque non fondarlo)[38], ma anche l'impossibilità di
una fondazione palingenetica che si immagini e pretenda di essere un inizio
assoluto: come eterno è il cosmo, per l'atomismo nulla mai
comincia dal nulla o in assoluta indipendenza dall'esistente[39]:
altra cosa è dire che quanto inizia in forma nuova si distacchi o
prenda distanza da quanto lo precede (metta cioè del vuoto tra sé
e gli altri). In questo caso, l'evento riconosce il suo debito col passato
(il che non implica storicismo alcuno, ossia che il presente sia interamente
inscritto nel passato, tutto ostensibile a partire dalle cause che lo producono)
e, al contempo, anche la sua irriducibilità a esso, la sua novità.
E questo proprio per la logica delle dinamiche aleatorie che lo definiscono.
Incontri e scontri, mutamenti e conservazioni, rotture e continuità,
movimento e quiete, sono fenomeni contemporanei e indisgiungibili per ogni
teoria atomistica: avvengono continuamente, con radicalità diverse,
impatti differenti, tempi multipli, velocità variabili. Come può
darsi in un orizzonte di questo tipo qualcosa come una teoria della
rivoluzione? Semmai si potrebbe dare, forse, una teoria delle rivoluzioni,
infinite, indeterminate, mai definitive: tagli negli esseri come esiti degli
scontri, dei conflitti, tra gli atomi e tra i loro aggregati; apocalissi
quotidiane e palingenesi di ogni istante, per quanto di portate assai diverse.
Ciò non significa affatto rinunciare alla possibilità del
cambiamento né alla sua radicalità, significa però
rinunciare all'aut-aut tra continuità e discontinuità
(ossia alla forma semplice della contraddizione, quella hegeliana, che corrisponde
alla sua veste ideologica). Per ogni atomismo, l'alternativa tra continuità
e discontinuità è del tutto falsa, perché il cosmo
è eternamente fratto (atomi e vuoto) e in continuo movimento (composizione-scomposizione
di atomi e di aggregati atomici): la sua unica costante è l'eterno
mutamento. Che una prospettiva di questo genere non significhi l'equivalenza
di tutto con tutto è fin troppo evidente: la qualità dei corpi
è diversissima e la lotta non è inutile né ininfluente,
ma essa deve fare i conti con la necessità delle forze: l'essere
(gli atomi), gli esseri e il vuoto. L'uomo trova qui il suo spazio, quello
dell'agire e del conoscere, ma non la sua onnipotenza: la sua intelligenza
è forza tra le forze, ma il suo essere è aleatorio quanto
tutto ciò che esiste come composto[40].
Il problema attorno al quale pare ruotare l'interesse althusseriano per
Machiavelli è quello di una rottura che connetta novità (in
senso machiavelliano) e inizio:
<<La novità non può che trovarsi alla superficie delle cose, non può che riguardare un aspetto delle cose e svanire assieme al momento che l'ha prodotta. L'inizio, al contrario, è, se si può dire così, radicato nell'essenza di una cosa, dato che è l'inizio di questa cosa: esso concerne tutte le due determinazioni, non passa con l'istante, ma dura con la cosa stessa. (...)>>[41.]
E finché la cosa dura. Machiavelli stesso è, per Althusser, questa "rottura", perché con lui inizia la scienza della pratica politica in quanto tale (un realismo politico che, però, non solo comprende al proprio interno la necessità dell'ideologia, ma è anche un realismo dell'impossibile, che attraverso l'immaginazione tenta di modificare i parametri di ciò che comunemente viene ritenuto possibile nell'orizzonte politico dato e, dunque, cerca di mutarne i limiti) e non il suo studio ideale, morale, religioso o d'altro tipo ancora: <<"la verità è sempre concreta", realizzata all'interno di forze concrete, effettiva, ed è perché è effettiva che è efficace>>. Questa scienza però si traduce in modalità diverse da quelle classiche, nelle quali <<l'universale regna sul singolare>>, perché ciò che interessa Machiavelli, invece, è <<"la verità effettuale della cosa", della cosa nel suo essere singolare, la singolarità del suo "caso">>[42]. Pensare nella congiuntura, infatti, significa non solo tener conto di tutte le circostanze che concorrono alla formazione di una situazione, ma soprattutto significa coglierne la contraddittorietà: è il contrasto tra le forze in campo che genera la congiuntura e, con essa, il suo necessario problema politico. Ma lo scontro che rende reale la congiuntura è possibile solo per la presenza del vuoto ed è appunto in esso che consiste lo spazio del 'soggetto': solo installandosi nel vuoto della congiuntura sarà possibile agire politicamente, ossia confliggendo con le forze in azione. Ma posizionarsi nel vuoto, vuol dire posizionarsi in un non-luogo, quindi in una posizione impossibile. Solo assumendo il rischio di quest'impossibilità si dà vita all'agire politico, perché solo così, collocandosi in un "impossibile inesistente", si origina lo spazio di una pratica politica possibile[43]. U-topia in Machiavelli non è l'immaginazione di un ideale o di un dovere (morale o religioso) che dia forma allo stato, ma il tentativo di pensare l'impensabile in quanto unico luogo-non-luogo dell'agire politico, perché in grado di dar vita a un processo di soggettivazione, inevitabilmente plurale[44]. Pensare l'impensabile o "l'impossibile inesistente", dunque, è una pratica teorica, ma anche una pratica politica:
<<giustamente il punto che il Principe Nuovo o il Principe Moderno richiedono non può essere un punto fisso: innanzitutto, non c'è un punto assegnabile nello spazio, perché lo spazio della politica non ha punti e non è uno spazio se non per mezzo di figure: esso ha tutt'al più dei luoghi, dove gli uomini sono raggruppati sotto determinati rapporti. E, supposto che questo luogo sia un punto, non sarà comunque fisso, ma mobile, meglio ancora instabile nel suo stesso essere dato che ogni suo sforzo deve tendere a darsi l'esistenza: non un'esistenza passeggera, quella di un personaggio o di una setta, ma l'esistenza storica, quella di un monarca assoluto o di un partito rivoluzionario. Ne concludo che ciò che rende così differente lo spazio della pratica politica dallo spazio della teoria, è di essere, una volta sottoposto all'analisi della congiuntura, che pone il problema politico "all'ordine del giorno" (come dice Lenin), rimaneggiato nella sua modalità e nel suo dispositivo dall'esistenza di questo luogo vuoto, in quanto luogo da riempire, e che il "soggetto" (l'agente) della pratica politica, Principe o partito, deve occupare>>[45].
Se, come sostiene Negri, <<pensare il nuovo nel vuoto di ogni condizione>>
significa due cose: innanzitutto, <<rinversare il punto di vista tradizionale
della filosofia, ossia la presunzione di pensare il reale>> (come
se il pensiero fosse un suo raddoppiamento oggettivo, epistemologico e idealistico)
e, in secondo luogo, <<pensare col corpo>>[46],
allora una delle radici di ogni materialismo, forse la principale, è
da cogliere proprio nel fatto che siano i corpi a precedere il pensiero,
a generarlo e a condizionarlo, per quanto poi possano esserne a sua volta
influenzati[47]. La politica, quando c'è,
ha una specificità: che è quella di passare per il legame-discorso
dello stato di cose esistente (la sua ideologia), senza però
farsene condizionare, anzi dissolvendolo, <<perché si costruisce
sull'ipotesi verificabile che nessuno è schiavo, nel suo pensiero
e nei suoi atti, del legame che gli impone di stare, al suo posto, interessato>>[48]. La politica ha dunque a che fare con
lo slegamento delle parti, ossia con l'esigenza di disfare l'illusione dell'indissolubilità
del loro legame, come se questo non fosse sempre casuale e contingente,
ma naturale e necessario. Lo scopo di ogni politica, quando c'è,
dunque, è la rescissione della pretesa naturalità di ogni
legame imposto dallo Stato[49]: cioè,
critica materiale (concreta, effettiva) dell'ideologia, che ha sempre <<un'esistenza
materiale>>[50].
È per questo che, tra i saperi, essa è quella che più
da vicino interroga la filosofia ponendo la seguente domanda: come si può
pensare la politica?, secondo quale 'logica'?, visto che il logos
di ogni leghein implica che si scelga (che si raccolga
dopo aver contato) e, dunque, che, contemporaneamente, anche si s-leghi?
Il cerchio sembra chiudersi, ma solo in apparenza e non solo perché
riporta a una domanda fondamentale della filosofia. La pratica politica
fondamentale per rigenerare il marxismo e il comunismo dovrebbe essere una
pratica teorica che cerchi, nuovamente, di pensare l'impensabile, tenendo
conto del carattere aleatorio della storia. Questa esigenza, che emerge
dai caratteri della congiuntura sopra descritti è, però,
in Althusser, ulteriormente circoscritta: essa si radica attorno al fatto
che è la politica stessa a essere ormai impensabile, perché
fagocitata dall'abbraccio mortifero tra partito e Stato: il primo, infatti,
<<è una creazione post-mortem della Rivoluzione d'Ottobre e la Rivoluzione d'Ottobre è, su questo punto, una chiusura e non un'apertura. D'altra parte, il partito è impensabile perché i partiti, come organizzazioni politiche, cessano d'esistere con la guerra del 1914, nella quale si opera l'estinzione [péremption] dei partiti di classe a vantaggio dello Stato del popolo intero, che è un'entità nuova in rapporto agli Stati della metà del XIX secolo. Il fenomeno di maggior rilevanza, da allora, sarà la sussunzione della politica allo Stato e la figura del partito, dopo la guerra del '14, sarà interamente normata, che sia parlamentare o comunista, dalla questione dello Stato>>[51].
Con la cosiddetta "mobilitazione totale", i partiti diventano
il punto più alto della sussunzione della politica allo Stato e dunque
la ragione dell'impensabilità della politica. Ecco perché,
allora, liberarsi dal Partito equivale a liberarsi dallo Stato, ossia da
questo Partito e da questo Stato (per quanto Althusser, e
Rancière non cessò di rimproverarglielo, sia rimasto iscritto
al Partito dal 1948 al 1980)[52]. La necessità
di rilanciare la parola d'ordine della "dittatura del proletariato"
(vedi più oltre almeno il cap. 11) sta tutta qui, a patto che la
si sappia far andare in una direzione diversa da quella a cui ha condotto
nell'esperienza storica postrivoluzionaria, durante la quale ha assunto,
per un certo tempo (prima di essere abbandonata) le forme organizzative
e ideologiche della borghesia, vanificando così la sua teorica funzione
mediatrice. Il rapporto tra scienza e storia è solo uno di questi
debiti, ma ricopre un ruolo decisivo nel pensiero althusseriano.
La stessa autocritica, a cui Althusser aveva sottoposto la sua prima impostazione
filosofica (con particolare riferimento a Pour Marx e a Lire le
Capital), ritenendola viziata da una <<deviazione teoricista>>
dovuta alla volontà di <<difendere il marxismo contro le minacce
reali dell'ideologia borghese>> attraverso la dimostrazione
che esso <<ha potuto svilupparsi, in Marx e nel Movimento operaio,
solo a condizione di una rottura radicale e continua con l'ideologia borghese>>,
sembra rispondere all'intento di emendarla dai residui idealistici (hegeliani
e, dunque, per lui, borghesi) che ancora vi si annidavano. Per quanto la
tesi fosse giusta e sia giusta (scrive Althusser), l'errore stava nell'aver
ridotto <<questo fatto storico>> nei <<limiti di
un fatto teorico: la "rottura" epistemologica osservabile
nelle opere di Marx a partire dal 1845>>, col risultato di trovarsi
invischiati <<in un'interpretazione razionalista della "rottura">>[53].
Il problema non consiste tanto, ovviamente, nel rifiutare il razionalismo,
quanto di tener presente accanto a esso il fatto che la scienza iniziata
da Marx, la scienza della storia, nasce anche <<dal concorso
imprevedibile, incredibilmente complesso e paradossale, ma necessario nella
sua contingenza, di "elementi" ideologici, politici, scientifici
(dipendenti da altre scienze), filosofici, ecc., che, a un certo punto,
"scoprono", ma a cose fatte, che si stavano cercando,
dato che si incontrano senza riconoscersi nella figura teorica di una scienza
nascente>>[54]. Nello specifico,
Althusser, si oppone così alla concezione della storia basata sul
<<rovesciamento>>, ossia sulla dialettica "semplice",
che, se ipostatizzata a unica figura della relazione, <<porta e obbliga
all'idealismo speculativo>>[55].
La figura dell'incontro (rencontre) dovrebbe servire appunto per
superare la riduzione dialettica della storia e rendere conto della sua
complessità, riconoscendovi elementi razionali e/o razionalizzabili
accanto a combinazioni aleatorie, la cui razionalità può,
forse e non sempre, essere ricostruita solo a posteriori. Insomma, si tratta,
in termini machiavelliani, di riconoscere la presenza di evenienze imprevedibili
e indeterminabili, che vengono poste, nominalisticamente, sotto il nome
di fortuna: caso, alea. La storia dovrebbe, dunque, essere il frutto
dell'incontro tra ragione e fortuna, tra scienza e caso.
Marx e Engels avevano cercato di fuggire all'idealismo hegeliano attraverso
il materialismo storico, ossia identificando nella struttura produttiva
l'elemento che determinava, in ultima istanza, i rapporti politici,
culturali, giuridici, ecc., tra gli esseri umani, ossia la sovrastruttura.
La limitazione è molto importante e non significa certo, come dice
Engels nella lettera a J. Bloch del 21 settembre 1890, che <<il fattore
economico sarebbe l'unico fattore determinante. (...) La situazione
economica è la base, ma i diversi momenti della sovrastruttura (...)
esercitano pure la loro influenza sul corso delle lotte e in molti altri
casi ne determinano la forma in modo preponderante>>. Da qui Althusser
ricava una lezione decisiva e cioè che
<<l'ultima istanza è appunto l'ultima istanza. Se essa è l'ultima, come nell'immagine giuridica che la sostiene, vuol dire che ce ne sono altre, quelle che si trovano nella sovrastruttura giuridico-politica e ideologica. Parlare di ultima istanza nella determinazione ha quindi una doppia funzione: separa radicalmente Marx da ogni meccanicismo e apre nella determinazione il gioco di differenti istanze, il gioco di una differenza reale nella quale si inscrive la dialettica. (...) Significa allora che la determinazione in ultima istanza per mezzo della struttura economica non si può pensare che all'interno di un tutto differenziato, dunque complesso e articolato (la Gliederung), dove la determinazione in ultima istanza fissa la differenza reale delle altre istanze, la loro autonomia relativa e il loro specifico modo di essere efficaci sulla struttura stessa>>[56].
Le conseguenze di questo ragionamento sono tali da cambiare <<i
riferimenti entro i quali si pensa la contraddizione>>, che non può
più essere pensata come <<contraddizione semplice>> (quella
logica, <<che oppone due entità uguali, semplicemente contrassegnate
da caratteristiche contrarie, + o ->>, cioè quella hegeliana),
ma come <<contraddizione surdeterminata>>, ossia come risulta
dal Capitale, una contraddizione <<ineguale>>, perché
mette in gioco dei <<contrari (...) che sono presi dentro un rapporto
di disuguaglianza, che riproduce continuamente le sue condizioni di
esistenza attraverso questa stessa contraddizione (...) anziché toglierle
nel superamento e nella bella riconciliazione hegeliana>>[57]. Tale ineguaglianza è data dalle condizioni
materiali che producono la contraddizione, che, perché diventi <<"attiva",
principio di rottura, abbisogna di un'accumulazione di "circostanze"
e di "correnti" tali che (...) si "fondano" in
un'unità di rottura>>[58].
È qui già enunciata, in nuce, la necessità di
una teoria dell'incontro che Althusser cercava, oltre che in Marx,
soprattutto in Machiavelli e in quella che egli definì La corrente
sotterranea del materialismo dell'incontro[59].
Il passaggio dalla <<contraddizione surdeterminata>> al <<materialismo
aleatorio>> rappresenta lo svolgimento di uno stesso problema: quello
di spiegare la storia in termini scientifici, con la consapevolezza, però,
che, proprio per questo, non è possibile eludere la presenza inquietante
di dinamiche fortuite, casuali e aleatorie, accanto a quelle (talvolta sottovalutate
dalla tradizione marxista) che fanno capo, genericamente, alla sovrastruttura
(ideologia)[60] e al rapporto tra produzione
e riproduzione.
Se questa problematica è già presente in Marx e nei primi
scritti di Althusser[61], è solo
negli ultimi però, dopo l'evento luttuoso del 1980, che Althusser
sembra assumere pienamente l'onere di pensare l'ineluttabile presenza del
caso nella storia e che l'aleatorietà diventa il segno dell'assenza
di teleologia (ma non di progresso) in essa e, dunque, il ruolo determinante
dei conflitti e delle lotte, che evidenziano la possibilità di un'interpretazione
di Marx e del marxismo che rifiuti le letture storicistiche, meccanicistiche
e deterministiche in genere.
Marx nei suoi limiti, però, sembra ancora preso nel tentativo
di mettere a fuoco "cosa s'è rotto" e la diagnosi proposta
riguarda proprio il rapporto tra struttura e sovrastruttura, tra base economica
e ideologia. Lo Stato, per schematizzare, ha ormai assorbito non solo i
partiti, ma anche la "società civile". Questa distinzione,
ancora fondamentale in Hegel e già criticata da Marx[62],
si rivela ormai in tutta la sua illusorietà (e qui sta anche, per
Althusser, il necessario superamento di Gramsci e della sua idea di "egemonia":
si veda il cap. 20 della traduzione). Non solo lo Stato è l'espressione
della società civile e, dunque, dei rapporti di produzione e di sfruttamento
che la caratterizzano (lo Stato è lo strumento attraverso
il quale la classe dominante cerca di perpetuare il suo potere), ma esso,
nel suo progressivo affinamento dei mezzi di dominio, ha ormai asservito
l'intera società (e non solo la parte di cui era espressione) per
mezzo dei suoi apparati ideologici. Non vi è più quasi nulla
che vi si sottragga, se non in qualche interstizio (vuoto) e l'unica
forma possibile di comunismo è la costruzione di forme di vita che
prescindano da rapporti mercantili[63].
Il passaggio (magari semplicemente dialettico) al socialismo è
ormai del tutto anacronistico.
È in questa stretta drammatica del presente (la fine degli anni Settanta)
che Althusser comincia a indagare il "materialismo aleatorio"
di matrice atomistica, dove il clinamen poteva offrire, al contempo,
lo spunto per una dolorosissima riflessione autobiografica[64],
ma anche quello per una discesa negli inferi della storia e della sua necessità
senza legge. L'onnipervadenza del capitalismo non lascia spazio ad alternative
che non siano tentativi di rotture, multiple, plurali, aleatorie,
improvvise, singolari e collettive, come "prendere il treno in corsa"
che, prima di essere uno dei tratti del filosofo materialista, è
metafora usata da Althusser per criticare il progressismo di Marx a proposito
<<della serie ordinata: comunismo primitivo, schiavismo, servitù,
capitalismo e comunismo>> che ogni società dovrebbe percorrere
in tutta la sua interezza, senza eccezioni[65].
Ma questa è, per Althusser e per noi, un'altra storia, forse ancora
da scrivere, forse ancora a venire. Una storia intessuta non solo dalla
ricerca delle cause della determinazione della coscienza da parte delle
condizioni materiali di produzione (Marx) e dello Stato da parte delle forme
della coscienza (Lenin), ma soprattutto dalla relazione tra Stato e ideologia,
anche quella della classe operaia.