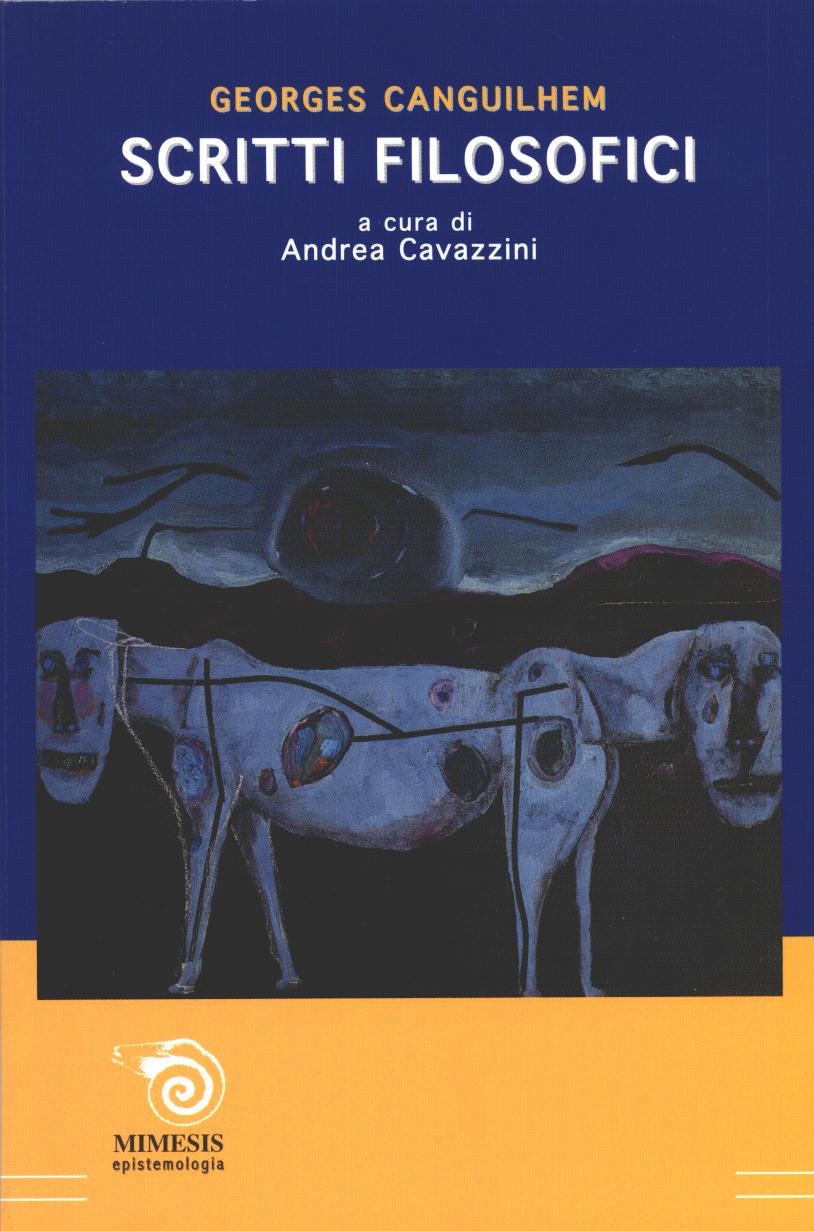 |
Georges Canguilhem Scritti filosofici |
Per una filosofia critica.
Lettura di Georges Canguilhem.
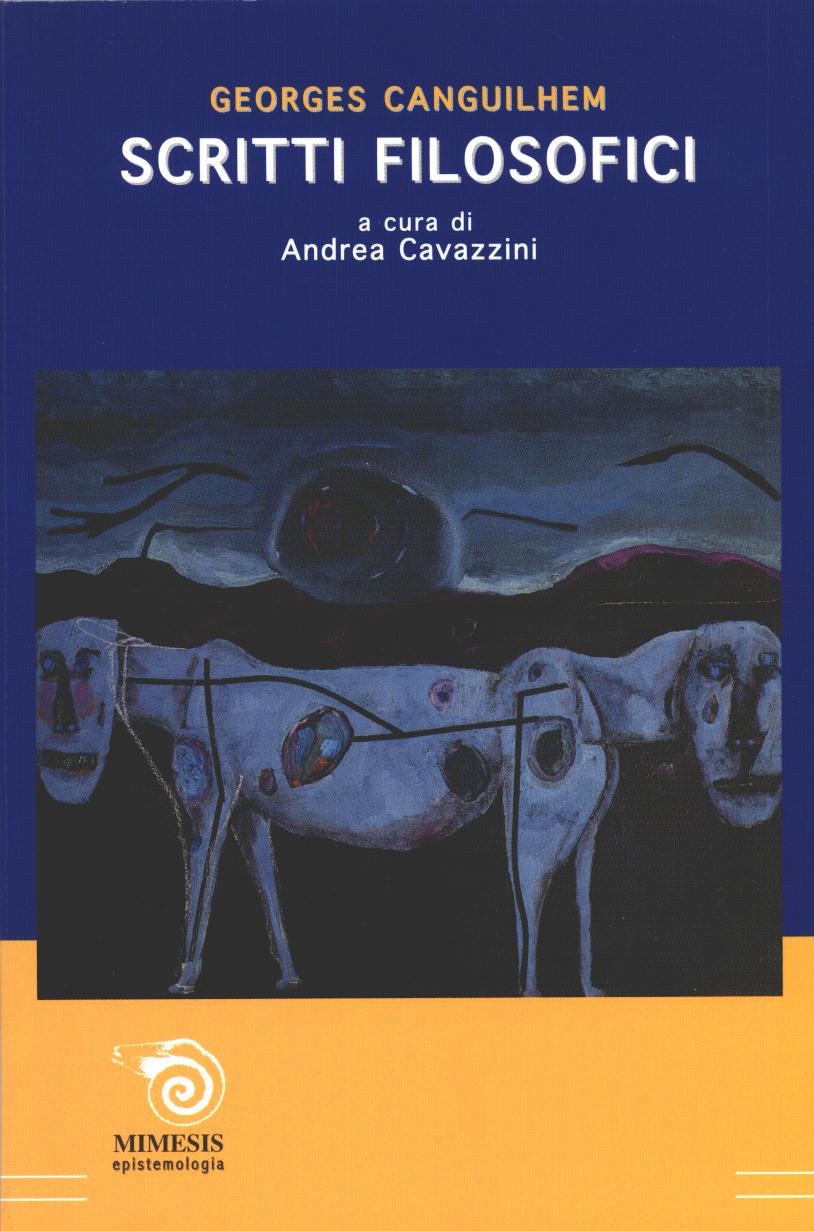 |
Georges Canguilhem Scritti filosofici |
Per una filosofia critica.
Lettura di Georges Canguilhem.
1) Il Soggetto e l'Esistenza
Nel suo opus maximum, Il Normale e il Patologico, Georges
Canguilhem critica la tesi di Auguste Comte e François-Joseph Broussais
secondo cui gli stati patologici non sono che alterazioni quantitative -per
eccesso o difetto- dei corrispondenti stati fisiologici. Dei due autori,
viene stigmatizzata: <<la vaghezza delle nozioni di eccesso e di difetto,
il loro implicito carattere qualitativo e normativo, a stento dissimulato
sotto la loro pretesa metrica. È in relazione a una misura giudicata
valida ed auspicabile -e dunque in relazione ad una norma- che sussiste
eccesso o difetto. Definire l'anormale mediante il troppo o il troppo poco
significa riconoscere il carattere normativo dello stato cosiddetto normale.
Questo stato normale o fisiologico non è più soltanto (...)
un fatto, bensì la manifestazione di un riferimento a un qualche
valore. Quando Bégin definisce lo stato normale come quello in cui
"gli organi agiscono con tutta la regolarità e l'uniformità
di cui sono suscettibili", non possiamo esitare a riconoscere che un
ideale di perfezione, a dispetto dell'orrore che a Broussais ispirava qualunque
ontologia, aleggia su questo tentativo di definizione>>[1].
Ciò che Broussais e Comte cercano di far passare per la determinazione
di un dato oggettivo, impersonale, quindi per un puro fatto constatabile,
in realtà veicola una posizione di valore, un sistema di preferenze,
forse anche di fantasmi, morali, politici, ed estetici, incentrati sul privilegio
accordato all'ordinato, al regolare, al simmetrico e armonioso. Il fatto,
la presunta "normalità" oggettivamente constatabile, è
in realtà un valore; e, come tale, ha uno statuto ]polemico:
esso non mira a vedere una norma nelle cose stesse, già data come
tale, ma ad instaurarla, a perorarne la validità. È polemico
nei confronti di ciò che è irregolare, anomalo[2],
stridente con l'anelito ad una realtà levigata e "in ordine".
Sintomo del carattere assiologico e non fattuale del concetto di normale
è il linguaggio unicamente qualitativo usato da Comte e Broussais
per esprimerlo. Ed infatti questo linguaggio è solo espressivo: comunica
preferenze e valori, ma non indica dati di fatto, non circoscrive un campo
di applicazione definito, una sfera delimitata di fenomeni. Per questo scopo,
gli manca quell'obiettività garantita dal linguaggio specialistico
e quantitativo delle scienze: <<L'ambizione di rendere la patologia,
e di conseguenza la terapeutica, interamente scientifiche, facendole procedere
semplicemente da una fisiologia preventivamente istituita, avrebbe senso
soltanto se fosse possibile innanzitutto fornire una definizione puramente
oggettiva del normale come di un fatto, e se, inoltre, fosse possibile tradurre
ogni differenza tra lo stato normale e lo stato patologico nel linguaggio
della quantità, giacché solo la quantità può
rendere conto ad un tempo dell'omogeneità e della variazione>>[3].
Questo programma è stato realizzato, nell'Ottocento, da Claude Bernard,
anche lui sostenitore della riduzione del patologico al fisiologico: <<A
differenza di Broussais e Comte, Bernard reca, a sostegno del proprio principio
generale di patologia, argomenti controllabili, protocolli di esperienze
e soprattutto metodi per la quantificazione dei concetti fisiologici. Glicogenesi,
glicemia, glicosuria, combustione degli alimenti, calore da vasodilatazione
non sono più concetti qualitativi, bensì sintesi di risultati
ottenuti in seguito a misurazioni. D'ora in avanti, quando si afferma che
la malattia è l'espressione esagerata o ridotta di una funzione normale
si sa esattamente cosa si intende>>[4].
Bernard dà alla fisiologia una rigorosa obiettivazione, la rende
sperimentale e quantitativa, le fornisce un vocabolario tecnico e non equivoco:
tutto bene allora? Siamo saltati nel regno della scienza, lasciandoci alle
spalle le ossessioni armonicistiche di Comte? Le cose, secondo Canguilhem,
sono un po' più complesse: <<Come lo stato patologico è
"il disordine di un meccanismo normale, consistente in una variazione
quantitativa, un'esagerazione o un'attenuazione dei fenomeni normali"
(Bernard 1877, p. 360), così lo stato morboso è costituito
dall' "esagerazione, la sproporzione, la disarmonia dei fenomeni normali"
(Bernard 1876, p. 391). Chi non vede qui che il termine "esagerazione"
ha un senso nettamente quantitativo nella prima definizione, e un senso
piuttosto qualitativo nella seconda?>>[5].
Dunque Bernard reimmette il proprio linguaggio obiettivo, specialistico,
nel circuito dell'espressione linguistica di valori, significati qualitativi
e concezioni del mondo; ma per Canguilhem questo fatto non lo si deve ad
un residuo o ad un ]deficit del rigore critico bernardiano. Al contrario,
il riemergere di un linguaggio pregno di opzioni assiologiche (anche qui,
in favore dell'ordine) dalla più rigorosa obiettivazione è
sintomo di una necessità ineliminabile: la necessità in base
alla quale, nei discorsi sulla vita ed i suoi differenti stati, sempre si
manifesta il carico di significato e di valore che possiedono tali stati
per il soggetto vivente, in quanto suoi propri stati. Di fronte a
questo momento significativo della conoscenza della vita, il progetto di
obiettivare quest'ultima si rivela un abuso: <<Il problema è
il seguente: il concetto di malattia è il concetto di una realtà
oggettiva accessibile alla conoscenza scientifica quantitativa? La differenza
di valore che il vivente istituisce tra la propria vita normale e la propria
vita patologica è un'apparenza illusoria che lo scienziato è
legittimato a negare?>>[6].
Per quanto Canguilhem mostri che la stessa ricerca fisiologica non conferma
la riducibilità qualitativa del patologico al normale, qui la posta
in gioco è un'altra: essa riguarda i titoli che il soggetto vivente
possiede ad essere il giudice ultimo delle proprie condizioni di vita. Questo
soggetto che vive un'esperienza significativa, che esperisce il valore della
propria vita, e che si ostina a voler fare della propria esperienza il metro
su cui valutare le proprie modalità di esistenza [7],
è il soggetto di cui tutto il saggio di Canguilhem -e forse la sua
intera opera- vogliono perorare la causa. Ma questo soggetto che cerca di
esprimere il proprio "male", il valore negativo della propria
condizione, nel medesimo tempo in cui tenta di affermarne la consistenza
e l'irriducibile realtà (pur negativa), quale linguaggio potrà
mai usare a questo scopo se non quello qualitativo, assiologico, non-obiettivo,
che abbiamo già visto criticato?
È evidente che il senso della critica di Canguilhem a Comte non è
un senso banalmente scientistico, mirante a espungere tout court
i "valori" dall'obiettività. Anche il soggetto malato di
cui Canguilhem si fa portavoce parla il linguaggio dei valori e del "senso
della vita" (in accezione biologica e gnomico-"esistenziale").
In realtà, le colpe di Comte e Broussais ammontano a ciò:
in primo luogo, i valori che essi veicolano nell'uso espressivo dei loro
concetti sono valori repressivi, che tendono a negare in nome dell'Ordine
il diritto del soggetto "deviante" di vedere riconosciuta la specificità
della propria forma di vita e, inscindibile da tale specificità,
il giudizio che egli ne dà, il rilievo assiologico che essa ha per
lui; in ultima analisi, ciò equivale a negare ad ogni soggetto
il diritto di giudicare da sé il valore delle proprie forme di vita,
attribuendo tale diritto ai custodi di una norma sovrimposta.
In secondo luogo, l'operazione di Comte richiede che la differenza tra fatti
e valori sia negata in favore di una in distinzione ambigua: affinché
la norma proposta sia universalmente valida e possa quindi zittire i dissenzienti,occorre
che essa neghi il proprio statuto di opzione polemica in favore dell'Ordine
e si mascheri da fatto, da dato puramente obiettivo. Anche Bernard
è imputabile di un'analoga mistificazione, poiché le procedure
obiettivanti da lui realmente elaborate sono valide nei limiti posti dalle
condizioni di obiettività che ad esse ineriscono, e non possono essere
tradotte indiscriminatamente in un discorso sui valori vitali.
Se Comte trasforma la sua opzione in un fatto, Bernard, che ci dà
la conoscenza di alcuni fatti, li sottrae al loro legittimo ambito di verificabilità
per farne la fonte diretta di un'opzione. In ambedue i casi, la demistificazione
richiede un'operazione critica, che appunto operi il krinein
tra i due registri del discorso: l'obiettività scientifica, sottoposta
a rigorose condizioni di validazione, e l'espressione del senso. Questo
krinein è però operato da un soggetto che utilizza
la distinzione tra i linguaggi per affermare la propria opzione assiologica
; esso vuole mostrare come il discorso che gli negherebbe l'espressione
è espressione di un sistema valoriale contrapposto, e non, come pretenderebbe,
un ordine oggettivo delle cose.
Il discorso qualitativo non è quindi eliminabile; esso è il
luogo del soggetto vivente e cosciente, che in esso afferma i significati
nei quali vive il proprio essere-nel-mondo. Ma questi significati sono portatori
di valori; e non vi è valore senza scontro tra opzioni opposte. Dunque
la funzione del soggetto qualitativo e assiologico è sempre scissa;
quel soggetto è sempre dato in una lotta, cioè nello scontro
tra l'esigenza di affermazione della propria irripetibile autonomia, al
limite della anomalia e dell'erraticità, e quella di razionalizzare
l'estrinseco, di renderlo funzionale ad un Ordine.
Queste due esigenze intrattengono rapporti opposti con il linguaggio non-qualitativo
dell'obiettività scientifica. L'affermazione dell'ordine tende ad
occultare il proprio carattere polemico, vuole apparire obiettiva, e per
questo intrattiene una confusione deliberata tra se stessa ed il registro
dei linguaggi obiettivi delle scienze; l'affermazione della specificità
delle forme di vita invece mira a distinguere tra fatti e valori per poter
esprimere se stessa: le interessa mostrare come i valori repressivi non
coincidano con le "cose stesse", e quindi tende a riconoscere
la specificità sia del registro obiettivo che di quello espressivo,
a delimitare di volta in volta gli usi possibili, i campi di validità
di ambedue i linguaggi. Importante per la seconda esigenza è soprattutto
che il soggetto non possa essere riassorbito nelle cose, che l'istanza giudicante
che esso rappresenta (in primo luogo in merito alle proprie forme di vita)
conservi il proprio statuto di autonomia rispetto al presunto "ordine
oggettivo" della realtà.
Questa autonomia però va interpretata. Il soggetto irriducibile
non è per questo "disincarnato". Non è una pura
capacità di porre valori, i quali sarebbero allora prodotti della
scelta arbitraria ed immotivata del soggetto stesso. Se così fosse,
si avrebbe una dicotomia insuperabile tra le "cose", esaustivamente
conoscibili dai linguaggi obiettivi della scienza, e la soggettività,
fonte originaria di valutazioni "pure" separate da ogni rapporto
con il "reale". Il problema posto da questo esito dicotomico è
il fulcro della "filosofia della vita" di Canguilhem. Si tratta
di radicare l'attività assiologica del soggetto in qualche forma
di passività, senza però che ciò rispetto a cui il
soggetto valutante è passivo possa venir colto dal procedimento aqualitativo
del pensiero scientifico. In altri termini, lo spazio in cui il "senso
della vita" del soggetto -quindi il soggetto stesso- deve essere localizzato
(affinché non si cada nella mistificazione di un "effetto Munchhausen"
assiologico), deve essere unità inscindibile di fatto e valore.
La "vita" del soggetto non può essere né semplicemente
obiettivata, né sublimata in una attività valutante fantasmatica
- il senso che il soggetto esprime in quanto autovalutantesi deve radicarsi
nella passività in cui e di cui il soggetto vive. Se, come si è
detto, gli stati del vivente hanno un valore per lui in quanto "suoi
propri stati", essi dovranno essere caratterizzati, ad un tempo
e inscindibilmente, come "suoi propri" e come "stati
di cose", "stati oggettivi".
Il soggetto attribuisce un valore alla propria forma di vita. Questa facoltà
non è assolutamente libera: si fonda nella vita stessa. Quella forma
di vita cui il soggetto attribuisce un valore positivo (dunque di "normalità")
è una forma capace di ampliare gli orizzonti e le possibilità
del soggetto nel suo rapporto con l'ambiente: <<L'uomo normale è
l'uomo normativo, l'essere in grado di istituire nuove norme, anche organiche.
Una norma unica di vita è sentita come privazione, non come fatto
positivo>>[8]. Ne consegue che patologico
(dunque portatore di un valore negativo) è lo stato del soggetto
che tende a fissare quest'ultimo in un limite insuperabile dei propri orizzonti
di relazione col mondo. Particolare significato assume allora questa discussione
del concetto di invalidità: <<Si nasce o si diventa
invalidi (...) La limitazione forzata di un essere umano a una condizione
unica e invariabile è giudicata negativamente, in riferimento all'ideale
umano normale che è l'adattamento possibile e voluto a tutte le condizioni
immaginabili>>[9]. Non si poteva
rendere più chiaro il fatto che la forma di vita del soggetto è
già in se stessa portatrice del valore e del senso che il soggetto
le attribuisce. Già anzi il termine di "portatrice" rivela
come al soggetto il senso che per lui ha la propria vita sia dato passivamente,
e non liberamente posto. L'irriducibile espressione di valori che definisce
il soggetto è qualcosa che determina il soggetto, non è da
esso determinata, pur non potendo disgiungersi dalla presenza del
soggetto in essa.
La forma patologica di vita è data al vivente, ed esso le è
sottomesso. Tale forma ha l'aspetto di un blocco delle capacità
del vivente di modificarsi e complessificarsi: la patologia è uno
scacco strutturale ed insuperabile che schiaccia l'essere vivente sotto
il peso della ripetizione cieca di condizioni vitali ormai prive di fecondità.
Questo peso, questo "girare a vuoto" delle facoltà del
corpo e della mente, è un fatto, ed anche discretamente "duro",
poiché il soggetto non è libero di pensarne ciò che
vuole: il senso che per lui ha questa forma di vita è intrecciato
ai vincoli posti dalla forma stessa, dai quali soltanto sorge il valore.
Perché appunto questo fatto è anche un valore: che
al vivente siano posti limiti invalicabili è affar suo; il
peso di una forma di vita bloccata nella ripetizione dell'identico, incapace
di maturare e migliorarsi, è qualcosa che non potrà mai essere
descritto in termini puramente obiettivi. Lo stesso vale per l'accrescimento
di capacità, per l'espansione della potenza di agire che caratterizzano
lo stato normale: l'aumento della perfezione, la scoperta di nuove capacità
del corpo e della mente, sono indisgiungibili dalla laetitia del
vivente che entra in nuove relazioni con l'ambiente ed in nuove configurazioni
delle proprie virtualità. Indisgiungibili anche nell'espressione
linguistica, che non può descrivere questi stati senza ricorrere
ad un registro qualitativo.
Questa doppia direzione del pensiero di Canguilhem, verso l'irriducibilità
del senso alle cose, e, d'altra parte, verso il radicamento del valore della
vita nell'essere stesso del vivente, è ciò che riteniamo costituire
il tema dei tre saggi di questo volume. Le problematiche da essi affrontate
trovano composizione in un medio posto tra l'oggettività ed il soggetto:
la vita stessa. Come parlare di essa? Qual è il suo rapporto con
l'obiettività scientifica? E con il senso vissuto? La riflessione
di Canguilhem si è mossa attorno a questi problemi, debordando i
confini tanto dell'esistenzialismo quanto dell'epistemologia, e toccando
i "grandi temi" della verità, della conoscenza, del pensiero.
E appunto in questi tre saggi, la Verità, il Sapere e il Pensiero
sono stati ridiscussi in rapporto, da un lato, al valore della propria esistenza
per il soggetto, dall'altro, alle scoperte della scienza contemporanea.
2) Genealogia della Verità
Il primo scritto qui presentato è contenuto in un omaggio collettivo
a Jean Hyppolite. Esso riguarda il problema dell'errore e della verità.
Meglio, riguarda l'impegno giudicante del soggetto nel distinguere tra verità
ed errore, e, in base a ciò che già sappiamo, al senso che
ha per il conoscente l'essere "nella verità".
Ciò che Canguilhem esclude nelle prime battute, è che la verità
sia data, cioè che sia una parte della realtà, del suo ordine
oggettivo, e che pertanto al soggetto basti vedere per conoscere;
e qualora ciò che è visto si riveli ingannevole, che basti
vedere-meglio per far tralucere il vero dalle scorie sensibili del
falso.
Che il falso non sia un momento del vero, come afferma Canguilhem, significa:
il falso non è l'immediato e il vero non è l'essenza profonda;
non è lo sguardo superficiale che genera l'errore fermandosi alle
prime apparenze e non è lo sguardo più profondo che scopre
il vero vedendo l'essenza trasparire dai fenomeni. Vero e falso sono valori
relativi ad un giudizio. I dati sensibili non sono veri o falsi,
né il vero consiste nel "vedere di più" di ciò
che è dato nel falso. Vero e falso riguardano l'interpretazione dei
dati sensibili.
Se dico che il bastone nell'acqua è davvero spezzato, dico il falso;
se dico che è un'illusione ottica e che il bastone è intatto
dico il vero. Ma questo vero è qualcosa in più che io vedo
rispetto a quanto vedrei se fossi convinto che il bastone è rotto?
Oppure io vedo in entrambi i casi gli stessi dati e cambia il mio modo di
interpretarli? La differenza tra vero e falso non è la differenza
tra il fenomeno e l'essenza, tra l'apparenza superficiale e la realtà
profonda, ma tra due differenti criterii ermeneutici applicati ai qualia
ed ai relata dati all'esperienza.
Se applico all'immagine del bastone un codice che comprenda gli effetti
di distorsione prodotti dall'acqua, e da ciò traggo un'inferenza
sull'immagine stessa, dirò che è falso che il bastone
sia spezzato. Ma io allora non vedo di più di quello che vedrei
se utilizzassi un codice che non comprende quei principii di ottica: vedo
altrimenti, o, se si vuole, penso altrimenti ciò che
ho visto.
False sono le inferenze tratte da un criterio ermeneutico che rifiuto. Ma
allora il falso non viene conservato nel vero in un processo di accumulo
del sapere ottenuto per accrescimento della penetrazione, da parte del soggetto,
in una realtà data. Il falso è alternativo ed inconciliabile
rispetto al vero. Il passaggio dall'ignoranza al sapere è l' uso
di un codice contro un altro alternativo, che allora viene negato, non conservato.
Il soggetto che da ignorante diventa sciente, non è un soggetto che
vede meglio le cose in sé stesse (forse che se vedo il bastone in
acqua rotto vedo male?), ma un soggetto che ha cambiato codice ermeneutico,
dunque che ha cambiato forma di vita, se con questo termine intendiamo
ora il complesso di condizioni pratiche e cognitive sulla cui base interpretiamo
i dati sensibili. Ma allora la distinzione vero/falso non è insita
nelle cose stesse (se lo fosse, sarebbe sempre riassorbibile in una configurazione
armonica della realtà): essa implica il giudizio di un soggetto cui
siano noti diversi sistemi di giudizio, diversi modi di relazione con la
realtà, e che ne abbandona consapevolmente uno per spostarsi in un
altro. Essere "nel vero" significa esattamente il contrario di
quanto una venerabile tradizione ha sostenuto, cioè essere sprofondati
nel nocciolo delle cose, coglierne il nucleo profondo, essenziale ed immutabile.
Essere nella verità significa muoversi, mediante una serie indefinitamente
reiterabile di rotture, in nuovi orizzonti di razionalità,
in nuove possibili letture della realtà. La verità è
polemica e costruttiva; essa non è il raggiungimento, alla fine
del processo conoscitivo, di ciò che era dato interamente all'inizio,
non è un cerchio chiuso, ma un processo aperto di invenzione, lo
scarto tra un codice interpretativo bloccato ed uno nuovo, che rilancia
la produzione di discorsi razionali. Il vero è il raggiungimento
di una posizione dalla quale la virtualità di possibili orizzonti
razionali risulti moltiplicata.
Il falso allora sarà la posizione contraria: quella dalla quale,
in ogni situazione problematica data, il pensiero può aprirsi meno
strade, vagliare meno opzioni, cristallizzandosi in un'unica configurazione
che delegittima o occulta tutte le alternative. Al limite, è la posizione
che tende ad identificare il proprio discorso con l'ordine oggettivo delle
cose. Come questa illusione possa sorgere dall'attività critica di
discernimento del vero e del falso è ciò che Canguilhem spiega
mediante la funzione normativa dei principi di non-contraddizione e di identità.
Caratteristica del principio di identità (A=A) è quella di
produrre un effetto reificante: si tratta di una necessaria illusione trascendentale
prodotta dall'uso di questo schema logico, per cui il vero sembra essere
incorporato alle cose stesse e la parola costituire un unità con
il concetto e la cosa. Ma a monte di questa unità c'è un processo
di produzione, in cui risulta coinvolto il principio di non contraddizione
(A non è non-A). Il principio di non contraddizione esclude che due
giudizi contraddittori (o due codici incompatibili) possano avere uguale
validità -il bastone non può essere sia spezzato che intatto;
la scelta di uno dei due giudizi ad esclusione dell'altro, in quanto è
formulata nella struttura intemporale della predicazione, cancella il fatto
che, prima di scegliere a favore di un giudizio (e del "gioco"
che lo sottende), si presentavano due opzioni nessuna delle quali era garantita
in partenza contro il prevalere dell'altra. Una volta compiuta la scelta
il contenuto ritenuto valido appare già da sempre intrinseco alla
realtà: ma esso è frutto di un'opzione, e non è dato
né in rebus, né tantomeno nel principio di non-contraddizione,
che è indifferente ad ogni contenuto, limitando la propria funzione
al compito strettamente formale di impedire che opzioni incompossibili possano
pretendere di coesistere. Al principio di tutto però non c'è
una realtà già strutturata da leggi immutabili, ma una molteplicità
di modi di rapportarsi alle datità, di inserirle in reti di relazioni
e di riferirle a progetti; noi "scegliamo" in questa molteplicità
i modi che ci consentono una maggior ricchezza e complessità di approcci
ai dati.
Ma non bisogna dimenticare che prima di questa scelta c'è sempre
uno spazio di indeterminatezza, in cui è possibile per principio
attribuire validità a ciò che sarà retrospettivamente
invalidato, o, se si preferisce, in cui ciò che sarà poi dichiarato
verità e ciò che invece dovrà venir respinto come errore,
si presentano come dotati di pari forza e possibilità di validazione.
La costruzione della verità è un processo che necessariamente
inizia in assenza della verità stessa: affinché
di essa si chiarisca la genealogia si dovrà attribuire una positività
all'errore, o meglio, si dovrà raggiungere uno spazio neutro, aldilà
di verità ed errore, dal quale derivare la formazione e l'opposizione
dei poli del vero e del falso. Essi non preesistono alla propria genesi:
le "forze" che si contrappongono in quello spazio neutro non sono,
finché permangono in esso, né vere né false, ma lo
divengono solo quando la forza che ha prevalso ha cristallizzato la propria
sopraffazione sull'altra in un sistema di giudizio. Ovviamente, se tale
cristallizzazione sfocia in un ulteriore "blocco" delle possibilità
vitali, sarà compito della critica ricondurre al suo statuto di errore
quella forza la cui affermazione si è rivelata perniciosa per la
vita. I principi logici dunque non esprimono alcun contenuto né della
realtà né del mondo, ma regolamentano questo rapporto di forze
dall'esito costantemente aleatorio.
Se la verità nasce opponendosi all'errore mediante differenziazione
da quella non-verità che contiene virtualmente verità ed errore,
allora se ne conclude che non è possibile verità senza possibilità
di errore. L'errore definisce in modo essenziale questa concezione produttiva
della verità; esso -la sua presenza incombente- è la condizione
assoluta affinché la verità non sia posta come preesistente
alla propria invenzione all'interno di una forma di vita.
Da questo punto di vista, è della massima importanza analizzare con
quali argomenti Canguilhem, ne Il Cervello ed il Pensiero, critica
i tentativi di ridurre l'attività della creazione intellettuale ad
effetto di processi fisici completamente oggettivabili e su cui si potrebbe
intervenire per migliorare le prestazioni dell'intelligenza. Per Canguilhem,
ciò che è irriducibile ed inoggettivabile nel pensiero umano
è innanzitutto qualcosa di negativo: in primo luogo, la capacità
di intenzionare qualcosa che non è dato -come potrebbe uno scienziato
giudicare una teoria od un'invenzione manchevoli se non ne avvertisse l'incompiutezza
rispetto ad un terminus ad quem che ovviamente non è presente,
e dunque non può neppure essere presentificato in nessi causali?
In secondo luogo, la capacità di fingere, nel doppio significato
di simulare, ingannare deliberatamente, e di costruire rappresentazioni
artificiali -cioè nel senso ad un tempo di capacità di menzogna
e di capacità di immaginazione produttiva. Queste due facoltà
del pensiero umano trascendono infinitamente ogni premessa data, e consentono
alla nostra attività intellettuale di non considerare l'esistente
come l'ultima parola del possibile. Il pensiero -ma abbiamo visto che esso
esiste solo entro una forma di vita complessiva- non può mai essere
ridotto ad un calcolo o ad un nesso causale efficiente perché ambedue
queste strutture possono solo ripetere o riprodurre quanto è già
dato: l'esito di un calcolo e l'effetto di un fenomeno causante sono già
contenuti nelle regolarità intrinseche ai loro rapporti con le proprie
premesse o cause. Come derivarne allora la tendenza del pensiero creativo
verso qualche cosa che è presentito, ma di fatto ancora non c'è?
Come derivarne l'invenzione di qualcosa che non è dato nelle cose
stesse, sia che esso risponda ad uno scopo recettivo, sia ad uno di positiva
innovazione? Se il pensiero è un meccanismo, se è riducibile
ad un calcolatore o ad una rete di interazioni neuronali, come è
possibile pensare qualcosa che non è stato inserito precedentemente
nel calcolatore e che, non essendoci, non può entrare in relazione
causale con alcunché? I modelli teorici utilizzati dalle scienze
della mente per render ragione del meccanismo del cervello non possono spiegare,
ad esempio, l'invenzione da parte di Pascal della macchina calcolatrice;
e non possono farlo perché non sono in grado di dar conto dei tentativi
reiterati e volontari di Pascal di approssimarsi ad un risultato non dato
e quindi non calcolabile. Così come non è possibile dar cinto
con questi mezzi del fatto che Newton "pensasse costantemente"
ad una teoria che ancora non c'era, che si dava solo come vuoto,
come esigenza di sviluppo dello stato contemporaneo della meccanica. Questo
vuoto è lo scarto tra ogni realizzazione, ogni realtà,
da un lato, e l'intelligenza umana dall'altro, è ciò che consente
al pensiero di uscire dai binari consueti, di modificare a proprio vantaggio
le premesse iniziali per trarne esiti imprevisti. È la differenza
tra il reale o l'attuale, ed il possibile. Non si tratta dunque di un'ipostasi,
dell'idea metafisica del Vuoto: si tratta solo di una riserva, per
usare le parole di Canguilhem, una riserva di ciò che può
essere rispetto a ciò che è. Questo vuoto è la traccia
invisibile dell'incompiutezza di tutti gli stati di cose vigenti, di tutti
gli ordini di razionalità dati: esso rende percepibile l'indipendenza
dell'esistente da ogni Necessità, il suo debordare su ciò
che potrebbe essere altrimenti. L'attività critica che è indisgiungibile
dalla verità si colloca in questo spazio inoggettivabile tra l'esistente
e se stesso; la scoperta che il reale è il risultato di un rapporto
di forze, e che il suo sussistere non è pertanto necessario, apre
per il soggetto la possibilità di trasformare ogni situazione data
allo scopo di incrementare e diversificare le proprie "capacità
di essere affetto". Concepire dunque la positività dell'esistenza
in termini di continua produzione di forme di vita e di ordini di verità,
vedere in questo lo stato normale, "sano", dell'essere vivente,
implica un'opzione cosmologica in favore di un universo in divenire, di
un mondo le cui forme attuali siano null'altro che la manifestazione di
superficie di una riserva di possibilità non regolamentabili apriori
e quindi non esauribili. Questa opzione ha dei presupposti, che ora dovremo
esplicitare.
3) Metafore dell'autoaffermazione
All'inizio abbiamo incontrato l'attività valorizzante del soggetto
rivestita di panni differenti ed inconciliabili: da un lato, la posizione
per cui il sommo valore dell'esistenza è la conformità ad
un Ordine, ad un armonia; dall'altro, quella per cui ha valore quella forma
di esistenza capace di produrre ordinamenti sempre nuovi. A queste posizioni
corrispondono due analoghe concezioni della conoscenza: una per cui essa
consisterebbe nel vedere-dentro le cose, ed un'altra per cui invece essa
consisterebbe in una costruzione di strutture razionali prive di garanzie
ancorate al fondo intimo delle "cose stesse". Si tratta qui delle
ricadute epistemologiche di quelle due fondamentali posizioni. Per illuminare
il significato complessivo dell'opposizione tra quelle due posizioni in
merito al valore sommo della vita è utile partire proprio dall'analisi
di quelle epistemologie contrapposte. Esse però dovranno venire analizzate
non tanto nel loro apporto più specifico all'impresa scientifica,
quanto come sintomi di immagini contrastanti del sapere e del suo
posto nel complesso delle realtà.
Hans Blumenberg ha individuato una cesura nelle immagini metaforiche costitutive
della concezione della verità, intercorsa all'inizio dell'età
moderna. Il mondo antico e quello medievale si reggono sul metaforismo della
"possente verità" - il che significa: la verità
si impone, la forza per cui essa viene còlta è la sua stessa
forza, mediante la quale essa si dà. Cogliere la verità non
è un'attività del soggetto, ma piuttosto un collocarsi di
questo nel proprio luogo naturale, nella posizione che l'ordine del cosmo
gli assegna e dalla quale è trasparente la struttura del mondo. Per
"verità" si intende in questo contesto: <<una certa
qual trasparenza della struttura del mondo, una completa pubblicità
della volontà che ordina la creazione, nessuna riserva alla partecipazione
comunicativa degli enti, la "intensità" della "veritas
ontologica">>[10]. Da Aristotele
passando per gli Stoici alla Patristica, il metaforismo della possente verità
implica -affinché regga il postulato di una trasparenza delle cose
al soggetto conoscente- che tra il cercatore della verità, quel medesimo
soggetto, da un lato, e le cose dall'altro viga un rapporto di armonia prestabilita,
poco importa se voluta dal Creatore o eternamente consustanziale alla struttura
dell'universo. Ciò che conta è che in quanto l'uomo
è teleologicamente inserito in un ordine cosmico, il cosmo stesso
gli è accessibile: cioè, l'uomo accede alla verità
solo in quanto egli stesso è nella verità, cioè in
un posto che gli spetta in virtù dei fini ultimi e dell'armonia del
mondo.
Nell'età moderna il metaforismo dominante in riferimento alla verità
è quello del lavoro: la ricerca della verità è
ardua, faticosa, condotta mediante inganni, artifici e pressioni; non si
dà più una trasparenza delle cose che la benevolenza della
natura o del Creatore avrebbe pacificamente posto in adeguazione reciproca
con gli organi conoscitivi umani: <<Qui si ha il rovesciamento dell'intera
metaforica della potenza della verità, nel sostituirsi della nozione
della violenza che l'uomo deve fare alla verità per impadronirsene.
Qui la verità non ha più nulla di ciò che si potrebbe
chiamare la sua "naturalezza": la coscienza del metodo e la riflessione
metodologica dell'incipiente modernità sorgono sul terreno del sentimento
fondamentale di un rapporto con la verità, che è di violenza,
da assicurarsi con la cautela e la circospezione (...) Tutto il vero è
acquisizione, non più dono; la conoscenza assume il carattere di
lavoro>>[11]. Questo rovesciamento
ha implicazioni decisive sull'antropologia: <<La metafora della potenza
della verità e, al suo seguito, il topos della facilità della
conoscenza, emergono prevalentemente come caratterizzazioni di un contenuto
teologico e morale in funzione salvifica>>[12].
All'uomo la verità è data perché la sua destinazione
è la salvezza, e l'ordine cosmico cospira ad indirizzarvelo. Il mondo
è ben ordinato in vista di questo fine, ed è perciò
che il suo ordine, di cui la salvezza umana è parte, non può
celarsi all'uomo stesso. Che la verità non abbia più una propria
"facilità", che all'estrema disponibilità sostituisca
non soltanto costumi più riservati ma addirittura una sconcertante
e scoraggiante ritrosia, significa dunque che la destinazione cosmica dell'uomo
non è più la salvezza, oppure che essa non è
più palese, oppure che non vi è alcuna destinazione
dell'uomo e del mondo: in tutti i casi, viene meno la garanzia di un ordine
dell'universo. Cioè, la verità si rifiuta perché il
mondo non può essere più pensato come "kosmos":
<<Cosa sia il mondo effettivamente - questa questione che meno d'ogni
altra può essere risolta è tuttavia anche quella che non può
mai essere lasciata irrisolta e perciò sempre decisa. Che il mondo
sia "kosmos", fu una delle risoluzioni costitutive della nostra
storia spirituale, una metafora il cui senso originario non perde di risonanza
(...) sempre ripresa nelle immagini del mondo come polis e del mondo come
grande vivente, del mondo come teatro e del mondo come meccanismo d'orologio>>[13]. La metafora della possente verità,
che negava all'uomo l'iniziativa della conoscenza al contempo assicurandogli
un confortevole luogo naturale in seno all'ordine cosmico, si reggeva sulla
metafora del mondo-come-"kosmos". La metafora della conoscenza
come lavoro imposto sull'indifferenza o l'ostilità delle cose, si
reggerà allora su un'analoga metafora fondatrice?
Il mondo-kosmos è una metafora assoluta. Le metafore assolute sono
tali in quanto irriducibili ad elementi più semplici: <<Certe
metafore potrebbero anche essere (...)elementi primi della lingua filosofica,
"traslati" irriducibili alla proprietà della terminologia
logica>>[14]; la metafora assoluta
è: <<una sfera catalizzatoria, alla quale il mondo concettuale
certamente di continuo si arricchisce, senza tuttavia modificare o consumare
questo fondo costitutivo primario (...) il processo delle mutazioni storiche
di una metafora porta in primo piano la metacinetica stessa degli orizzonti
di senso e delle prospettive, entro cui i concetti subiscono le loro modificazioni>>[15]. Le metafore assolute sono gli orizzonti
di senso, mai del tutto esplicitabili, in base a cui rispondiamo alla domanda
"cos'è il mondo?". È in base al funzionamento delle
metafore assolute che un ]fatto, nudo e crudo, tautologico, può
essere significativo, portatore di un senso e dotato di spessore valutativo:
ad esempio, un fatto biologico può essere dotato di valore positivo
o meno, può essere valutato come indebita deviazione da un ordine
concepito come desiderabile in quanto assicurazione di stabilità,
o piuttosto come forma di vita specifica e legittima, unica titolare del
giudizio sulla propria specificità. L'orizzonte metaforologico di
Comte e Broussais è ancora quello governato dal "kosmos":
a quale metafora assoluta fa ricorso Canguilhem nel suo sforzo di legittimare
l'originalità di ciascuna forma di vita?
Blumenberg ha chiarito come alla fine del Medioevo le garanzie fornite tradizionalmente
all'uomo in merito ad un universo approntato per la sua conservazione siano
state erose dall'affermazione dell'onnipotenza arbitraria e trascendente
inizialmente invocato quale supremo garante[16],
ma ora reso inaffidabile dall'assoluta indipendenza nei confronti delle
aspirazioni umane. L'attività dell'uomo ora deve essere riferita
ad una realtà imperscrutabile, non finalizzata: l'unica chance
della razionalità consiste nel fare dell'autoaffermazione dell'agire
umano l'unico modo in cui l'uomo può, almeno provvisoriamente, garantire
la propria esistenza. L'umanità deve ora affidarsi al proprio potere
costruttivo, alle proprie risorse inventive e pragmatiche, per conservare
ed espandere la propria condizione, imponendo alle cose riottose i propri
progetti. L'autoaffermazione, che quindi comprende l'immagine della conoscenza
come lavoro e della verità come produzione, è la metafora
assoluta che definisce l'orizzonte moderno. Un'analisi più approfondita
della sua struttura rivela che innanzitutto essa costruisce il proprio orizzonte
a partire da un vuoto, una carenza. Gli esseri (l'uomo in
primis, ma non solo) esistono sempre in un vuoto di fondamenti, sono dati
in configurazioni fattuali e contingenti poiché nessun ordine cosmico
può essere reperito che imponga loro un modo di attività necessario,
un luogo naturale e dei limiti prestabiliti. Non solo dunque essi possono
mutare assetto: devono farlo per non soccombere in un modo non garantito.
L'autoaffermazione consiste dunque in una deviazione: gli esseri
devono deviare dal loro corso primitivo per poter mantenere la propria esistenza,
devono innovare il proprio statuto non ancorato ad alcun'armonia prestabilita.
Ma il corso primitivo antecedente la deviazione non è esso stesso
un ordine: non si dà ordine cosmico, dunque ciò da cui deviano
gli esseri è un assetto fattuale quanto ciò verso cui si muovono.
Se la deviazione fosse deviazione da un ordine preesistente sarebbe quest'ultimo
a riaffermarsi, attraverso la propria negazione, come originario orizzonte
di senso del mondo, ma appunto che ciò si possa dare è escluso
nell'età moderna: la deviazione dunque devia dai risultati di altre
deviazioni, cioè non ha inizio assoluto, è sempre-già
cominciata, e pertanto è una deviazione originaria. La filosofia
di Canguilhem, per cui il valore positivo di una forma di vita consiste
nel produrre ulteriori ed imprevedibili forme di vita, è una potente
illustrazione di questa metafora assoluta. Louis Althusser dirà che
Canguilhem ha avuto una "grande influenza" sul suo pensiero. Sebbene
il riferimento non sia specifico, non può essere un caso che l'ultima
riflessione di Althusser sia incentrata sulla deviazione degli atomi, deviazione
primordiale e senza inizio, produttrice di infiniti mondi in perpetua erranza.
Né caso né "influenza", si direbbe, ma elaborazione
della stessa metafora assoluta intrinseca a tutto il pensiero moderno[17].
Conclusione
Secondo E. Melandri, il risultato di questa metaforica è che:
<<In epoca moderna l'uomo avverte se stesso come deus creatus;
egli sente con sempre maggiore determinazione di posseder già in
sé i criteri per valutare il grado della propria autoaffermazione,
per scegliere la direzione ottimale di tale sviluppo e concentrare tutte
le energie allo scopo>>[18]. È
Melandri stesso a ricordare che i contemporanei, "noi postmoderni",
non credono più sulla fiducia alle promesse di questo prometeismo
ingenuo: e dal 1960 questa sfiducia è diventata un luogo comune.
Ma non avevamo bisogno di "rivelazioni dell'Essere" marca anni
'80, né di accompagnarle con la perorazione di un "tutti a casa"
politico, per sapere che l'autoaffermazione è diventata un orizzonte
problematico, almeno quanto lo fu il kosmos alla fine del medioevo. Il pensiero
di Georges Canguilhem, come, per altri versi, quelli di Althusser e Foucault,
ci sembra un egregio sintomo di tale problematicità. In esso, l'orizzonte
dell'autoaffermazione declinato in veste di deviazione originaria, dismette
i panni del demiurgismo umanistico, e si rispecifica in configurazioni più
sobrie.
In primo luogo, è nella metafora della "riserva" che l'autoaffermazione
incorpora il senso del limite. La facoltà di deviare dalle condizioni
date è certo potere di trascendimento di, ed intervento su, queste
condizioni, ma non è facoltà di annullare o creare le condizioni
dello stesso esercizio della critica. Canguilhem paragona il soggetto che
si avvale della sua riserva al pittore che si sposta lievemente per cogliere
sotto una nuova angolatura il paesaggio contemplato: forse che il pittore
però può tirare fuori da se stesso il paesaggio? Allo stesso
modo, il soggetto irriducibile alle "cose", non può prescinderne
interamente, ma solo spostarsi per moltiplicarne le possibili implicazioni.
In secondo luogo, ciò che in Canguilhem spiazza ogni umanesimo prometeico
è la teoria della patologia. Come abbiamo visto, la "salute"
coincide con la capacità di mutare, mentre l'invalidità
coincide con l'essere bloccati in una forma di vita. Troviamo di nuovo l'inversione
dei valori relativi al kosmos: il "male" è essere schiacciati
dalla ripetizione inesorabile di una regolarità, mentre ogni regolarità
è "bene" solo allorché permette di eccedere i suoi
stessi confini. Però non deve sfuggire come Canguilhem attui qui
un'inversione dell'inversione. Il senso dell'immagine della deviazione
originaria non consiste solo nel legittimare l'innovazione delle forme di
vita "sane", ma anche nel sottrarre ad ogni verdetto di interdizione
le forme di vita "malate". Non è il vivente che strabocca
di potenza, che entra continuamente in relazioni vitali sempre più
complesse e ricche, il solo destinatario del discorso di Canguilhem: esso
è verificato piuttosto dalla capacità di legittimare la specificità
delle forme di vita mutilate, sofferenti, per le quali l'esistenza è
la ripetizione forzata di un impedimento insuperabile. Non gli "adatti",
dunque, ma proprio gli "inetti", devono beneficiare dell'orizzonte
dell'autoaffermazione.
Infatti, che una forma di vita sia in grado di espandersi, oppure viceversa
sia condannata all'isterilimento delle proprie possibilità, si tratta
sempre di esiti fattuali di processi fattuali: dietro di essi non c'è
nessuna Provvidenza, nessun ordine. Dunque, la deviazione dalla norma, poiché
ogni norma è frutto di un deviare più fondamentale, non può
essere vista come una colpa, una trasgressione morale, né
nel caso di una deviazione espansiva né in quello di una che mette
capo ad una forma invalida di esistenza; quest'ultima ha uno statuto ontologico
identico a quello delle forme "valide", e quindi ha diritto all'autoaffermazione
che le sue condizioni gli consentono: al limite, anche solo il diritto di
avere una voce propria, di pretendere al riconoscimento della propria specificità,
di essere riconosciuta come singolarità irriducibile e titolare della
valorizzazione del proprio stato, per quanto dolorosamente diminuito.
Nell'Idiota, il tubercolotico Ippolít ragiona in termini di
autoaffermazione quando lamenta la sorte che ha chiuso drasticamente
la via delle sue possibilità: <<Perché cominciavo
realmente a vivere, sapendo che ormai non potevo più cominciare?>>[19]. Per Ippolít, che afferma importare
soltanto <<la vita, la sua incessante ed eterna scoperta>>[20], è inaccettabile la consapevolezza
che la sua vita è orrendamente impoverita e limitata dalla malattia
e dalla morte incipiente. Fin qui, il suo ordine di valori è quello
dell'autoaffermazione, di cui egli non si sente capace. Ma in lui è
attivo anche l'orizzonte metaforico del "kosmos", poiché
avverte la propria disgrazia come esclusione dall'armonia universale: <<Che
importa a me della vostra natura, del vostro parco di Pavlovsk, del vostro
levare e tramontar del sole, del vostro cielo azzurro e delle vostre facce
soddisfatte, quando questo banchetto che non ha fine, ha cominciato con
l'escluderne me solo, come superfluo? Che posso trovare in tutta codesta
bellezza, quando adesso ogni minuto, ogni secondo, devo sapere, sono costretto
a sapere che anche questo minuscolo moscerino ronzante intorno a me in un
raggio di sole partecipa a quel banchetto e a quel coro, e sa il posto suo
e lo ama ed è felice, e io solo invece sono un aborto?>>[21]. Di fronte allo scandalo della propria
sorte, Ippolít rifiuta di accettare che essa possa rientrare in un
disegno provvidenziale del mondo; egli quindi decide di uccidersi in quanto
<<il suicidio è forse l'unico atto che io possa ancora cominciare
e finire di mia volontà. E se io volessi approfittare della mia ultima
possibilità di agire?>>[22].
L'episodio è una variante di un tema dostoevskijano fondamentale:
la ribellione contro l'ordine divino dell'universo. Si tratta però
di una variante significativa. A differenza di Raskolnikov, Ippolìt
non si ribella per ampliare le proprie possibilità di azione, ché
il suo stato non glielo consente. Eppure, si può dire che anche lui
compie un gesto di autoaffermazione; solo, essa consiste nella pura rivendicazione
dell'esclusiva titolarità a giudicare e decidere della propria vita.
In altri termini, se ammettiamo un'armonia provvidenziale in cui tutto è
ordinato "per il meglio", cosa resta allo sventurato Ippolít?
Niente, nemmeno il diritto a chiamare sventura la propria sventura: egli
infatti morirebbe sì, ma ad majorem Gloriam, la sua sorte
sarebbe riassorbita nella constatazione rassicurante che, se c'è
il "lieto fine", se il bilancio è attivo, un'anomalia è
pur sempre un fatto trascurabile, un'eccezione irrilevante, e poi chissà
che la Provvidenza non tragga maggior bene da quel piccolo e inoffensivo
male. Così, Ippolít è costretto a scegliere l'autoaffermazione
contro questo assolutismo teologico-morale, affinché non gli venga
sottratta, oltre alla propria labile e precaria forma di vita, anche la
residua significatività di quest'ultima. Ma appunto, l'autoaffermazione
qui non può consistere che nel rifiuto di rimettere il giudizio sul
proprio stato ad un piano imperscrutabile, ad un senso preesistente che
avrebbe già computato e valutato la malattia, il dolore e la morte.
Ippolít rivendica di essere l'unico giudice legittimo del valore
della sua vita, e, non vedendovi nulla di positivo, sceglie l'autodistruzione.
Ciò che importa però non è tanto questa scelta, quanto
il criterio in base al quale Ippolít se ne assume la responsabilità,
che è appunto quello dell'autoaffermazione in quanto diritto rivendicato
all'autovalorizzazione.
Così, l'autoaffermazione appare già in Dostoevskij nella forma
post-prometeica che abbiamo visto in Canguilhem. Si tratta di una svolta,
che dalla fine degli ordinamenti trascendenti ricava attenzione alla fragilità
umana, ma anche alle possibilità nascoste presenti in un mondo di
fattualità, piuttosto che al progetto di dominio umano sulla totalità
delle condizioni d'esistenza della specie. Questo progetto è diventato
ideologicamente sospetto e attualmente irrealizzabile nell'età contemporanea,
che perciò si può (forse) chiamare postmoderna, se con modernità
intendiamo l'epoca del progetto autoaffermativo nella sua fase ingenua,
non-tematica e non-problematica. Ma allora cosa ne è di tale progetto,
una volta che sia diventato tematico, e perciò autoriflessivo? Una
via possibile è quella di abbandonarlo, invocando il ritorno di una
trascendenza capace di farsi nuovamente carico delle potenze sottratte all'uomo:
è la via di Heidegger e di tutte le teologie negative rifiorite negli
ultimi decenni. Un'altra via può consistere in una forma di opportunismo
trascendentale, che della contingenza irrimediabile fa lo scenario di una
fruizione estetico-egoistica priva di intenzionalità critica: è
la via del pensiero debole, e di tutti i delibatori della pluralità
irrelata dei linguaggi e dei codici. Canguilhem ed i filosofi che ne hanno
in vario modo seguito la lezione, come Althusser e Foucault, rappresentano
un altro percorso possibile. La contingenza del mondo, la fattualità
delle condizioni dell'esistenza, in quanto risultati della deflazione del
prometeismo moderno, aprono lo spazio della "riserva" che consente
la distanza critica, potenzialmente trasformativa, dall'esistente; la specificità
delle forme di vita, in quanto risultato del crollo dell'Ordine cosmico,
impone che l'uso che si fa di questa "riserva" sia non solo sempre
calibrato sulla singolarità delle situazioni, ma, soprattutto, verificato
solo dal rapporto che riesce ad instaurare con quelle forme di vita per
le quali la datità del mondo rappresenta il peso dell'oppressione.
È questa visione, dell'autoaffermazione come Diesseitigkeit,
come prassi emancipativa che si determina mediante il proprio coinvolgimento
nei "destini generali", che abbiamo trovato nel pensiero di Georges
Canguilhem, e che ci sentiremmo di raccomandare come modello di pensiero
critico.
Andrea Cavazzini
Parma, Luglio 2002