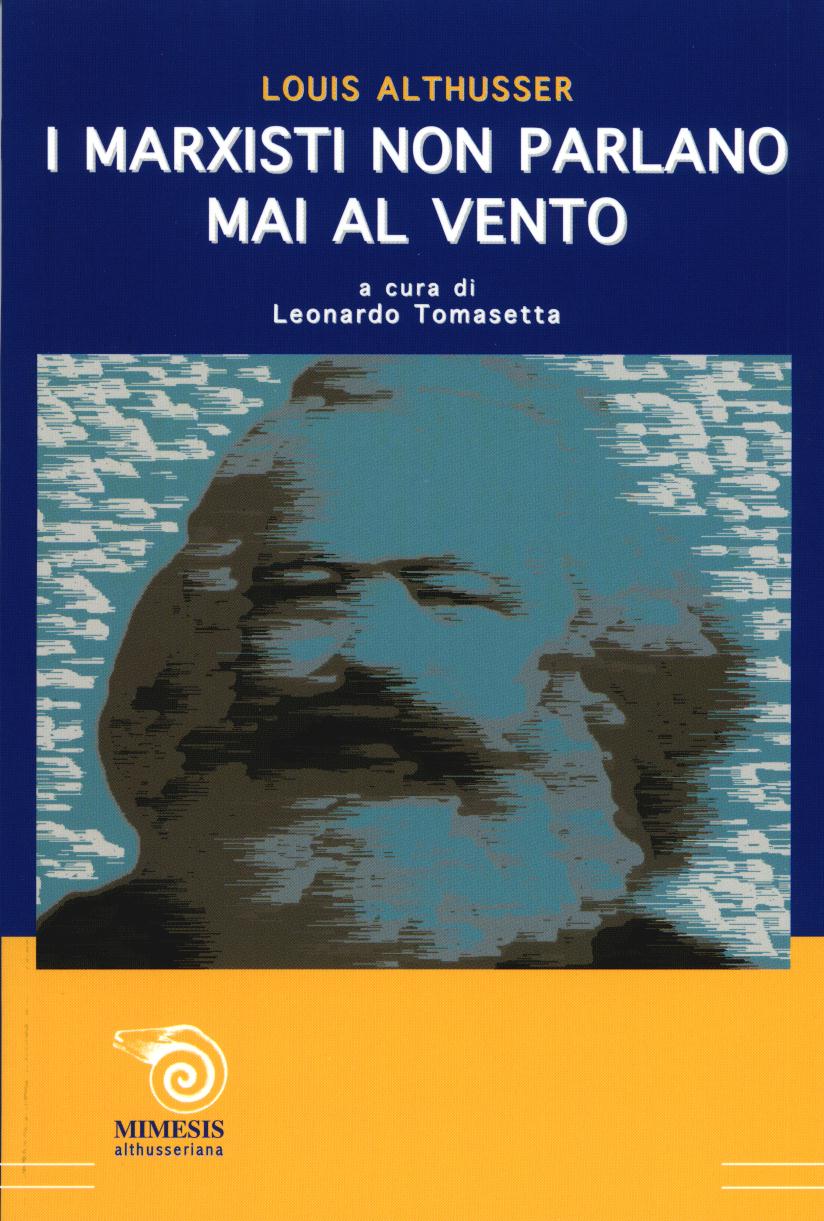
I marxisti non parlano mai al vento. Risposta a John Lewis
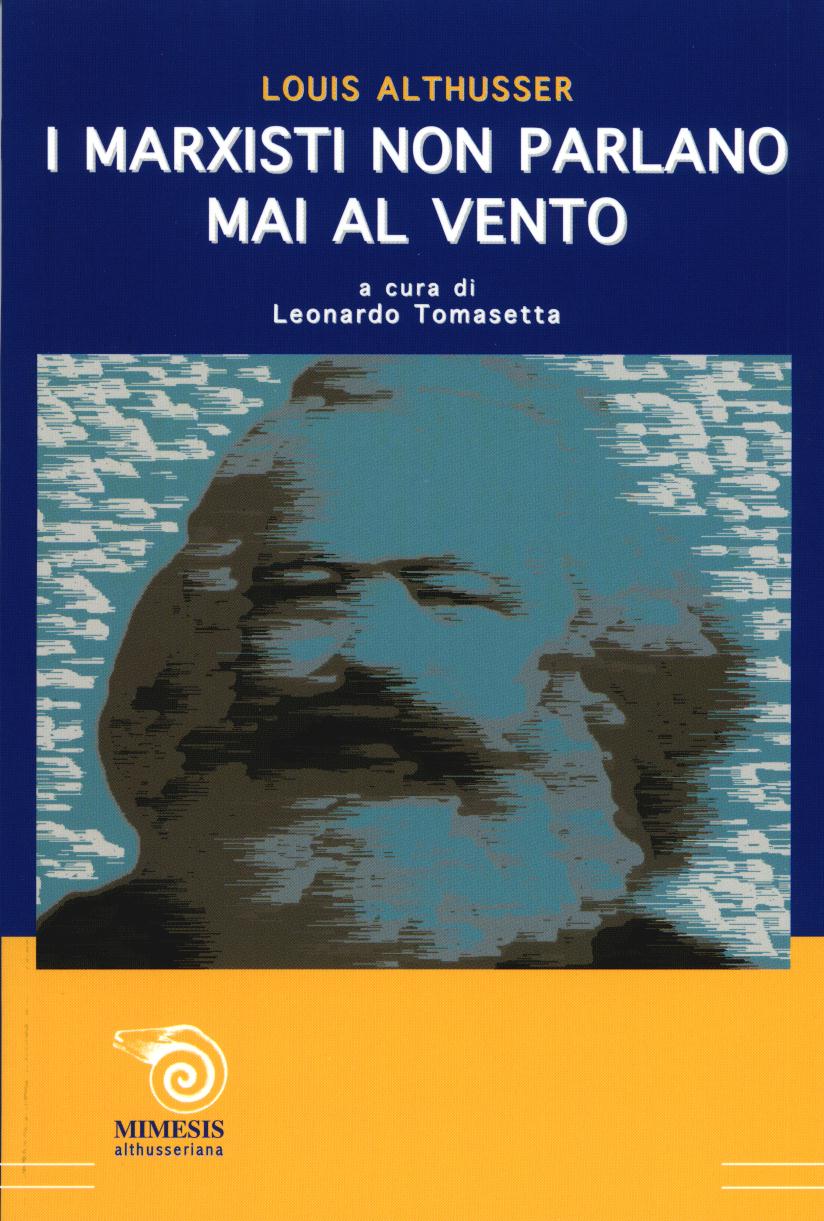 |
Louis Althusser I marxisti non parlano mai al vento. Risposta a John Lewis |
Introduzione
La filosofia è unita alla politica come le labbra ai denti
di Leonardo Tomasetta
Che dire! Mi sembra essere questa la frase che dà la chiave di
volta al vigoroso pamphlet althusseriano. Il lettore se la ritroverà
davanti molto più in là, all'inizio della Nota critica
sul culto della personalità. Ma proprio perché in questo
scritto Althusser aggredisce con i "denti" della politica i marxisti
idealisti di tutte le tendenze, voglio chiarire subito il mio punto di vista
sulle finalità recondite della Risposta. Questa "aggressione"
trova il suo punto alto d'ispirazione nelle "labbra" della filosofia
di Althusser, che, col suo fraseggio scolpito, al limite della ossessione
iterativa, indirizza, e al tempo stesso smorza, la sua vis polemica
sui nomi più celebrati del gotha filosofico di Francia.
J. Lewis, a cui il pamphlet è formalmente indirizzato, è solo
la figura retorica di una resa dei conti che Althusser meditava da tempo
nei confronti di una "cattedrale" filosofica (Sartre, Garaudi,
Sève, ecc.) a cui non avrebbe forse riservata tanta attenzione, se,
ai suoi occhi, questi celebrati filosofi di Francia non avessero avuto il
grave torto di voler accreditare le loro scelte filosofiche in nome del
marxismo.
Occorre storicizzare.
Siamo agli inizi degli anni 70. A ridosso delle più grandi convulsioni
sociali e politiche che il secolo XX abbia conosciuto: la più prolungata
contestazione giovanile che la storia ricordi a livello mondiale; le rivendicazioni
paritarie dei movimenti femminili; i massicci scioperi operai, specie in
Francia e in Italia; il XX Congresso in URSS; l'invasione della Cecoslovacchia;
la guerra in Vietnam; la minaccia atomica con l'installazione dei missili
russi a Cuba; i primi scricchiolii all'interno delle arrugginite strutture
dei partiti comunisti d'Europa. Quel mondo, quegli eventi, stimolavano grandi
svolte, nuovi progetti, endemici sommovimenti ideologici, inedite, o ritornanti
speculazioni filosofiche.
La grande riflessione critica si divideva a quei tempi fra le maestose note
della Scuola di Francoforte e i vari afflati umanistici dell'esistenzialismo
e del "situazionismo" francesi.
Sull'altra sponda dell'Atlantico, Marcuse, come un navigato surfista, dominava
sull'onda lunga della rivolta studentesca, colorando di nuove suggestioni
il fascino della trasgressione. Di qua dell'Atlantico, Louis Althusser,
solitario guardiano di un tempio che stava già per essere dissacrato
e saccheggiato, sfoderava la spada affilata della polemica per organizzare
l'ultima resistenza. E lo fa, si illude di farlo, con le armi della logica,
con il rigore dell'esercizio critico, che spesso si ritorcerà contro
se stesso.
Commette allora lo stesso errore di Martin Lutero nei confronti della chiesa
cattolica apostolica romana. Vuole rivendicare l'ortodossia del suo marxismo
sapendo che la chiesa madre moscovita teneva stretto il controllo sui partiti
comunisti d'europa.
Althusser, che, fra i tanti meriti acquisiti sul campo, ha anche quello
di aver descritto con tanto acume gli apparati ideologici di Stato, commette
l'errore (rapportato all'epoca) di sottovalutare il peso egemonico dell'"apparato
ideologico" del comunismo internazionale. Apparirà perciò
ingenua la sua domanda sul perché i comunisti alla J. Lewis siano
tanti e i comunisti alla Althusser pochi. Il potere si "situa",
si radica, si ramifica, tanto più capillarmente, quanto più
può appellarsi alla tradizione, per farne, essa sì, un sinonimo
di "ortodossia".
Ma a parte ciò, è la difesa dell'ortodossia che, a mio avviso,
suona falsa sulla bocca di Althusser. Il suo, diciamolo subito, è
un marxismo critico, e nel senso più radicale del termine:
il fatto stesso di andare a caccia delle più piccole sviste, debolezze,
"aporie" all'interno dell'imponente opera di Marx la dice lunga.
E la sua è una qualità che i marxisti dovrebbero apprezzare
se vogliono coniugare la loro vocazione rivoluzionaria con i parametri della
scienza. Una qualità che si riscontra in tutta la "pratica teorica"
di Althusser: un uomo - soggetto, agente (?), qui non interessa - determinato
quanto si vuole (come ognuno di noi) dalle circostanze materiali, ma sempre
pronto a correggere i propri errori, a "raddrizzare" le inevitabili
curvature che il suo pensiero ha dovuto assumere, sotto la sferza degli
eventi.
Nel mio Stratificazione e classi sociali - Sociologia e marxismo avevo
dedicato ad Althusser molto spazio[1].
In parte, per manifestargli la mia gratitudine per avermi aiutato a sciogliere
(grazie al suo concetto di "surdeterminazione") uno dei nodi più
controversi del concetto di sovrastruttura in Marx; più spesso per
avanzare i miei dubbi sui criteri "troppo gerarchici" con cui
in Per Marx aveva risolto il rapporto teoria-prassi.
A distanza di pochi mesi (20 febbraio 1975), mi sono sentito assai gratificato
nel ricevere una sua lunga lettera. Dopo gli apprezzamenti di rito per il
mio lavoro, candidamente mi confessa la sua sorpresa per avere io prestato
tanta attenzione ai suoi "provocatori" interventi[2].
Poi, con discrezione, mi spiega che il suo concetto di "pratica teorica"
non era destinato a risolvere il problema più generale del rapporto
teoria-prassi, ma ad ottenere, "in tempi così difficili",
"l'autonomia relativa" della teoria e conferirle quel carattere
pratico, attivo, materialistico di "rottura con la sua rappresentazione
tradizionalmente idealistica".
E' la riproposizione, con parole meno solenni, del concetto forte di filosofia
come "lotta di classe nella teoria" che il lettore troverà
nelle pagine della Risposta. Ma intanto desidero sottolineare il
dato caratteriale dell'interlocutore: una persona in permanente tensione
fra la necessità di affermare con forza le sue intime convinzioni
e il dovere di prestare l'orecchio a qualsiasi critica proveniente sia dalle
confutazioni altrui, sia dalla lezione dei fatti.
Lo dimostra la citazione, nella lettera che ho ricordato, della metafora
leniniana del bastone da raddrizzare ogni volta che s'incurva troppo da
un lato. Ma lo dimostrano soprattutto i continui aggiustamenti di tiro,
riscontrabili anche in questo lavoro, con note, osservazioni o postille.
Una persona rara, dicevo prima. Unica, vorrei precisare adesso che sono
costretto ad assistere o ai camaleontici travestimenti dei maître
à penser, o alla chiacchiera a ruota libera dei monopolisti del
sapere mediatico.
Ma torniamo alla filosofia di Althusser, e il lettore non me ne voglia se
mi lascerò andare in qualche autocitazione di troppo. La frase con
cui ho titolato la mia introduzione esprime già la stretta connessione
che Althusser vede fra politica e filosofia. Una connessione però
che, si badi bene, non implica una posizione ancillare della filosofia verso
la politica. A dispetto della sua sprezzante ironia verso i "marxisti
della cattedra", Althusser è pur sempre un cattedratico e un
cattedratico di filosofia. Ora, chi conosce l'"imprinting" cattedratico
sa benissimo che l'ultima libertà che un docente universitario può
concedersi è quella di subordinare l'autonomia della propria disciplina
al primato di un altro sapere, fosse pure quello marxista. E del resto,
il nostro Cesare Luporini, nell'introdurre il Per Marx, dirà
proprio che all'interno del marxismo di Althusser c'è il "rifiuto
ragionato della morte della filosofia"[3].
Una ragione, però, che lo porta ad assegnare alla filosofia una doppia
possibilità: agire sulla scienza, sia in senso progressivo, sia in
senso regressivo. La filosofia materialista, le tesi del marxismo-leninismo,
non solo non contraddicono con la "scienza della storia di Marx",
ma l'arricchiscono di nuovi concetti. La stessa ragione lo porterà
più avanti a ripetere l'autocritica che aveva già fatto nella
Prefazione alla edizione italiana di Lire le Capital (1967),
tenendo distinte la "rivoluzione filosofica" dalla "rottura
epistemologica". Solo la seconda ha a che fare con la scienza e in
Marx la prima farà da buttafuori della seconda.
Detto così, nel lettore potrebbe nascere il sospetto di trovarsi
difronte a una sorta di tautologia. In realtà nel testo althusseriano
i passaggi sono parecchi, anche se a volte così insistiti da provocare
qualche moto d'insofferenza. Va, in ogni caso, dato atto ad Althusser di
aver ribadito anche in questa Risposta (lo aveva anticipato nel 1968,
in Lenin e la filosofia) che la filosofia non è una scienza,
non ha un oggetto, non ha una storia (nel senso scientifico delle parole),
ma è "politica nella teoria".
Rimane però la questione del posto che la teoria occupa nella scala
delle ideologie. Ma, a differenza di quanto si poteva leggere in Per
Marx, dove veniva collocata al vertice di tutte le pratiche e, scritta
con la T maiuscola, prendeva addirittura il posto della "dialettica
materialista", qui la teoria, anche se nella accezione più alta
di filosofia, non è mai "pura". In essa permane
la "tendenza dominante" generata dalle sue interne contraddizioni.
A mio avviso, si tratta di una rettifica molto importante, che fa cadere
un'altra forzatura critica che anche ai nostri giorni si sente ripetere.
Cioè quella della mancanza in Althusser del senso del dialettico.
Anzi, della sua predilezione per un materialismo da cui sia bandito il termine
dialettico.
Più avanti vedremo meglio in che senso si può parlare di dialettica
quando ci si riferisce al pensiero di Althusser. Qui mi limiterò
ad accennare ai problemi del dubbio e delle contraddizioni che accompagnano
il suo lavoro. Chi come me ha avuto la fortuna di scambiare con lui direttamente,
sa che Althusser era l'incarnazione stessa del dubbio e ne era consapevole.
Voglio dire che nessuno più di lui viveva il dubbio come compagno
inseparabile del suo lavoro. E il dubbio lo spingeva a fare spazio, talvolta
eccessivo, alla ricerca delle contraddizioni all'interno delle sue stesse
tesi. Questa ansia metteva in moto il suo irrefrenabile stimolo di continua
rielaborazione del proprio pensiero. Ma, a parte le personali sensazioni,
sta di fatto che in questa Risposta la duplice natura delle qualità
filosofiche del marxismo viene continuamente ribadita, pur affermando "il
primato dell'essere sul pensiero".
Ma torniamo per un momento sulla pretesa che, in questa Risposta,
Althusser rivendica che il suo pensiero politico rappresenti l'ortodossia
marxista-leninista.
Ritengo che oggi un seguace di Althusser dovrebbe cominciare col mettere
in discussione la stessa opportunità di ricorrere al binomio Marx-Lenin
per affermare l'ortodossia del marxismo.
La rivendicazione delle ortodossie scatena sempre le più feroci guerre
di religione e poi credo non interessi a nessuno sapere oggi chi sono i
marxisti ortodossi. Viceversa, a parte la grande suggestione che scatenò
a suo tempo la "teoria dei cento fiori" di Mao-Tse-tung, ritengo
che il pensiero può dirsi veramente libero quando si presta a una
molteplicità d'interpretazioni.
Diversa è la questione della scientificità di una teoria.
Si richiede, in questo caso, che qualsivoglia affermazione sia sostenuta
dalla sua verifica empirica. Ovvero, da quello che Koyré ha definito
il "dialogo sperimentale". Vale a dire qualcosa che implica
sia la comprensione, sia la modificazione dell'assunto. Ma ciò che
più rileva sul nostro piano politico è che il primato della
"verità scientifica" venga assegnato a quello dei "cento
fiori" che si dimostrerà più in grado di attecchire nello
specifico habitat del comunismo.
E' nell'ottica della ricerca di una tale "verità" entro
il pensiero umano, che Marx aveva assegnato il primato alla prassi sulla
teoria[4]. Del resto, che neppure Althusser
fosse intimamente convinto che il suo pensiero politico rappresentasse l'ortodossia
marxista, lo dimostra il fatto che, ad appena quattro o cinque anni di distanza
dal suo pamphlet contro J. Lewis, comincerà ad elencare una serie
di problemi che Marx non aveva affrontato, o eluso, o, peggio, risolto attraverso
la contaminazione con la filosofia hegeliana. Lo farà al convegno
organizzato da "Il Manifesto", tra l'11 e il 13 novembre 1977.
Continuerà nel 1978, con lo scritto rimasto incompiuto dal titolo
Marx nei suoi limiti[5].
Non sono problemi di poco conto e uno di essi riguarderà, nientedimeno,
il criterio "contabile" con cui Marx aveva affrontato il problema
del plusvalore, sottraendo alla "teoria dello sfruttamento" quel
respiro ampio che, se sviluppato, avrebbe potuto evitare lo scadimento della
transizione al comunismo nell'economistica versione del socialismo di stampo
staliniano.
E' fuor di dubbio che il cosiddetto "criterio contabile" del plusvalore
abbia a che fare con la lettura che non solo Stalin, ma tutta la dirigenza
comunista ha dato delle teorie sul plusvalore. Ma addebitarne la colpa a
Marx, oltre che frutto di una attenzione parziale ai testi, a me sembra
uno scavalcamento della storia. I problemi che, entro il capitalismo, si
ponevano all'epoca della manifattura non possono essere confusi con quelli
che sono nati nell'età del postfordismo e della automazione del lavoro.
Ma converrà procedere per gradi. Sviscerare il problema in questa
sede potrebbe risultare ridondante rispetto alle categorie che hanno fin
qui sostenuto la polemica. Quelle che s'incontrano in questa Risposta,
sono, elencandole: le masse; il proletariato; la lotta delle classi; l'umanesimo;
lo stalinismo; e solo per inciso l'economismo[6].
Le Masse
Althusser, per una simmetrica contrapposizione alla categoria "uomo"
celebrata dagli idealisti, le chiama in causa all'inizio della sua replica
a J. Lewis. E facile però accorgersi che ne parla con un certo imbarazzo.
Si limita a dire: "In effetti le masse sono parecchie classi,
strati e categorie sociali raggruppate in un insieme talvolta complesso
e mutevole". E poco dopo aggiunge: "il soggetto/masse
pone dei seri problemi d'identità, d'identificazione. Un soggetto
è anche un essere di cui si può dire `è lui'. Per il
soggetto/masse, come si fa a dire: `è lui'?".
In realtà la parola diventa per Althusser soltanto un segno, una
espressione vuota che gli serve per introdurre la vera categoria che gli
sta a cuore:
Il proletariato.
Ed "è intorno al proletariato (la classe sfruttata nella
produzione capitalistica) che si unificano le masse che `fanno la
storia', nello specifico, la rivoluzione che esploderà nell'anello
più debole della catena imperialista mondiale".
In questo passo Althusser è veramente in odore di ortodossia. Un'ortodossia
in cui il bastone si è curvato tutto dalla parte di Lenin, giacché
Marx non avrebbe mai sottoscritto che la rivoluzione proletaria potesse
dare buoni frutti attaccando l'anello più debole della catena imperialista.
Ma qui s'impone una domanda che vorrei ripetere ai nuovi lettori per evitare
che, nella fretta di andare "oltre Marx", ci si liberi, come suol
dirsi, dell'acqua sporca buttando a mare anche il bambino. La domanda è
questa: si sono chiesti i critici di Marx da "sinistra" (?) perché
quest'uomo abbia speso un'esistenza ad analizzare così pedantemente
l'anatomia e la patologia del Capitale, mettendo in fila ben cinque
tomi, comprese le Teorie sul plusvalore?
Anche i marxisti che non sono andati fino in fondo nella lettura di questi
tomi sanno che il lavoro di Marx era legato a un obiettivo politico: scoprire
quale forza materiale, quale "agente storico", avesse potuto,
nelle condizioni date, essere in grado di portare a compimento la lotta
di emancipazione del proletariato.
Althusser non ha dubbi al riguardo. Risponderà anzi, con Balibar,
che sono le stesse condizioni dello sfruttamento a rendere la classe operaia
"capace di dirigere tutte le classi sfruttate", aggiungendo in
seguito che in questa impresa il proletariato verrà aiutato dalla
creazione "delle organizzazioni per la lotta di classe, che si pongono
all'avanguardia del movimento di tutti gli sfruttati per strappare il potere
di Stato alla borghesia".
Dunque fin qui sembrerebbe pacifico che l'agente storico di cui parlavo
prima sia il proletariato. Ma quale? Quello dell'epoca della manifattura,
del taylorismo e del fordismo, o della tuta e colletti bianchi dei nostri
giorni?
Ritornerò più avanti su questo tema. Per ora mi limito a far
risaltare una grande ovvietà, e cioè che il proletariato inteso
alla maniera del "lavoratore produttivo" alla "Cipputi"
è una specie in via d'estinzione nelle aree più sviluppate
del capitale. Non solo la rivoluzione non potrebbe contare su di esso, ma,
ammesso che se ne possa ingigantire la presenza, la conquista del "potere
di Stato" di cui parla Althusser non sarebbe in ogni caso qui possibile
con metodo democratico.
I partiti e i sindacati della classe operaia, i loro dirigenti, in tutti
questi anni hanno vissuto di rendita sull'operaismo. Ne hanno fatto il vessillo
con cui hanno coperto le varie contaminazioni borghesi del loro modo di
essere e di pensare. Nessuno meglio di Althusser ha descritto questa lenta,
ma inesorabile corruzione ideologica e solo di recente si sono levate da
noi voci isolate rivolte a fare luce sulla "sconcertante parabola dell'operaismo
italiano"[7].
Il risultato è stato che da almeno un ventennio la lotta delle classi
in Occidente è diventata una bestemmia e la stessa classe operaia
sembra essere caduta in letargo[8].
In compenso, gli automatismi normalizzatori del mercato "globale",
controllano (nel senso di una sommatoria a risultato zero) le pratiche contestative
(laddove esistono) della "sinistra", tradizionale o radicale che
sia.
Ma questa è una storia a sé, tutta da scrivere.
Per ritornare ad Althusser, si ha il dovere di aggiungere che già
in questa Risposta traspare netta la sua critica all'economismo e
alla tenacia con cui ha accreditato la versione "contabile" del
plusvalore. Purtroppo ne fa risalire la colpa fino a Marx, quando invece
prevalenti sono le responsabilità dei marxisti che, dopo di lui,
hanno cessato di analizzare ciò che accadeva a livello dell'organizzazione
del lavoro e della riproduzione della forza lavoro.
Non abuserò dello spazio che ho a disposizione per dimostrare questa
mia tesi. Elencherò invece, nello stesso ordine con cui sono apparsi
negli scritti postumi di Althusser, gli altri aspetti di deficit analitico
del marxismo. Sono i problemi della natura dello Stato entro le società
imperialiste; del funzionamento dei sindacati e dei partiti operai irretiti
nel gioco dello Stato borghese; del come stabilire rapporti non strumentali
col movimento di massa; del come superare le tradizionali divisioni fra
la sfera economica e la sfera politica; del come assecondare infine un reale
deperimento della funzione dello Stato.
Il lettore che ne avrà interesse potrà trovarne sviluppi più
dettagliati nel già citato Marx nei suoi limiti, ma è
altresì chiaro che altra acqua, dopo Althusser, è passata
sotto i ponti della storia e che i marxisti, se non si sono completamente
mummificati nel riformismo, farebbero bene a considerarli insieme a tutte
le altre acquisizioni che il progresso scientifico ci ha nel frattempo consentito
di ricevere.
La lotta delle classi
E' il vero punto di forza di questa Risposta. Ma non per la riproposizione
di una formula, quanto per la funzione chiarificatrice che la lotta delle
classi assume nelle scelte di campo. Il semplice appellarsi alle classi
non è infatti di per sé segnale di rotta verso il comunismo.
E' il ruolo che si attribuisce a queste lotte che fa da spartiacque fra
un rivoluzionario e un riformista. Se ci si limitasse a dire che sono le
classi (o peggio le masse) a fare la storia al posto dell'uomo, si tratterebbe,
come lo stesso Althusser riconosce, di una questione meramente nominalistica.
La differenza sostanziale, la presa di distanza del marxismo scientifico
dall'idealismo sta nel ruolo che viene attribuito alla lotta: "la lotta
delle classi è il motore della storia" aveva già proclamato
Marx.
E quale esempio più riuscito, da parte di Althusser, delle due squadre
di rugby? Gli uni (i riformisti) si limitano ad osservare che in campo sono
schierate due squadre prima della partita; gli altri (i rivoluzionari) ritengono
che classi e lotta di classe siano concetti inseparabili. Senza la lotta,
le classi non esisterebbero neppure. Ed è durante il loro scontro
che si può capire chi è schierato da una parte e chi dall'altra.
Ne consegue che in assenza della lotta delle classi, il movimento della
storia si arresta. Al limite la sua ruota potrebbe girare all'indietro.
Ma converrà a questo punto fare un breve richiamo storico perché
anche il lettore più giovane possa capire l'importanza della posta
in gioco.
Quando Althusser ribadisce questi concetti siamo negli anni in cui il marxismo
occidentale trova il suo punto di forza nella riscoperta dell'"umanesimo
socialista". Ne consegue che la sua intellighenzia si produce
nell'esaltazione delle qualità dell'uomo antropologico che l'organizzazione
capitalistica del lavoro ha nel frattempo asservito alla forza produttiva
delle macchine.
Parallelamente, sul piano della risposta politica a questo stato di asservimento,
i partiti della classe operaia puntano sulla trasformazione graduale dell'organizzazione
del lavoro, attraverso due fondamentali strumenti: la lotta economica guidata
dai sindacati e la lotta politica guidata dai partiti. E' il classico modello
della via democratica al socialismo, ma gli avversari del proletariato,
caricaturalmente, attribuiranno questa strategia al modello sovietico. Eppure
non potevano ignorare che in URSS i sindacati disponevano di un potere soltanto
decorativo e che la conquista dello Stato non poteva avvenire per via elettorale,
dal momento che il "pluralismo" e le procedure elettorali non
facevano parte dell'armamentario della legislazione sovietica.
La scelta strategica dei partiti operai europei verrà, in un primo
tempo, ricompresa sotto la parola composita social-democrazia. In
un secondo tempo, e cioè dopo la caduta del muro di Berlino, si scinderà
nel binomio socialismo-riformista. Oggi che anche il "socialismo"
è diventato una parola sospetta, si usa dire più anodinamente
riformismo, amalgamando in esso tutto ciò che può essere
ricondotto a un generico populismo sociale.
Come si vede, mettere al centro il problema della lotta delle classi non
è questione di semplice restauro filologico. E', come si è
detto, necessità di istituire un discrimine politico che possa separare
il marxismo dall'intruglio del riformismo.
Ma mettere al primo posto la lotta delle classi, avverte opportunamente
Althusser, implica analizzare la materialità della lotta e
"questa materialità è in ultima istanza, l'unità
dei rapporti di produzione e delle forze produttive sotto i Rapporti
d'un modo di produzione dato, in una formazione sociale storicamente concreta".
Questa precisazione, nell'economia della Risposta, ha un valore decisivo
perché si tratta di eliminare dalla rosa delle spiegazioni possibili
sul farsi della storia quella più astratta e inconcludente della
"trascendenza". Si afferma perciò la funzione decisiva
della lotta delle classi nella fondazione del marxismo come "scienza
della storia". Althusser fa derivare la nascita di questa scienza dalla
elaborazione da parte di Marx di tutta una serie di nuovi concetti: "il
modo di produzione", le "forze produttive", i " rapporti
di produzione", "infrastruttura-sovrastruttura, ideologie",
ecc. Ma il fondamento teorico di essa starebbe tutto nella cosiddetta "rottura
epistemologica" del 1845.
Già in Leggere il Capitale Althusser aveva sostenuto che la
scienza nasce come "sorpresa" dell'ideologia a seguito di una
rottura epistemologica che si verifica al suo interno[9].
Qui rettifica e si rammarica di aver "pensato la filosofia col modello
delle scienze". Viceversa, "la filosofia è soltanto la
politica nella teoria". La sua evoluzione segue perciò i tempi
e le fasi alterne della politica, con la possibilità che in essa
ritornino saltuariamente vecchie categorie. Ma poi conclude che "nel
caso di Marx, possiamo dire che tutto accade `in contemporanea': rivoluzione
filosofica e rottura epistemologica. Ma è la rivoluzione filosofica
che determina la "rottura epistemologica"[10].
A mio avviso (ma non soltanto mio), non sono argomenti sufficienti per elevare
a statuto di scienza della storia i risultati di un'analisi economica
che copre un arco limitato di tempo. Né la geniale intuizione di
essere la lotta delle classi il "motore della storia" può
essere considerata la causa che spiega, sia pure in ultima istanza, l'intero
movimento della storia. Non ho dubbi, però, che, in quanto metodo
di analisi materialista della storia, il marxismo si mostra ancora oggi
insostituibile, o perlomeno valido per comprendere i processi storici al
riparo dalle diverse opzioni ideologiche. Ed è a partire da Marx
che la meta, del socialismo esce dalla vaghezza del saintsimonismo, dell'owenismo
e del proudhonismo per diventare un traguardo da perseguire scientificamente.
E qui sospetto che si apra un baratro davanti a me, su cui si fermeranno
attoniti anche i miei compagni di strada.
Sì, perché è inutile nasconderlo, parlando di meta,
di traguardo del marxismo, ripropongo inevitabilmente il problema del télos.
A differenza dei filosofi, ho però la fortuna di potermi scaricare
di dosso questa sofisticatissima querelle. Da interessato analista
dei fatti storico-sociali, non posso invece non tener conto che in nome
del fine del socialismo milioni di uomini hanno lottato e sono morti in
ogni parte della terra, lasciando a poche decine di filosofi il gusto di
discettare intorno al rapporto fra materialismo e finalismo.
Certamente, anche Althusser con l'affermazione della storia come processo
senza soggetto(i), né fine(i), spezza una lancia contro il finalismo.
Ma attenzione! Un conto è il fine nell'accezione deterministica di
Hegel, un altro il fine della lotta delle classi che diventa motore della
storia. Un motore, lo sa bene qualsiasi meccanico, può portare la
macchina fino al traguardo, o andare "fuori giri", o addirittura
"grippare". Non è detto perciò da nessuna parte,
tranne che nel vaticinio politico del Manifesto del Partito Comunista,
che la società capitalistica approderà trionfalmente alla
società comunista. Torna perciò a merito di Althusser l'aver
distinto fra Marx ancora contaminato da hegelismo e Marx che si è
lasciato Hegel definitivamente alle spalle. In questa seconda età
di Marx, e in particolare in base a quanto si può leggere nel Libro
III de Il Capitale, nelle Teorie sul plusvalore e nella parte
seconda dei Grundrisse, in Marx è ben presente la consapevolezza
che per ogni tendenza al "crollo" del sistema capitalistico si
sarebbero sviluppate altrettante controtendenze che ne avrebbero ritardato,
o evitato, l'evento[11].
Spiace perciò dover constatare che in questa Risposta, per
un rigurgito di ortodossia, proprio Althusser dimostri di cadere, sia pure
accidentalmente, nella trappola del finalismo[12].
E però, in questo stesso pamplhet, la voce di Althusser si fa solenne
quando ammonisce: "I comunisti, quando sono marxisti, e i marxisti,
quando sono comunisti, non parlano mai al vento".
Con qualche taglio tipografico, abbiamo elevato questo monito a titolo della
presente riedizione della Risposta, proprio perché convinti
che il marxismo, indipendentemente dal suo esito comunista, non sia un semplice
rizoma della storia, ma la radice profonda di un albero secolare che dovrà
dare ancora i suoi frutti. Ma già ora, pur con le sue inevitabili
contraddizioni interne, il testo che stiamo presentando costituisce, a mio
avviso, un primo, fondamentale contributo che Althusser dà alla definizione
di un materialismo dialettico assai diverso dal suo significato storico.
Ho sottolineato provocatoriamente l'aggettivo "dialettico" perché
sarebbe ora, da tutte le parti, di smetterla di giocare sull'equivoco. La
dialettica di cui parlano Althusser e i marxisti che a lui si richiamano
non è il "diamat" di tradizionale memoria. E neppure il
semplice rovesciamento della dialettica hegeliana. Non ha niente a che vedere
con la "negazione della negazione", o con la semplice opposizione
"astratto-concreto".
E' piuttosto il presentarsi di una molteplicità di determinazioni
nella produzione di un fatto, di un evento in cui, però, una sola
di queste determinazioni si dimostra più incidente delle altre, segnando
così una differenza rispetto alle altre. Ed è in questa differenza
che in Althusser s'inscrive il concetto di dialettica, o di contraddizione
surdeterminata[13].
Con diverso codice, un altro illustre scienziato di Francia, Henri Laborit,
studiando le strutture informative del cervello umano, chiama la sintesi
di questa molteplicità di determinazioni "auto-organisation"[14].
Umanesimo e stalinismo.
Era il titolo che, nella prima edizione italiana della Risposta a
J. Lewis, l'editore De Donato aveva dato a questo pamplhet di Althusser.
Se non l'abbiamo mantenuto non è per distinguerci dalle scelte altrui.
E' che a distanza di trent'anni lo stalinismo non è più evocativo
di altri "ismi" e l'umanesimo ha perso il fascino rinascimentale
che da noi ha sempre esercitato. Contrapporremo all'umanesimo fra qualche
istante una categoria meno soggettiva, più "globale" e
più aderente alla hidden hand che governa il mondo, cioè
il mercato. Il che non ci impedirà di rivolgere un po' di attenzione
anche allo stalinismo.
Althusser non banalizza la figura di Stalin, riducendola a quella, oggi
così ricorrente, del despota sanguinario, macchiatosi di tutte le
nefandezze umanamente concepibili. Anzi ne mette in risalto, come sarebbe
dovere di ogni storico, il ruolo che ha avuto nel fare da argine al nazismo
e di avere invertito, con Stalingrado, la marcia trionfale della wermacht.
Commette, a mio avviso, anche l'errore di elogiarlo per la decisione con
cui, contro il parere di Trotski, decise di portare avanti la costruzione
del socialismo in un solo paese. Ma ciò che non gli sembra tollerabile
è la riduzione della "deviazione staliniana" ai concetti
di "culto della personalità" e di "violazione della
legalità socialista", così come in tutta Europa avevano
fatto gli apparati comunisti. Sarebbero proprio questi due concetti, secondo
Althusser, a mettere in evidenza l'avvenuta contaminazione borghese del
comunismo sovietico e occidentale.
Contaminazione ascrivibile, del resto, alla linea strategica adottata fin
dal 1930 dalla III Internazionale, sotto la guida di Stalin. La saldatura
fra umanesimo e stalinismo avviene proprio nella propensione a credere che
il peso della "personalità" sia decisivo nella determinazione
dei fatti storici e che le cause di avvenimenti anche gravi per le sorti
di intere popolazioni siano da ricercare nelle pratiche della sovrastruttura
giuridica (violazione della legalità socialista). Viceversa,
per un marxista, le degenerazioni di un sistema sono sempre da ricercare
all'interno delle sue contraddizioni. Dirà perciò
che una critica di sinistra che accetti di parlare di deviazione e che si
affidi, per definirla, alla ricerca corretta delle sue cause storiche fondamentali,
non si soffermerà sull'"Uomo", o la "Personalità",
ma indagherà sulle forme della sovrastruttura, sui rapporti di produzione,
quindi sullo stato dei rapporti di classe e delle loro lotte, e solo a quel
punto potrà parlare del diritto violato, ma anche dei motivi della
violazione.
Umanesimo e economismo
E' venuto il momento di ritornare su quello che poche pagine più
indietro abbiamo chiamato necessità (avvertita da Althusser negli
ultimi tempi) di mettere mano a una teoria dello sfruttamento che non sia
risolvibile in termini puramente contabili. Detto più esplicitamente
si tratta della cruciale questione del plusvalore, che qui, per evitare
prevaricanti sconfinamenti, tratterò tenendo conto solo dei pochi
accenni contenuti in questa Risposta.
Mi spiego. L'umanesimo presente nella versione idealistica del marxismo
- rileva Althusser - nella prassi storica dei partiti operai, ha sempre
fatto coppia organica con la interpretazione deterministica dello sviluppo
capitalistico. Dirà infatti: "Dietro le categorie astratte della
filosofia, che le servono di facciata, è questa la coppia che volevo
prendere di mira, attaccando congiuntamente, e l'umanesimo teorico (intendo
dire, non una parola o qualche frase, o anche delle fertili prospettive,
ma un discorso filosofico in cui `l'uomo' diventa una categoria con funzione
teorica) e l'economismo, in cui le forme volgari dell'hegelismo e
dell'evoluzionismo fanno corpo comune. Perché dopo Marx, nessuno
(o almeno nessun marxista rivoluzionario) può sbagliarsi : quando
in piena lotta di classe le litanie umaniste occupano il primo piano della
scena teorica e ideologica, alle spalle c'è sempre l'economismo che
vince"[15]. E poi spiega: dietro
la storia dei Diritti dell'Uomo c'è Bentham (il fondatore dell'utilitarismo
borghese) che trionfa; dietro l'idealismo neokantiano di Bernestein (il
massimo teorico della socialdemocrazia tedesca) è la corrente economista
che trionfa.
Si tratta di constatazioni inoppugnabili. Da documentare, semmai, per allontanare
il sospetto che possa trattarsi di mere affermazioni ideologiche. Ho però
già accennato prima al salto storico che si compirebbe affrontando
il discorso del plusvalore, così come l'ha impostato Marx all'epoca
della manifattura, con i parametri dell'attuale organizzazione del lavoro.
Adesso è il momento di aggiungere che il criterio "contabile"
non è l'unico con cui Marx si rapporta al problema dello sfruttamento
capitalistico, che poi è l'altra faccia dell'espropriazione del plusvalore.
Già Raniero Panzieri, nel suo magistrale Plusvalore e pianificazione,
aveva evidenziato come l'espropriazione del plusvalore operaio si traduca
in una crescita continua del potere del capitale e come a porre un
limite a questa crescita non ci sia altra forza che quella della "resistenza
della classe operaia"[15].
Il potere di per sé non è una categoria contabile, ma, se
non bastasse questa interpretazione isolata, andando a spulciare in ciò
che Marx si riprometteva di sviluppare nel suo Il Capitale, se la
morte non glielo avesse impedito, ci accorgeremmo che nei suoi Grundrisse
Marx aveva gia annotate le probabili trasformazioni qualitative
della sfera capitalistica di produzione. E' il lungo elenco che il lettore
troverà in nota a piè di pagina e che contempla la maggior
parte dei lavori che i nostri economisti si ostinano a chiamare "improduttivi",
quando invece costituiscono la fonte primaria di plusvalore che accresce
il potere non solo economico del capitale[16].
Il fatto che tutti questi lavori contribuiscono, chi direttamente, chi indirettamente,
all'accrescimento del potere capitalistico, dovrebbe di per sé aiutare
nella ricerca, che prima ponevo, dell'attuale agente storico della rivoluzione.
Non posso però non considerare che le opzioni ideologiche, da un
lato, e gli effetti materiali delle attuali divisioni internazionali del
lavoro, dall'altro, rendano quanto mai problematica una classificazione
univoca dell'attuale composizione di classe. Ciò che mi premeva e
mi preme affermare per il momento è però che l'uso contabile
del concetto di plusvalore, più che a Marx, si debba imputare ai
partiti e ai sindacati riformisti, che, per giustificare la loro vocazione
centrista, hanno bisogno di dilatare il concetto di ceto medio.
In quanto ad Althusser, ora che il discorso si avvia alla sua naturale conclusione,
converrà fare un accenno a quelle che sono state considerate le sue
nuove "aperture" degli anni '80.
Inizierò dal rapporto fra caso e necessità, che, come opportunamente
ha ricordato di recente Maria Turchetto, ha suscitato l'interesse di Althusser
fin dai tempi dela sua IV lezione introduttiva al "corso di filosofia
per operatori scientifici" (ott./nov. 1967)[17].
Né io, né altri più documentati di me possono affermare
che Il caso e la necessità di Monod abbia alla distanza ispirato
il "materialismo aleatorio" di Althusser. Di sicuro sappiamo,
e Maria Turchetto ce lo conferma, che Althusser giudicava quella di Monod
"una teoria idealista della storia", basata sulla "credenza
che siano le idee che governano il mondo". La riprova di questo
giudizio non ci viene soltanto dalle affermazioni dello stesso Monod, o
dalle critiche di Althusser. Ce la dà indirettamente un altro Nobel
della chimica, Ilya Prigogine, quando scrive che "La scienza moderna
atterriva sia i suoi oppositori, che la consideravano un'avventura inaccettabile
e minacciosa, sia alcuni dei suoi sostenitori, come Monod, che hanno visto
nella solitudine scoperta dalla scienza il prezzo da pagare per questa nuova
razionalità"[18]. La solitudine
in cui si crogiola Monod nasce dalla sua personale convinzione (idea che
si dimostrerà vera solo a metà, grazie agli esperimenti di
Prigogine) di essere la natura passiva e morta e che, una volta programmata,
segue eternamente le regole scritte nel suo programma. La scoperta, questa
sì veramente rivoluzionaria, di Prigogine sta invece nella dimostrazione
che la natura è cieca e sorda solo in situazione di equilibrio. In
situazione di lontananza dall'equilibrio, e in particolare in prossimità
dello loro biforcazioni, i sistemi naturali diventano sensibili anche a
una piccola fluttuazione proveniente dall'ambiente. Possono allora cambiare
anche drasticamente il loro comportamento e interagire con le stesse azioni
dell'uomo. "Non si può sfuggire all'analogia con i problemi
sociali, addirittura con la storia. - Lungi dall'opporre `caso e
necessità' cominciamo a vedere come entrambi questi aspetti siano
essenziali nella descrizione dei sistemi non lineari lontano dall'equilibrio"[19].
Una tale acquisizione scientifica, in nessun caso sospettabile di derivazione
ideologica, perché scaturita da ripetute prove sperimentali, suggerisce
anche di porre diversamente la separazione fra "scienze della natura
e scienze storico-sociali" di weberiana memoria. Ma la cosa che ci
riguarda più da vicino è se una eventuale teoria del materialismo
aleatorio, o dell'"incontro" che dir si voglia, possa ancora oggi
poggiare su un ingenuo atomismo epicureo, dal momento che, come sottolinea
sempre Prigogine, il comportamento di un "orologio chimico" è
assai diverso da quello caotico della polvere che danza nell'aria.
E veniamo ora al deperimento dello Stato. Se il marxismo vuole costituirsi
come metodo scientifico e insieme perseguire l'obiettivo di un salto qualitativo
nella strutturazione dello Stato, diventa maggiormente d'obbligo fare i
conti con le categorie di "entropia" e "soglia di
nucleazione". Dovrà uniformarsi, cioè, nella sua azione
ai comportamenti dei sistemi complessi lontani dall'equilibrio e soffermarsi
sulla formazione delle "fluttuazioni pericolose" e delle
"strutture dissipative"[20].
L'uomo non fa la storia, ma agisce in essa - ci ricorda saggiamente Althusser
- e in questo agire c'è anche l'azione nella natura, che può
accelerare i tempi della catastrofe, ma può anche anticipare quel
cambiamento di stato a cui il nostro sistema sociale è destinato
ad andare incontro, via, via che si allontana dal suo iniziale stato di
equilibrio.
C'è un bellissimo passo di Hobsbawm che amo ricordare ora che mi
avvio a concludere: "Come un `surfer' il rivoluzionario non crea
le onde su cui si muove, ma si limita a tenersi in equilibrio su di esse.
A differenza del `surfer' - e qui sta la differenza fra il rivoluzionario
serio e la prassi anarchica - prima o poi smette di correre sull'onda
e deve controllare la sua direzione e il suo movimento"[21].
Non so quanto sia opportuno parlare di rivoluzione e di rivoluzionari nel
terzo millennio. C'è ancora chi fa fatica a capire che la rivoluzione
con la r minuscola non è legata all'evento catartico, irripetibile
a cui solo pochi privilegiati possono assistere, ma si compie - quando se
ne ha la vocazione - giorno per giorno cominciando col mettere in discussione
gli schemi e le certezze del giorno prima.
Nel mare della vita chi ama la libertà nel cambiamento
deve imparare a osservare il moto delle onde prima di saltare sul suo surf.
Questa dovrebbe essere la prima regola da osservare per chi, senza avere
la pretesa di farla, vuole agire nella storia. Imparerà così
a conoscere che il mare della storia gli si presenta, ora come necessità,
con le sue leggi di galleggiamento legate alla statica dei fluidi, ora come
caso, affidato ai capricci del vento e delle correnti.
La seconda regola è certamente la più difficile da osservare.
Per darsi una direzione anche il surfer ha bisogno di un télos.
Qui scatta quel pericolo che dicevo di trovarsi soli davanti al naufragio.
Oppure, quello più ricorrente che, al limite del télos,
si finisca per mettersi alla ricerca di théos. E quanti navigatori
degli albori hanno finito per fare rotta verso il Sole vedendolo salire
sull'orizzonte! E però, se il navigatore, prima di salpare le ancore,
si dà una rotta, questo vuol dire che si è attrezzato con
le carte e sa dove volere approdare. Non è stato però sempre
così e le più grandi scoperte si sono avute quando la meta
risultò diversa da quella prevista. L'umanità non avrebbe
conosciuto nessuna rivoluzione se coloro che hanno agito nella storia avessero
avuto chiari fino in fondo i loro approdi.
Ma come si concilia allora l'amore per l'ignoto con la necessità
che ha il surfer rivoluzionario di controllare la sua direzione e
il suo movimento? Qui si ritorna al problema della scienza, che però
è problema sia di "verificazione", sia di "falsificazione",
come propone K. R. Popper. Nell'uno e nell'altro caso, però, non
c'è "vero" e non c'è "falso" che non debba
essere provato nella prassi. Ma è la teoria che illumina la prassi
e non c'è prassi rivoluzionaria (ci ricorderebbe il nostro Althusser)
senza teoria rivoluzionaria.
Ebbene, contraddicendo il mio maestro, azzarderò di dire che le cose
non stanno esattamente così. Intendo sostenere cioè che mi
trovo d'accordo con la prima proposizione, non con la seconda: nessuna prassi
può essere attivata senza il supporto della teoria, ma non è
detto che quest'ultima debba essere pregiudizialmente "rivoluzionaria"
per attivare una prassi rivoluzionaria. Oltretutto, chi può giudicare
se una teoria è rivoluzionaria prima ancora che la prassi ad essa
riconducibile possa confermarlo?
Nessuna teoria è di per sé rivoluzionaria o conservatrice.
Può risultare solo in parte o totalmente vera, parzialmente o totalmente
falsa. Prima di questa dimostrazione - che è affidata alla prassi
- alla teoria si può chiedere solo che la sua struttura linguistica
risulti coerente con i suoi enunciati assiomatici e denotativi.
Alla teoria si richiede perciò una perfezione che la prassi
non può e non deve conoscere. Una perfezione che s'imponga alla nostra
ammirazione con la stessa "gaudiosa apparenza" che l'artista apollineo
rivive nel mondo figurativo del sogno.
Una "gaia scienza" dunque, ma non nel senso nietzschiano di una
"coscienza come prodotto di una socializzazione gregarizzante",
ma di una conoscenza maturata attraverso il gusto della forma, l'incisività
del segno, la perfezione delle geometrie. Un modo quindi di superare anche
l'antinomia arte-scienza, senza che la prima scada nell'imitazione di quanto
già appare e la seconda nella spiegazione di quanto è già
nelle apparenze.