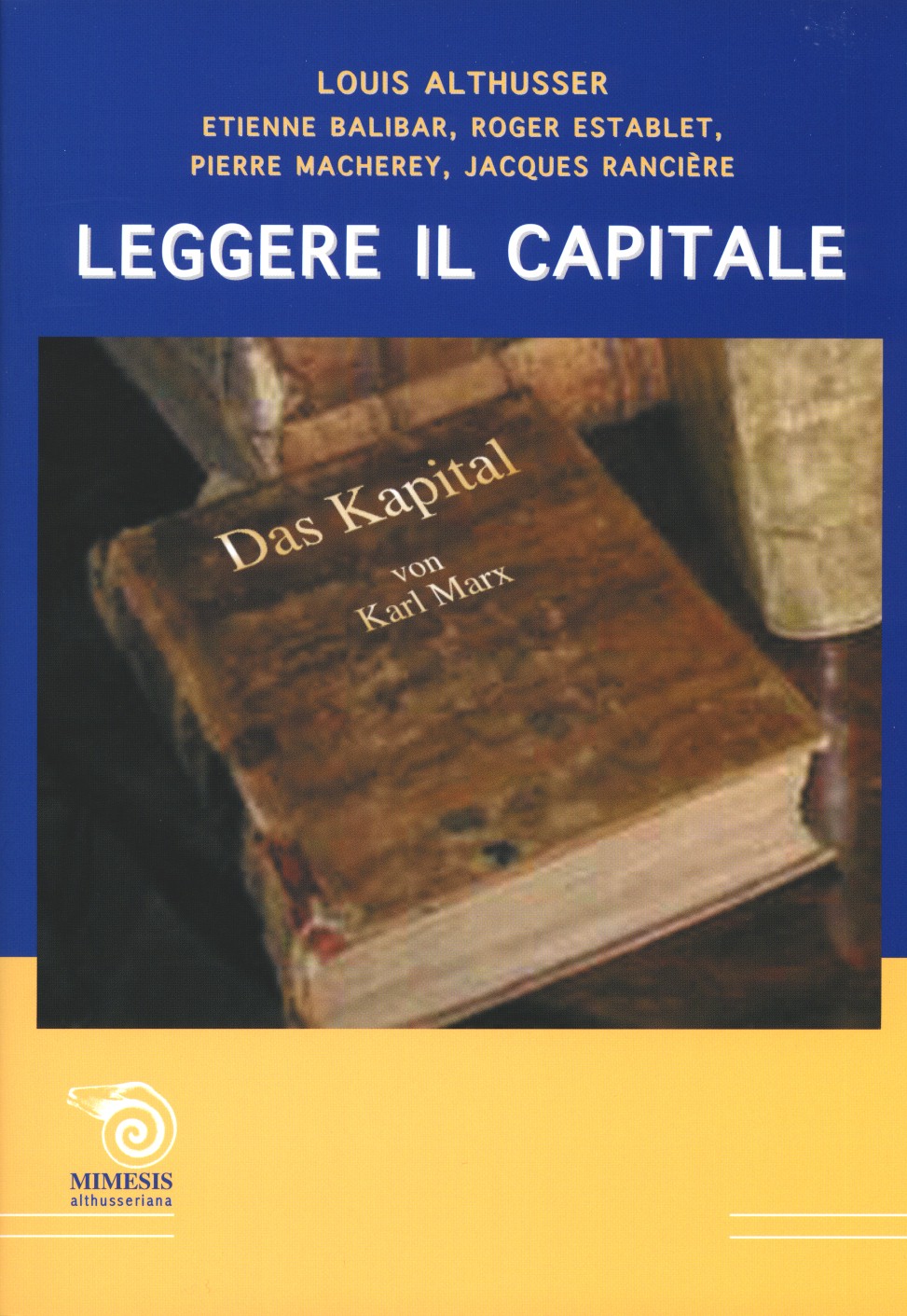
Leggere il Capitale
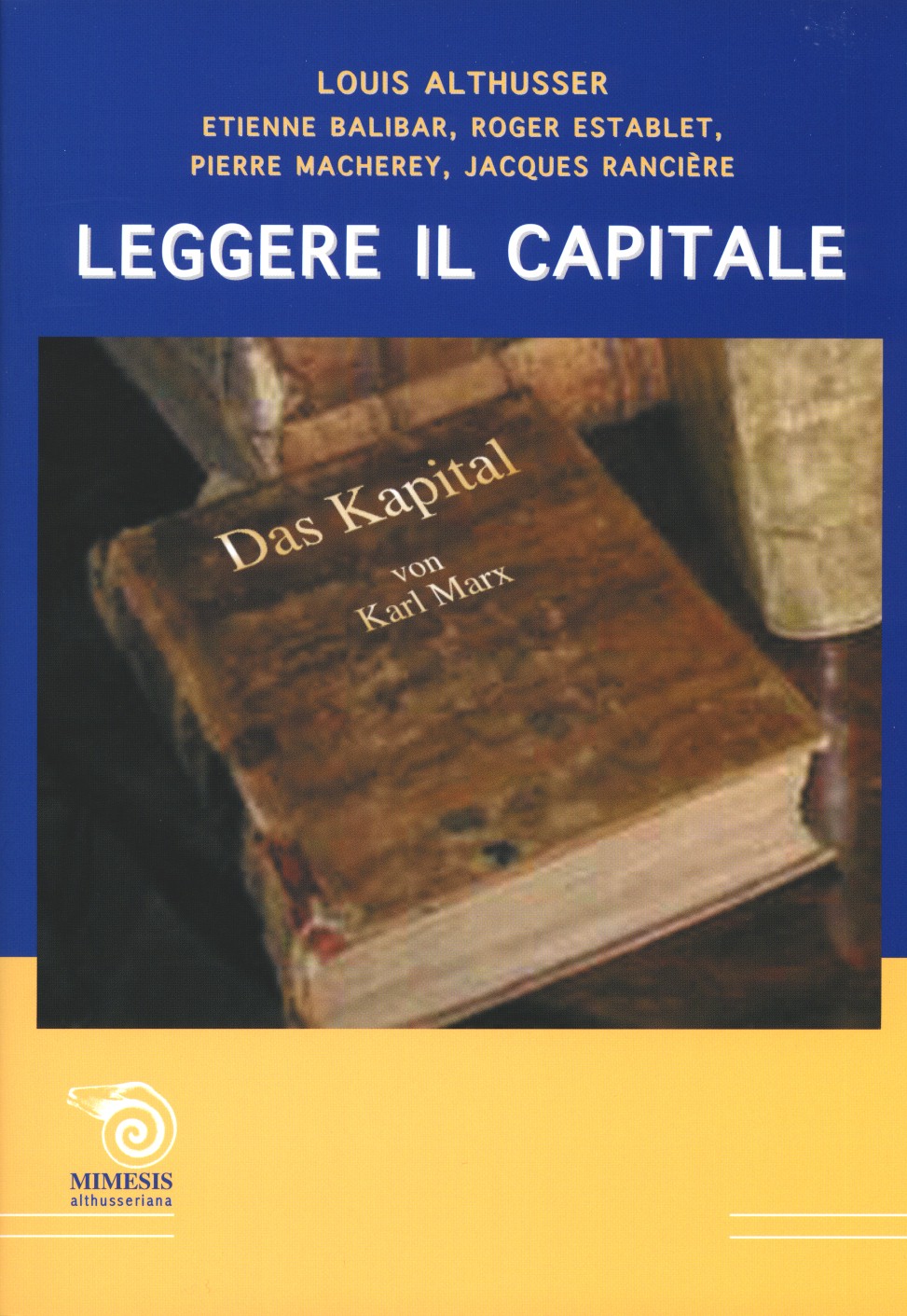 |
L. Althusser, E. Balibar, R. Establet, P. Macherey, J. Rancière, Leggere il Capitale |
recensione
di Gianfranco La Grassa
Si tratta della prima edizione italiana completa del seminario tenuto da Althusser e allievi nel 1964-65 all’Ecole Normale Supérieure (Parigi). Impossibile in poche righe sintetizzare le complesse argomentazioni svolte, avendo come obiettivo un radicale ripensamento (e rilettura) della massima opera di Marx. Meglio esporre, telegraficamente, come all’epoca colsi (e molti altri con me) il significato, profondamente rivoluzionario, del testo in esame. Ovviamente non ne feci, né faccio adesso, una lettura da filosofo, bensì da economista e teorico della società, per lungo tempo vicino a Bettelheim, economista marxista profondamente influenzato dall’althusserismo.
Contro lo storicismo e la concezione di un evolversi della società regolato dal predominante influsso dello sviluppo delle forze produttive – ad opera di un soggetto umano guidato dalla teleologia del suo lavoro (tutta la tematica dell’“ape e l’architetto”, mi auguro nota per l’essenziale) – il lavoro teorico della scuola althusseriana riponeva al centro del pensiero marxiano l’analisi strutturale, cioè quella dei rapporti sociali (di produzione). In definitiva, secondo la mia opinione, Leggere il Capitale è una raffinata, profonda e assai ramificata ed estesa riflessione sulle tesi contenute in poche e sommarie righe di Marx nella prefazione a Il Capitale: “…qui si tratta delle persone soltanto in quanto sono la personificazione di categorie economiche, incarnazione di determinati rapporti e di determinati interessi di classi. Il mio punto di vista, che concepisce lo sviluppo della formazione economica della società come processo di storia naturale, può meno che mai rendere il singolo responsabile di rapporti dei quali esso rimane socialmente creatura…”(corsivi nel testo).
Le determinanti sociali degli individui sono le strutture dei rapporti; ed è tramite l’analisi di queste che, per dirla con Althusser, Marx aprì alla scienza il “Continente Storia”. Concentrare l’indagine su queste strutture – come si propone e si fa in Leggere il Capitale – significa apportare un colpo decisivo allo schema “classico” del marxismo economicistico della tradizione: lo sviluppo delle forze produttive incontra, al suo “massimo” livello, l’ostacolo rappresentato dal vecchio involucro dei rapporti di produzione (pensati come relazioni di proprietà dei mezzi produttivi); questo involucro viene dunque spezzato; tutta la “sovrastruttura” politico-ideologica che si erge su quella “base” (rapporti di produzione) viene rovesciata e trasformata. Senza alcuna sottovalutazione dei problemi dello sviluppo, la lettura althusseriana di Marx pone l’accento sul rivoluzionamento dei rapporti sociali; di cui si deve però conoscere la struttura in quanto da essa nasce tutta la problematica della lotta tra le classi (dominanti e dominate). L’Uomo, con la sua Teleologia del (e nel) Lavoro, viene espunto dalla scienza della “Storia”. Inoltre, la struttura sociale non è soltanto di tipo economico-produttivo; essa è composta complessamente da rapporti economici, politici, ideologici (con i loro differenti apparati tipo impresa, Stato, scuola, ecc.). Questa struttura complessa è a dominante, dove quest’ultima può essere rappresentata dalla sfera sociale economica o invece da quella politico-ideologica; ferma restando solo la, marxianamente ben nota, “determinazione d’ultima istanza” da parte dell’economico.
Difficile rendere conto dell’impatto che ebbe la teorizzazione althusseriana sulla lotta politica e ideologica di quel tempo. Lo storicismo e l’umanesimo si fondavano profondamente sulle tesi (evoluzionistiche e gradualistiche) dello sviluppo delle forze produttive. La “via italiana al socialismo” del PCI, la politica del PCF, ecc. – in genere le politiche dei comunisti detti “revisionisti” – erano pregne di tesi simili. Leggere il Capitale (così come le successive opere althusseriane) furono un attacco radicale nei confronti dell’opportunismo che si affidava all’evoluzione storica, di fatto orientata dallo sviluppo produttivo secondo modalità (strutture di rapporti) capitalistiche (anche nei paesi detti “socialisti”). Quella battaglia ideologica fu persa proprio per l’irriformabilità del “comunismo”. Non ci si poteva rendere conto del fatto a quell’epoca, ma proprio la “storia” ha dimostrato che non è più possibile la semplice rielaborazione, pur radicale, del pensiero di Marx.
Tuttavia, a modesta opinione di chi scrive, Leggere il Capitale resta uno spartiacque per qualsiasi nuova riflessione critica intorno al capitalismo. Bisogna ormai fuoriuscire più decisamente dal marxismo, ma senza rispolverare l’Uomo, la Teleologia, ecc. L’opera althusseriana va continuamente riletta soprattutto per quanto concerne l’imprescindibile esigenza dell’analisi strutturale (della struttura dei rapporti sociali). Altrimenti addio scienza del “Continente Storia”!
(pubblicata su L'indice dei libri del mese)