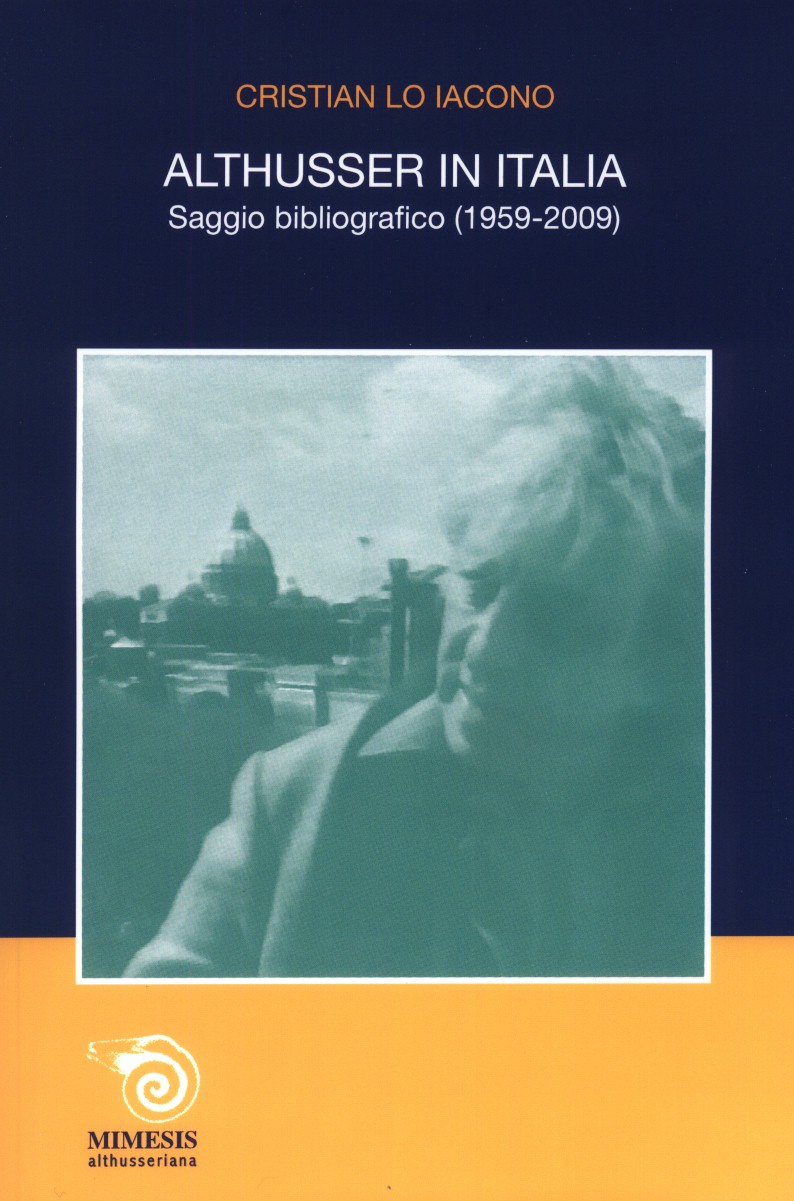
Althusser in Italia. Saggio bibliografico (1959-2009)
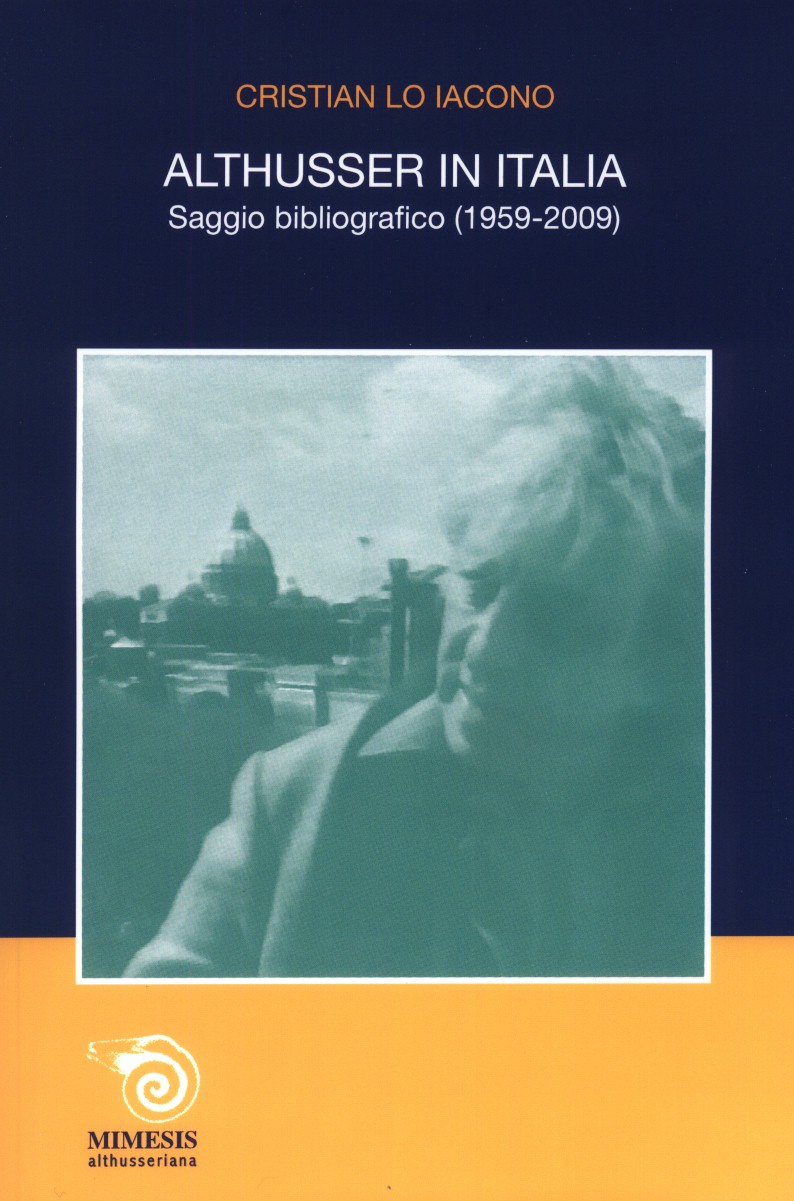 |
Cristian Lo Iacono Althusser in Italia. Saggio bibliografico (1959-2009) |
di Andrea Girometti
È «uno strumento di lavoro» il testo redatto da Cristian Lo Iacono, pubblicato nella collana “Althusseriana” dell’editore Mimesis curata dall’Associazione culturale “Louis Althusser” (Althusser in Italia. Saggio bibliografico 1959-2009, Milano-Udine, 2011, pp. 276). Ed è un esempio di letteratura secondaria di qualità, come ricorda Maria Turchetto nella Prefazione, orientato alla ricerca e il più possibile utile agli studiosi. Lo Iacono ripercorre e ricompone gli sconnessi interventi su e di Althusser in Italia nel corso degli ultimi cinquant’anni. Dalla prima recensione che Norberto Bobbio nel 1959 dedicò a Montesquieu, la politique et l’histoire alla nuova ricezione, successiva alla scomparsa del filosofo francese e alla pubblicazione di gran parte degli inediti, perlopiù incentrati sull’abbozzo – suggestivo e in progress – di un'inedita corrente sotterranea filosofica denominata materialismo aleatorio. Il libro si articola in un saggio introduttivo dell’autore e nella ricostruzione, in ordine cronologico e tramite agili schede descrittive, di un vasto repertorio bibliografico. Nel complesso si contano oltre 500 records tra monografie, articoli e saggi. Un lavoro imponente di spoglio, catalogazione e (in gran parte) consultazione diretta. La costruzione di una vera e propria “bibliografia primaria”. L’oggetto della ricerca non è solo Althusser ma l’althusserismo, includendo nel repertorio i testi (e la ricezione dei medesimi) degli ex-allievi, perlomeno nella fase antecedente alla frammentazione del gruppo. Lo Iacono si sofferma, in prima battuta, sul concetto di ricezione critica – riprendendo la lezione epistemologica althusseriana condensata nella produzione di effetti – sottolineando il carattere dirimente, nella selezione bibliografica, della «tracciabilità di quei fenomeni di ricezione testimoniati dalle traduzioni, dalle recensioni, dai saggi» che ne attestano «l’effettiva e documentabile presenza nel dibattito italiano». Un concetto complesso di ricezione. Di più: surdeterminato – come precisa nel primo capitolo – e per almeno tre motivi: 1) è innanzitutto Althusser a scoprire l’Italia e ad assimilarne il dibattito filosofico e politico; 2) il filosofo francese interviene direttamente e/o indirettamente in tale dibattito; 3) le “sfasature temporali“ relative alla pubblicazione delle sue opere hanno condizionato oltremisura, rispetto ad altri autori, contenuti ed obiettivi dell’impresa althusseriana. È dunque Althusser a scoprire nei primi anni ’60 il marxismo italiano, e in particolare quella tendenza, esplicitamente ammirata, con cui potenzialmente stabilire più di un’alleanza nel “progetto di decostruzione del marxismo”, che corrisponde al dellavolpismo. Tuttavia si rivelerà un incontro disturbato. La periodizzazione della cesura tra il Marx “ideologo” e “scienziato”, la mancata comprensione della funzione del materialismo dialettico nella lotta ideologica e infine la posizione althusseriana che intravedeva in Marx un cambio di problematica piuttosto che il “rovesciamento” della dialettica hegeliana, rappresentarono le issues che divisero i percorsi. Allo stesso tempo sarà Cesare Luporini, su cui l’influenza althusseriana sarà evidente nella successiva svolta antistoricistica, a farsi carico d’introdurre Althusser in Italia. Con non poche difficoltà ed equivoci. Si pensi all’introduzione alla prima edizione del Pour Marx, edito dalla casa editrice del Pci (anteponendo al libro una nota editoriale), o al saggio Realtà e storicità, che pur simpatizzando con alcune soluzioni presenti nell’opera collettiva Leggere il Capitale, sono riprese senza abbandonare la nozione hegeliana dell’Aufhebung. Per Lo Iacono si tratta di una ricezione anticipata che non gioverà all’interpretazione successiva. E ciò è ancora più vero se si pensa alla problematica traduzione di Lire le Capital: pubblicato solo nel 1968 in forma ridotta, con una nota dell’autore all’edizione italiana in cui si avviava il processo di “autocritica” e che, di fatto, rispondeva in chiave subalterna alla ricezione storicista delle tesi althusseriane, già parzialmente anticipate, lasciando più di un non-detto nell’accusa generalizzata di storicismo che affettava, ad un tempo, Gramsci e la scuola di Della Volpe. Su questo aspetto, per quanto parziale sia la lettura althusseriana, (ri)leggere Gramsci dopo Althusser – come ha già scritto Vittorio Morfino – è tutt’altro che improduttivo. Lo stesso concetto di ideologia (e il possibile connubio con l’approccio gramsciano) venne del tutto trascurato nei suoi “aspetti più originali” e, potremmo aggiungere, solo attualmente si è tornati a riflettervi efficacemente (come fa ad esempio Fabio Raimondi nel recente Il custode del vuoto. Contingenza e ideologia nel materialismo radicale di Louis Althusser). I testi del periodo “autocritico” – recepiti e usati in gran parte dalla critica per rimarcare il carattere contraddittorio dell’althusserismo e ridimensionarne la portata – sfociano negli interventi diretti sulla “crisi del marxismo” – le dernier combat, dirà Andrea Cavazzini in un suo recente lavoro – sino a giungere al (quasi) oblio, almeno in Italia, negli anni ’80 e alla riscoperta post mortem. Il saggio di Lo Iacono si conclude con l’indicazione di alcuni orientamenti della critica. Alla scontata ricezione prevalente in ambito marxista, si affiancano alcune correnti – da sondare in itinere – particolarmente sensibili ai temi althusseriani quali: «la reazione del marxismo fenomenologico», la ricezione di un’area eterogenea come il «marxismo epistemologico italiano», la critica di orientamento cattolico, l’incontro con l’operaismo e il post-operaismo e infine il «nuovo ciclo della ricezione» in cui l’Associazione “Louis Althusser” ha interpretato un ruolo di primo piano nel mostrare «un Althusser sconosciuto» e la continuità di alcune sue “istanze” di fondo come la «logica della contingenza», la «filosofia dell’opacità», il «materialismo». Istanze che – concordiamo con Lo Iacono – «non paiono sopite».
(Pubblicato in Critica Marxista, n. 1, gennaio-febbraio 2012)