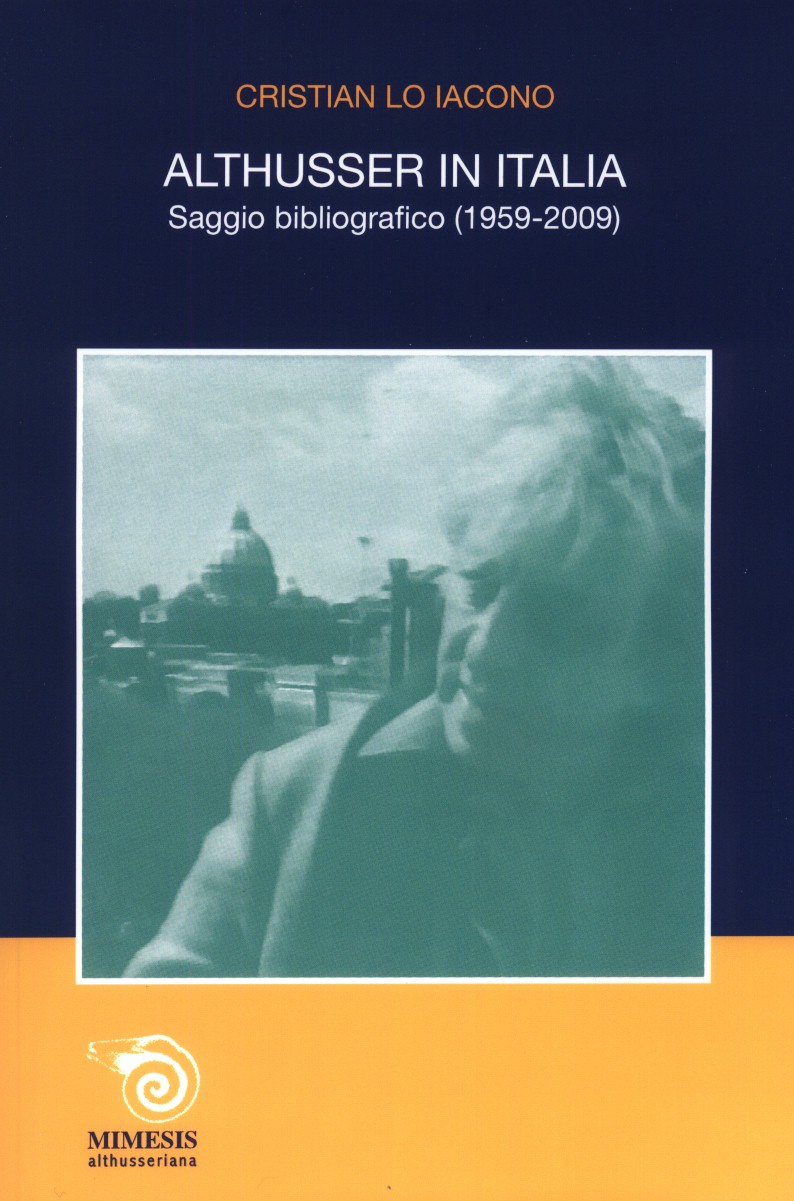
Althusser in Italia. Saggio bibliografico (1959-2009)
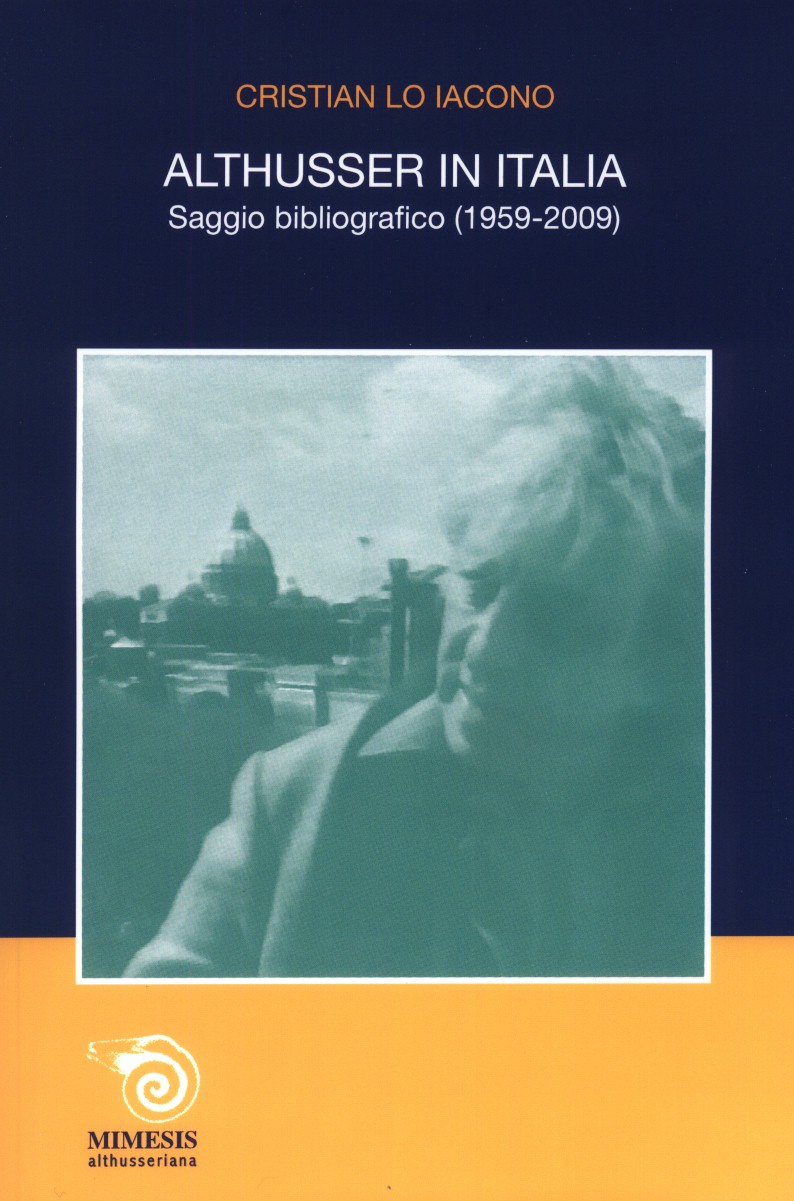 |
Cristian Lo Iacono Althusser in Italia. Saggio bibliografico (1959-2009) |
Recensione a: Cristian Lo Iacono, Althusser in Italia. Saggio bibliografico (1959-2009)
di Andrea Cavazzini
Il libro di Cristian Lo Iacono è certo qualcosa di più di quanto il suo titolo suggerisce. L’accurato lavoro bibliografico, infatti, sostiene una ricostruzione globale del rapporto tra uno dei più importanti filosofi marxisti del ‘900, Louis Althusser appunto, e l’Italia – un rapporto che è stato non solo di ricezione degli scritti althusseriani nel dibattito filosofico e politico italiano, ma anche, e per certi versi soprattutto, di attenzione e interesse da parte di Althusser nei confronti della cultura filosofica marxista nostrana. Che questo rapporto meritasse una ricostruzione completa è reso evidente, non solo dal dato delle passioni e delle speranze che Althusser ha investito rispetto all’Italia, ma anche da un altro fatto forse non immediatamente evidente per chi non conosca la situazione (o la “congiuntura”) dai due lati delle Alpi: dopo le vicende tragiche che hanno coinvolto Althusser nel 1980, e dopo la contemporanea crisi delle prospettive comuniste e del dibattuto marxista, è in Italia che il filosofo francese ha maggiormente continuato ad essere considerato come un autore importante, capace di ispirare iniziative culturali di lungo respiro e portatore di posizioni filosofiche originali e suscettibili di sviluppo ed elaborazione. In Francia, Althusser è invece un autore scomparso dal dibattito filosofico: qualche, rarissima, monografia universitaria, poche riedizioni (in genere di testi dedicati ad autori “classici” quali Machiavelli e Spinoza), e molte operazioni scandalistiche coperte dalla foglia di fico della “riscoperta del vissuto biografico”. Niente di comparabile all’esistenza, in Italia, di una collana di libri dedicata ad Althusser (“Althusseriana”, appunto), che ne ripubblica sistematicamente le opere maggiori, o ai convegni internazionali costruiti attorno alle attività della suddetta collana, o ancora alla collana “Epistemologia”, gemella della precedente, dedicata alla filosofia e alla storia delle scienze secondo un orientamento che Althusser rivendicava in particolare all’inizio della sua carriera; e naturalmente all’attenzione per il filosofo francese da parte delle correnti post-operaiste. Non si dimenticherà, inoltre, il ruolo giocato dal pensiero di Althusser nelle attività del Centro Studi sul Materialismo Storico nel corso degli anni ’80. Una presenza italiana importante dunque, ma quasi interamente successiva alla scomparsa di Althusser dalla scena pubblica, laddove in Francia, l’eclissi degli anni ’80 seguiva due decenni di prestigio e autorità incondizionati di cui godeva l’autore di Pour Marx – non ritengo esagerato dire che la lettura di Marx tentata da Althusser, la quale cercava di sottrarre il marxismo alla sua matrice idealista-hegeliana, è l’operazione che ha cristallizzato l’unità relativa di un “campo” filosofico francese alcuni esponenti del quale (Foucault, Deleuze…) contano oggi tra le icone del radicalismo filosofico-politico.
Questo scarto temporale può senza dubbio contribuire a far sì che le riappropriazioni di Althusser tendano a decontestualizzarne l’opera, a sottrarla alla congiuntura storica che è stata la sua, e i cui punti di riferimento – l’autorità del pensiero marxista, l’esistenza di un movimento comunista mondiale – sono oggi inesistenti e opachi per la maggior parte dei lettori. Merito non lieve del libro di C. Lo Iacono è di ricostruire questa congiuntura attraverso il prisma delle letture (e delle non-letture) di cui Althusser è stato l’oggetto, e, fino almeno al 1980, un partecipante attivo.
Louis Althusser non parlava per tutti, né a tutti: i suoi interlocutori erano i militanti del movimento comunista, del quale il suo lavoro filosofico intendeva riformare le istanze intervenendo sul loro “fondamento” teorico. E, correlativamente, i lettori di Althusser non cercavano né una filosofia più intelligente delle altre, né un nuovo sistema ontologico, né tantomeno una chiave ermeneutica per leggere i filosofi del Rinascimento e dell’Età Classica, ma cercavano nei suoi (pochi e brevi) scritti le chiavi di un superamento delle impasse teoriche e pratiche della politica comunista dopo la destalinizzazione. Qui sta tutta la specificità di Althusser, ciò che rende difficile leggerlo oggi. Ma anche là dove bisogna leggerlo e interrogarlo oggi: se si vuole farne un uso realmente vitale, occorrerà imparare a confrontarsi con gli aspetti suoi che sono i più apparentemente morti. Lo Iacono tenta questa operazione, alla fine del suo saggio introduttivo, e ci ritorneremo. Innanzitutto, però, merita una riflessione la storia dei rapporti tra Althusser e il marxismo italiano che Lo Iacono ricostruisce, e che è una storia di non-rapporti, di effetti impossibili, di letture devianti o sterili. Una cosa è certa: Althusser non ha giocato un ruolo nel dibattito marxista italiano, che fu estremamente ricco e vivace negli anni ’60. Contrariamente a quanto suggerirebbero i ricorrenti complessi di inferiorità culturali italici – per cui il nostro “provincialismo” ci impedirebbe ripetutamente di attingere alle fonti della cultura internazionale – furono i limiti (innanzitutto politici) di Althusser a impedire un’inscrizione più profonda nel fermento della cultura di sinistra dell’epoca. È un fatto, ben documentato da Lo Iacono, che Althusser cerchi i suoi interlocutori italiani tra i filosofi membri del PCI – in particolare Galvano Della Volpe e Cesare Luporini – che più gli sembrano opporsi alla pervasiva ideologia storicistico-umanista oggetto delle sue stesse critiche. Ma le vere novità nella cultura della sinistra marxista avevano avuto luogo, dagli anni ’50, all’esterno, e contro, la politica del Partito Comunista. Le analisi del “neo-capitalismo” del dopoguerra si ispirano alla Scuola di Francoforte o a Lukács, introdotti in Italia dagli animatori di riviste dissidenti (ad esempio “Ragionamenti”), e saranno poi i “Quaderni Rossi” a articolare questa ispirazione ad un lavoro massiccio di inchieste operaie e ad analisi economico-sociologiche più precise. I riferimenti culturali rispettivi rendevano certo difficile l’ipotesi di un contatto tra Althusser e questi ambienti. Ma il problema era più profondo. Althusser voleva restare nell’ambito dei contatti “autorizzati” dai rapporti tra i differenti partiti comunisti occidentali, e rifuggire ogni tentazione minoritaria o scissionista (eccettuate le fronde filo-cinesi che incoraggerà presso i suoi allievi, ma appunto la Cina maoista non era un’eresia minoritaria, bensì un concorrente dell’URSS alla guida del movimento comunista): non avrebbe quindi potuto ammettere una rilettura di Marx – quale quella condotta dai “Quaderni Rossi” e poi dall’operaismo – solidale di un processo politico alternativo alla “legittimità” dei partiti di obbedienza sovietica. Ora, in Italia, il rinnovamento della cultura marxista era inscindibile da un tale processo, legato alla dissidenza più o meno organizzata di gruppi di intellettuali e alla ripresa delle lotte operaie al di là della strategia togliattiana della “via italiana al socialismo”. Resta che un tentativo di rilettura di Marx quale quello intrapreso dai “Quaderni Rossi” avrebbe potuto, dal punto di vista concettuale, interagire con la rilettura althusseriana – tanto più che i fondatori rispettivi dei “Quaderni” e dell’operaismo, Raniero Panieri e Mario Tronti, vicini teoricamente a Della Volpe, non risparmiavano critiche all’umanesimo marxista e allo storicismo hegelianeggiante che erano i bersagli pure di Althusser. Purtroppo, Lo Iacono dedica solo una pagina alla vicenda “Quaderni Rossi”-operaismo, viziata inoltre da considerevoli imprecisioni e da un’incomprensione generale dell’importanza di quelle correnti.
Vi è un altro dato. Althusser cercava manifestamente – è quanto emerge dal lavoro di Lo Iacono – degli equivalenti italiani della sua operazione: una rilettura di Marx a base non politica, ma scientifica, che non contestasse direttamente la legittimità del partito ma ricostruisse le categorie teoriche su cui esso fondava la sua autorità. Purtroppo, questa tattica non teneva conto della differenza delle congiunture italiana e francese. Il Partito francese imponeva un’ortodossia dottrinale che poteva quindi essere contestata con un’operazione puramente teorica, la quale avrebbe avuto degli effetti politici indiretti. Il PCI, negli anni ’60, aveva ormai istituzionalizzato la separazione tra elaborazione teorica e legittimità politica: agli intellettuali era lasciata una certa libertà di ricerca, purché restasse intatto il primato della direzione del partito nel decidere la linea politica. Inoltre, Althusser sembrava credere che Luporini o Della Volpe, entrambi universitari, potessero rappresentare delle posizioni equivalenti a quella che lui occupava in Francia – militante del partito e filosofo universitario (più precisamente, dell’Ecole Normale Supérieure). Ma in Italia l’Università e in genere le istituzioni intellettuali “di Stato” non hanno mai avuto l’autonomia e il potere che le caratterizzava in Francia. Un filosofo dell’Ecole Normale – che incarna in quanto tale il Sapere – può lottare “nella teoria” contro un partito che si vuole suprema istanza teorica; ma un professore universitario italiano può ben poco contro un partito che pretende soprattutto un primato nella strategia politica. Credo che siano queste le ragioni per le quali non vi fu, in Italia, alcun “effetto Althusser”: le posizioni del filosofo francese furono viste come omogenee al dibattito, assolutamente sterile, sull’oggettività (o meno) della contraddizione, e ascritte ad una scolastica neo-ortodossa (il lavoro di Luporini e della scuola dellavolpiana merita certo anch’esso un giudizio meno liquidatorio). Il lungo ciclo delle lotte operaie e studentesche, e la costituzione della Nuova Sinistra, non troveranno alcun uso positivo per le tesi di Althusser, che per molto tempo, allineato benché con incertezze e contraddizioni sulle posizioni del PCF a proposito del Maggio 1968, non sembrerà comprendere la portata degli avvenimenti (Lo Iacono registra le oscillazioni a questo proposito). A partire dal 1969, come documenta Lo Iacono, la pubblicazione di un testo estremamente contestualizzato come Lénine et la philosophie farà di Althusser una “testa di turco” frequente sulle pubblicazioni vicine all’area extraparlamentare. Soprattutto il lato “epistemologico” dell’impresa althusseriana sarà brutalmente e riduttivamente criticato, dopo aver costituito il terreno d’incontro con Luporini e della Volpe, e la stessa autocritica di Althusser rivolta al proprio “teoricismo” contribuirà a cristallizzare l’immagine di un iperrazionalista dogmatico buono per esercizi scolastici. Un’altra parte importante del lavoro di Althusser negli anni ’60, il rapporto con la psicanalisi, non sarà in genere nemmeno percepita – con pesanti effetti di ricezione, poiché quel rapporto ispirerà un’importante corrente maoista in Francia.
Althusser ritorna nel dibattito italiano alla fine degli anni ’70, ormai in rottura con il PCF e disposto a dichiarare aperta la “crisi del marxismo”. In particolare, Althusser partecipò al convegno organizzato dal Manifesto a Venezia nel 1977 su Potere e opposizione nelle società post-rivoluzionarie, che riuniva dissidenti di sinistra dei paesi dell’Est, esponenti della Nuova Sinistra (tra cui Franco Fortini) e dei partiti comunisti “legittimi”, e dei maoisti anti-sovietici quali Charles Bettelheim e un ex-allievo di Althusser, Robert Linhart, fondatore della corrente maoista francese. Nello stesso periodo, Althusser invita Toni Negri all’ENS, per tenere delle lezioni sui Grundrisse da cui sarà tratto il celebre Marx oltre Marx. La fase finale dell’azione pubblica di Althusser è assai poco studiata, e affidata a materiali frammentari[1]: merito grande di Lo Iacono è di ricostruirla nella sua problematica coerente e di mostrarne i legami con gli ultimi testi sul “materialismo aleatorio”. In ogni caso, pare certo che Althusser si avvicini alle posizioni delle sinistre antagoniste ai partiti comunisti tradizionali, giungendo anche a fare l’apologia dell’effervescenza dei movimenti di massa italiani – che nello stesso periodo il PCI si apprestava a reprimere. L’ultimo Althusser, afferma Lo Iacono, sembra sviluppare “l’idea di un comunismo come movimento storico non più legato alle grandi organizzazioni politiche di massa” (p. 64); avanza l’idea di “isole di comunismo” già esistenti “in tutte quelle nicchie sociali entro le quali hanno luogo relazioni non mercantili, prive di dominazione politica e di assoggettamento ideologico”. In un dibattito pubblico del 1980, che Lo Iacono ricostruisce da scarsi indizi e testimonianze, un Althusser disperato e al limite del delirio – la crisi psichica definitiva e il troppo noto uxoricidio sono di poco posteriori – si proclama semplice cassa di risonanza del pensiero dei movimenti di massa che agiscono ormai su di una “scena” politica eterogenea a quella dello Stato e della rappresentanza partitica. Il comunismo è ovunque si diano rapporti liberati, esso esiste come “anarchia sociale”, e si tratta solo di riconoscerne la presenza “interstiziale” nelle “crepe” della società. Lo Iacono suggerisce un’influenza esercitata su Althusser da esperienze quali la teologia della liberazione, il movimento femminista, e soprattutto il ’77 italiano – una pista di ricerca che merita senz’altro di essere ulteriormente esplorata. Inoltre, le aporie di queste ultime posizioni sono messe in evidenza: Althusser parla senza distinguere di movimenti di massa e di lotte di classe, due concetti che non si sovrappongono; e resta poco chiaro come queste “isole di comunismo” possano esistere parallelamente ai rapporti capitalistici senza esserne assorbite e senza però destrutturarli e modificarli. In generale, il problema della durata dei rapporti comunistici resta irrisolto, forse al di là di quello che Althusser poteva pensare alla fine del suo percorso, contemporanea della fine dell’esperienza comunista. Ma appunto è qui che il discorso va ripreso, chiedendosi a cosa fa allusione quest’ultimo intervento althusseriano, a che futuri sviluppi possibili rimandano le sue enunciazioni paradossali. Secondo Lo Iacono, una morale da trarre esiste: “La crisi del marxismo degli anni Settanta e Ottanta non ha soltanto come origine la riorganizzazione dello Stato e del mercato, ma l’incapacità della teoria sociale marxista di offrire valide basi di comprensione dell’insorgenza dei nuovi movimenti sociali (…). In Italia la questione si pose in termini di incapacità – teorica e politica – del marxismo di confrontarsi con i cosiddetti nuovi soggetti, in primo luogo il movimento delle donne, e poi con i movimenti pacifisti ed ecologisti” (p. 68). Conclusione fuorviante, e deludente rispetto al percorso laboriosamente ricostruito: l’ultimo Althusser anticiperebbe la scena politica postmoderna nei suoi tratti più scontati? Credo che sia un errore attribuire alle folgorazioni di Althusser nel 1980 un rinvio a fenomeni politici reali: quegli enunciati frammentari e convulsi disegnano piuttosto un’immagine sublimata del comunismo come liberazione, al di là di ogni specificazione storico-sociale, per riaffermarne un’ultima volta le ragioni oltrepassandone la catastrofe storica. Il comunismo appare come un fenomeno originario, antropologico e cosmologico, un gigantesco fantasma destinato a sostenere il valore di un impegno politico, e la validità di un pensiero che ha voluto intervenire nella storia ma che la storia sembrava ormai smentire e negare radicalmente. Enunciati simili si trovano nell’ultima intervista di Sartre, anch’essa del 1980. Non credo si renda giustizia alla volontà di Althusser di pensare fino in fondo il comunismo oltre il comunismo suggerendo che questo sforzo estremo e disperato potrebbe alludere ad una miscela di femminismo ed ecopacifismo – ricetta ben poco nuova, e di cui dalla fine degli anni ’70 non facciamo che misurare le insufficienze e l’impotenza. Quanto alla crisi del marxismo, è precisamente l’incapacità di pensare la trasformazione dello Stato e soprattutto dei rapporti di produzione ad averla prodotta, laddove i “nuovi soggetti” emersi da questa crisi hanno spesso rappresentato un risvolto parassitario della rinuncia a trasformare la società nei suoi caratteri strutturali. La congiuntura attuale mostra assai bene che è l’assenza di uno sguardo d’insieme sullo Stato e sul Capitale – quale il marxismo forniva – a rendere fragili e precarie le effervescenze numerose delle società devastate dal capitalismo contemporaneo.
È forse da qui che il ragionamento su Althusser dovrebbe essere ripreso. Questo libro ce ne offre l’occasione, quali che siano le ragioni di dissentire dalle sue conclusioni, e speriamo che sia seguito da altri tentativi analoghi di ritornare su un’epoca di cui scontiamo ancora la rimozione.
[1] Se ne può trovare un commento sul sito del Groupe de Recherches Matérialistes
, (http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_1_annee_Cavazzini_Althusser.pdf)