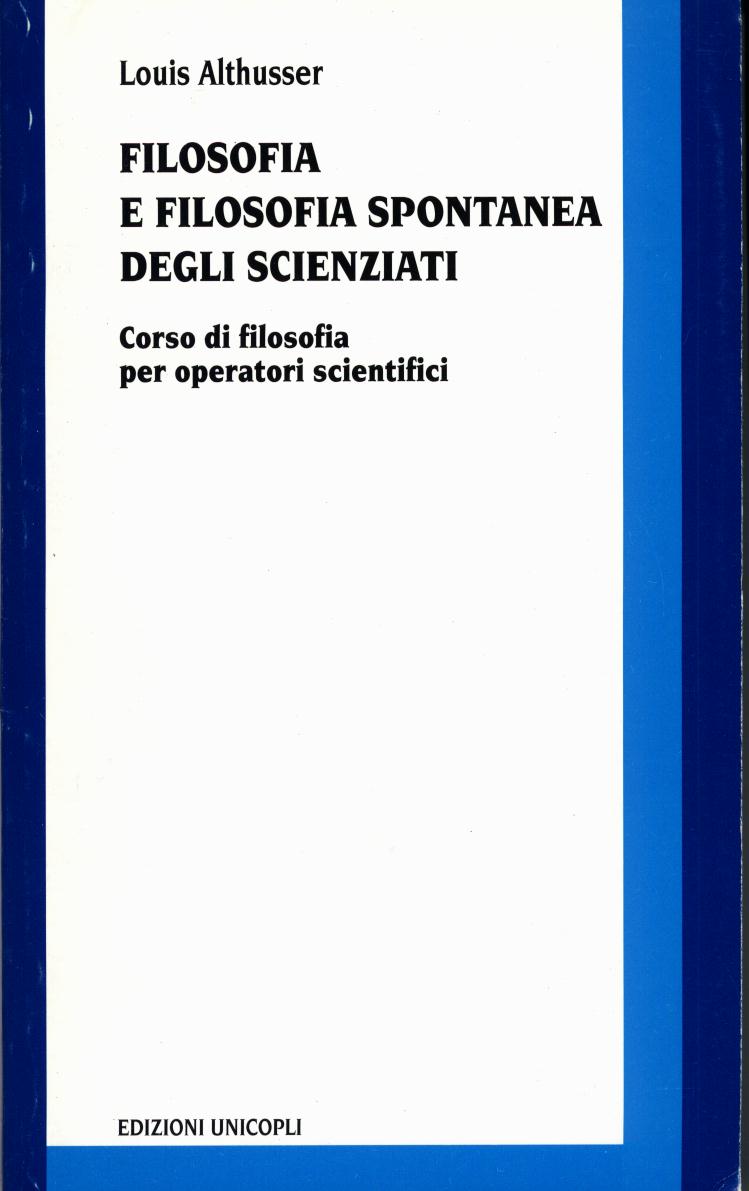
Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati
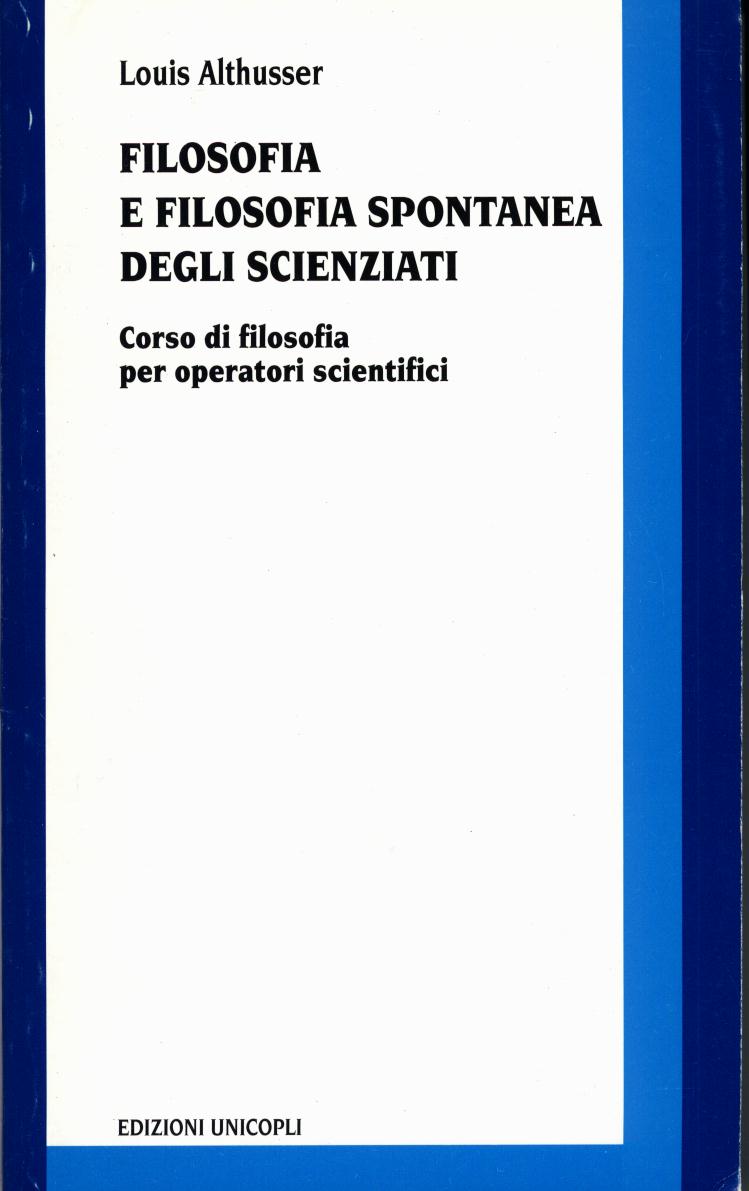 |
L. Althusser Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati |
Recensione
di Augusto Illuminati
Niente di male che la diffusione della filosofia segua le mode. Peccato
che, mentre le mode (vestiti, acconciature, canzoni) si costruiscono a loro
modo una storia rivisitando periodicamente per decenni le esperienze passate
(i roaring '30, i faboulous '60 e da ultimo i '70), i divulgatori
filosofici trascurino i successi passati e corrano sempre ciecamente dietro
all'ultimo libro. Ben vengano dunque riprese di riflessione su autori che
hanno occupato il proscenio negli anni '70 e '80 e poi sono andati incontro
a un'eclissi immotivata quanto la fortuna dei loro successori. Già
questo giornale è ritornato, in occasioni di recenti pubblicazioni,
sul significato e il peso dell'opera di Michel Foucault, e vorremmo ora
segnalare altri due filoni del pensiero francese, molto diversi ma in epoche
separate del pari e fugacemente egemonici sulla cultura italiana.
Maria Turchetto (turchetto@interfree.it) ha fondato un'associazione Louis
Althusser e avviato, in collaborazione con le edizioni Unicopli, una collana
di libri di e su questo autore, che si apre con Filosofia e filosofia
spontanea degli scienziati -Corso di filosofia per operatori scientifici
(Milano 2000, pagg. 187, lire 25.000). Si tratta di cinque lezioni (l'ultima
finora inedita in Italia) tenute nel 1967-1968 presso l'École Normale
Supérieure e accompagnate dal testo di Jacques Monod cui fa riferimento
la quarta. In esse si sviluppa l'idea che esista una filosofia spontanea
degli scienziati, caratterizzata da due elementi: 1) un elemento di origine
intrascientifica, cioè una convinzione materialista emergente dalla
pratica immediata e consistente nella credenza dell'esistenza reale dell'oggetto
e dell'oggettività della conoscenza ad esso relativa nonché
nella giustezza delle procedure investigative; 2) un elemento extrascientifico,
esterno alla pratica e sostanzialmente idealista, che sostituisce in linea
di tendenza l'esperienza all'oggetto, il modello alla teoria, le tecniche
di validazione al metodo scientifico. Questo secondo elemento tende a prevalere,
anche negli scienziati più onesti, conferendo una tonalità
idealista a tutta la scienza. Esempi, l'empiriocriticismo classico di Ernst
Mach e più recentemente la riflessione di Monod, mentre la proposta
operativa consiste nell'intervento dall'esterno di una filosofia che rispetti
e sostenga la causa dell'elemento 1, rafforzando la buona causa materialista
contro i ripensamenti dovuti alla pressione dell'ambiente circostante, delle
idee (spiritualiste) della classi dominanti, la cui tipica forma è
l'accoppiata di empirismo e umanesimo. Del resto la filosofia nasce e si
modifica soltanto in relazione all'esistenza e ai cambiamenti delle scienze
in senso stretto (non semplici pratiche tecniche), ma pretende di farsi
"filosofia della scienza" e di fabbricare una "teoria della
conoscenza", esibendo così il suo lato ideologico. La critica
del meccanismo base idealista -l'invarianza della formula (Soggetto=Oggetto)=Verità
nelle due varianti empirista e formalista- si accompagna alla consapevolezza
(spinoziana!) della non eliminabilità, ma della semplice riconoscibilità
e controllabilità dell'elemento ideologico, dato che i processi di
produzione delle conoscenze sono surdeterminati da un contesto sociale conflittuale.
Il filosofo materialista saprà agire l'ideologia senza esserne agito,
sfruttarla per veleggiare controvento, secondo la splendida metafora per
cui la verità non è disvelamento, ma velo (Heidegger!) nel
duplice senso di velamento e vela.
(pubblicata su Il Manifesto del 9/7/2000)