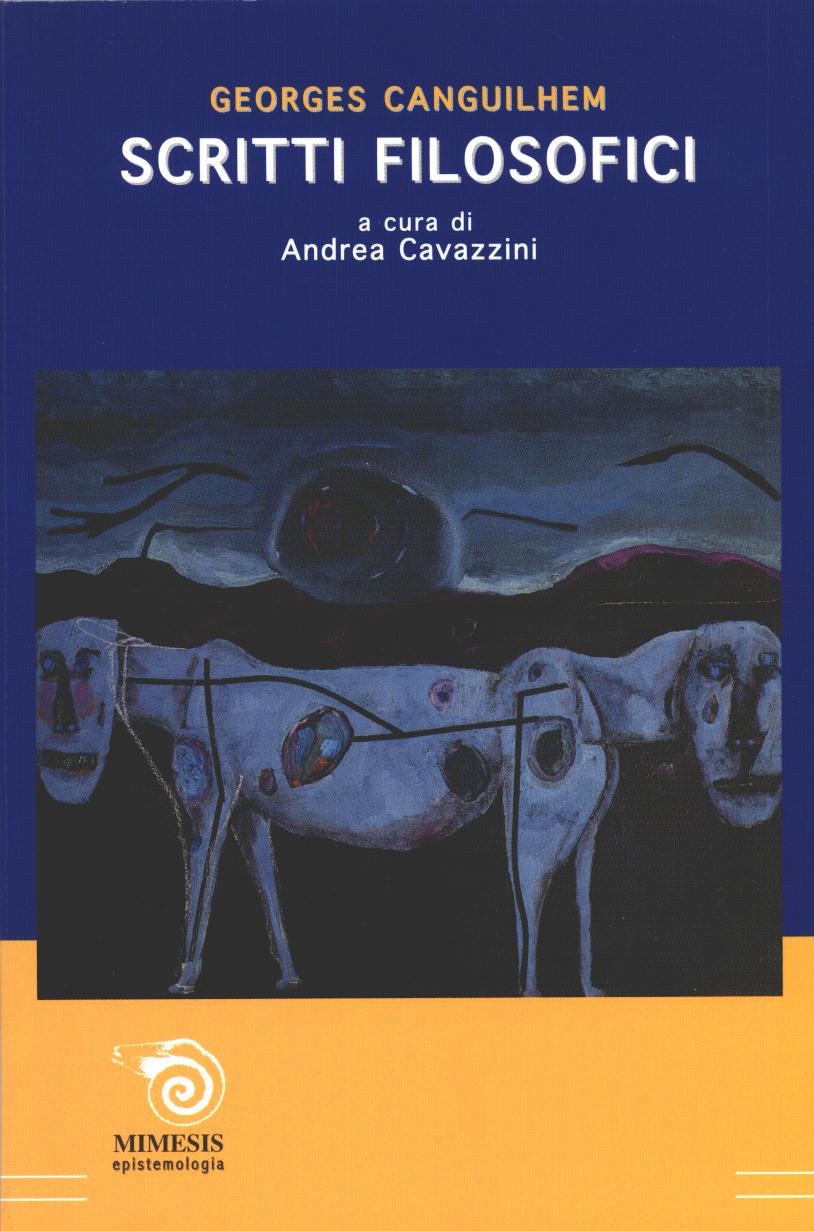
Scritti filosofici
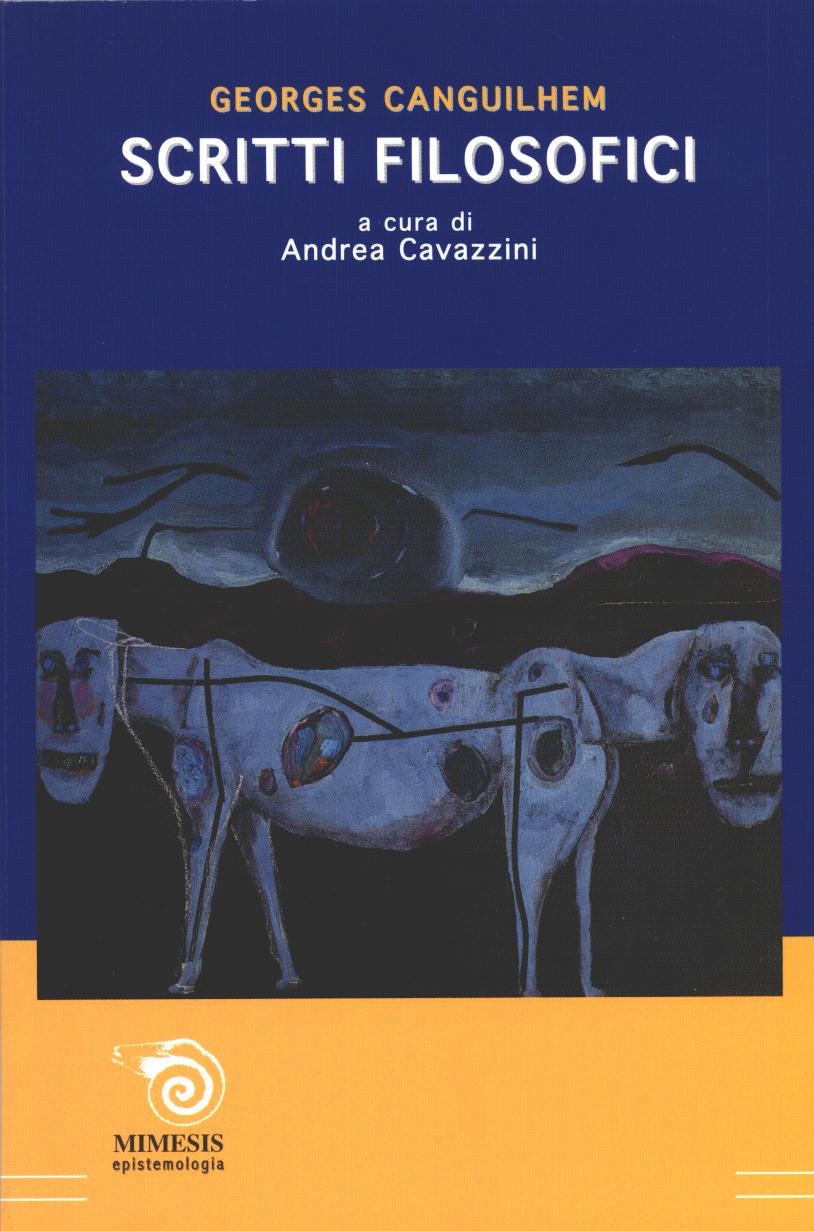 |
Georges Canguilhem Scritti filosofici |
Georges Canguilhem, Scritti filosofici (a cura
di A. Cavazzini), Mimesis, Milano 2004
Canguilhem: la critica epistemologica come filosofia della
resistenza
di Michele Cammelli
Difficile non ammettere che siamo disorientati dinanzi al potere che
oggi la scienza ha nelle mani per conoscere e modificare l'essere vivente.
A volte, nel nostro immaginario comune, il confine con la fantascienza tende
a scomparire e si profila lo scenario da incubo di un mondo che potrebbe
assomigliare sempre più ad un gigantesco allevamento dove la vita,
compresa quella umana, diventa semplice modo di produzione sottoposto alle
norme dettate dalla genetica. Se la scienza è il nuovo "pastore",
vien da pensare, sarà la luce fredda del laboratorio a prendere il
posto del prato assolato dove un tempo il "gregge" della vita
pascolava in libertà. E, forse, non è per caso che il primo
animale clonato in laboratorio sia stato proprio quello che nella nostra
cultura occidentale rappresenta da sempre l'esempio stesso dell'animale
che obbedisce al potere: la pecora, chiamata scherzosamente "Dolly"
che, in inglese, significa "bambola". Se l'intenzione era quella
di segnalare l'entrata in scena di un nuovo "potere pastorale"
che si pone alla guida del DNA (per la guida delle anime la lotta fra i
"pastori" è ancora aperta), era difficile giocare uno scherzo
migliore di questo primo scherzo d'allevamento. Come Edgar Allan Poe fa
vedere in molti dei suoi racconti, il potere si manifesta spesso in un modo
duplice: terrificante e grottesco insieme. E qui lo fa con un primo inquietante
battesimo: "Dolly"...
Il filosofo e storico della medicina e della biologia francese Georges Canguilhem,
invitato nel '74 ad una conferenza mondiale sul tema <<Biologia e
divenire dell'uomo>>, ci dà un'idea limpida delle domande che
possiamo e dobbiamo porre ad una forma di potere che si nasconde dietro
alla maschera più insidiosa: l'evidenza oggettiva. Davanti ad una
platea composta da quelli che erano allora i più noti esperti di
biologia e di medicina, egli conclude il proprio intervento domandando:
<<biologi e medici ritengono di essere a loro modo, uomini di potere?
Riconoscendo i propri poteri, vogliono esercitarli? Con quali altri poteri
vogliono cooperare?>>.
Provocata da queste domande, la scienza diventa un problema che è
anche ed inevitabilmente di natura politica. Non si tratta di esaltarla
o condannarla. Si tratta, invece, impresa ben più difficile, di cercare
di riconoscere in modo puntuale le nuove forme di sapere e di potere che,
di volta in volta, vanno insieme alle modalità storiche della sua
affermazione.
Canguilhem (1904-1995) ha intrapreso questo cammino critico interrogandosi
sulla storia e l'epistemologia delle scienze della vita e della medicina,
terreno dove, come sapeva bene Foucault (uno dei suoi allievi più
noti), la relazione fra politica e scienza è particolarmente delicata.
Ma quest'opera, tutta composta di saggi puntuali il più delle volte
relativamente brevi, è ancora in gran parte da scoprire in Italia.
Arriva, perciò, come una felice notizia e come un buon auspicio per
il futuro la recentissima uscita presso la casa editrice Mimesis di questa
agile raccolta di saggi di Canguilhem curata e tradotta da Andrea Cavazzini
e pubblicata con il titolo di Scritti filosofici. Il contesto editoriale
che l'accoglie è quello più adatto: la collana "Epistemologia",
appena inaugurata dalla Mimesis sotto la direzione di Maria Turchetto con
l'esplicito intento di portare in Italia ciò che resta sconosciuto
o che sarebbe da riscoprire di quella grande tradizione francese di storia
della scienza e di epistemologia che va da Bachelard a Koyré a Canguilhem.
Con precisione da "archeologo del sapere", Foucault ha più
volte paragonato il ruolo teorico e l'importanza politica di questa tradizione
filosofica francese a quello della Scuola di Francoforte: è principalmente
attraverso la critica epistemologica che in Francia, già a partire
da Comte, ricorda Foucault, ci si è posti il problema della storia
della razionalità occidentale come problema politico. Un esempio
illuminante lo troviamo proprio nel primo lungo saggio che Canguilhem
pubblica nel '43, mentre la Francia è occupata dai nazisti ed egli
si trova impegnato nella resistenza: Il normale e il patologico.
Il saggio mostra che i concetti di "media" e di "normalità"
elaborati dalla medicina positivista del XIX secolo non sono in grado di
cogliere la dinamica essenzialmente discontinua e soggettiva del vivente;
si tratta, ancor oggi, di una delle critiche epistemologiche più
lucide nei confronti del sogno medico-scientifico di normalizzare la salute
e di una meditazione originale sul possibile significato positivo della
malattia nel momento in cui venga pensata come prova singolare che mette
il soggetto vivente davanti al compito di creare se stesso nuovamente e
non come semplice venir meno di una astratta "condizione media"
di salute. Ma perderemmo la ragion d'essere polemica e militante di questo
saggio se non vi leggessimo anche, fra le righe, la radicale e consapevole
critica che l'autore sta muovendo al nazismo. Il regime al quale Canguilhem
resiste come partigiano e, dobbiamo dire a questo punto, anche come epistemologo,
mira, infatti, ad estendere il più possibile il controllo politico
sui corpi, sulle malattie e sui processi biologici della riproduzione, proprio
elevando a fine politico un valore che ha significato solo come "valore
medio": la "salute della popolazione" (ed è appunto
per questo che l'implicazione della medicina e della biologia positiviste
nella macchina di potere nazista resta, ancor oggi, una delle pagine più
oscure ed inquietanti di quell'esperienza: "esperienza" per alcuni...
"esperimento", forse, per altri).
Nella raccolta appena pubblicata il lettore troverà tre saggi, fino
ad oggi inediti in Italia, dove Canguilhem elabora in modi diversi una critica
degli oggetti scientifici. Il problema di Canguilhem è mostrare in
che modo il discorso e la pratica della scienza arrivano a farci vedere
un certo oggetto. Gli oggetti scientifici non sono qualcosa che preesiste
all'attività della scienza: sono qualcosa che si afferma e diventa
visibile solo attraverso di essa. Il primo saggio, Su la scienza e la
contro-scienza, mostra che una verità scientifica si afferma
sempre escludendo una credenza precedente che ora viene considerata illusoria
sulla base del modo di ragionare della scienza attuale. Viene da qui la
funzione filosofica della storia delle scienze: essa, come dice l'ultimo
saggio su L'oggetto della storia delle scienze, ha il compito
di riportare alla luce i passaggi epocali e le rotture epistemologiche che
hanno reso possibile l'emergenza di un nuovo "modo di dire il vero".
Facendo vedere i limiti della verità attuale, lo storico delle scienze
fa anche vedere che l'orizzonte in cui questa verità trova il proprio
senso non è l'unico possibile.
Come fa ben notare Andrea Cavazzini nella sua introduzione agli Scritti
filosofici, Canguilhem è un filosofo della "riserva",
della riserva di ciò che può essere rispetto a ciò
che è. Per questo, nel saggio centrale su Il cervello e il pensiero,
egli critica duramente l'idea condivisa dalle neuroscienze attuali secondo
cui le attività del pensiero e della volontà si ridurrebbero
a semplici procedure di calcolo predeterminate nel cervello: se il pensiero
fosse come un calcolatore già programmato non potrebbe esistere per
l'uomo la possibilità di aprirsi a nuove esperienze di conoscenza.
La vita stessa è, per Canguilhem, possibilità d'errare. Eliminare
questa possibilità vorrebbe dire, in definitiva, distruggere la vita
stessa.