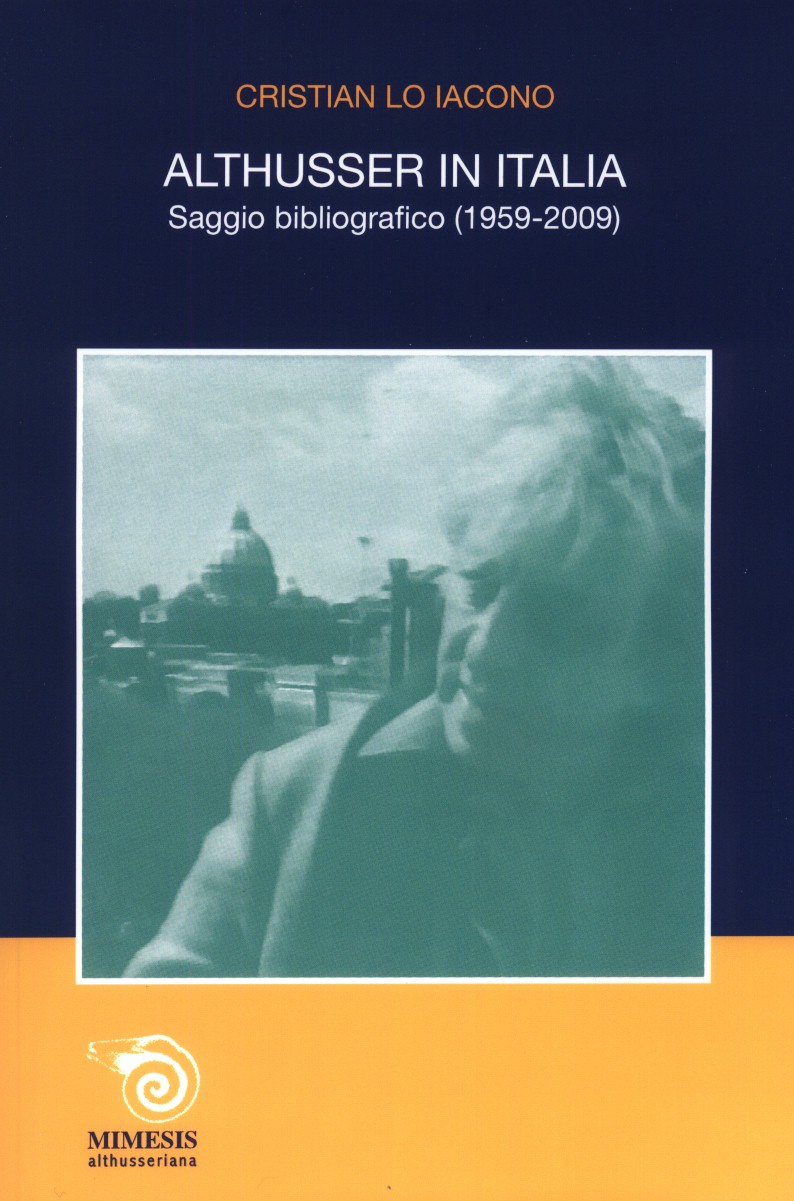
Althusser in Italia. Saggio bibliografico (1959-2009)
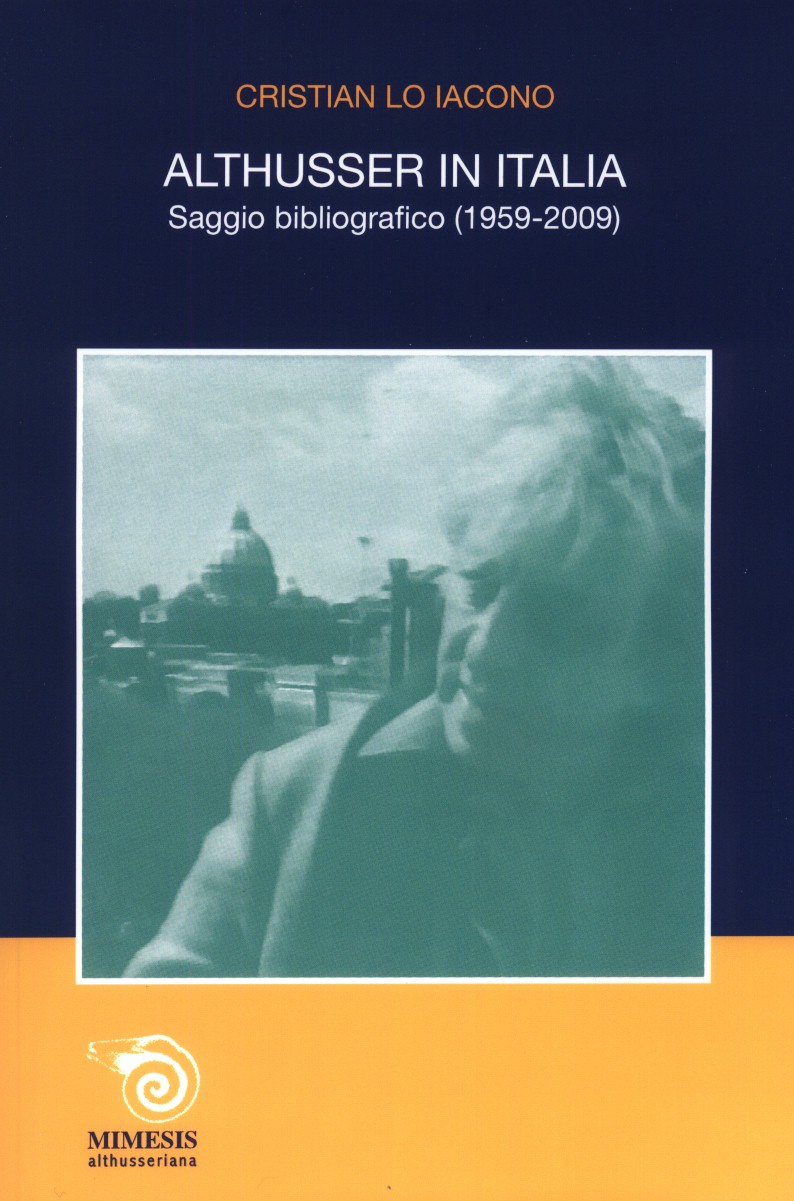 |
Cristian Lo Iacono Althusser in Italia. Saggio bibliografico (1959-2009) |
Prefazione
di Maria Turchetto
Presentare questo lavoro di Cristian Lo Iacono mi dà l’occasione di dire due parole anche a proposito della collana Althusseriana che lo accoglie, e che è stata pensata e diretta secondo scelte molto diverse rispetto a quelle che caratterizzano per lo più l’“accademia” – soprattutto italiana.
In campo filosofico, l’accademia italiana, presa com’è (con rarissime eccezioni) nella tradizione di una storia della filosofia per autori piuttosto che per problemi, privilegia da sempre la monografia su un autore, genere quasi obbligato dai concorsi universitari. Col risultato di alimentare a dismisura la letteratura “secondaria”, a scapito della “primaria” (esiste in Italia il paradosso di autori ormai classici di cui sono disponibili sintesi e commenti ma non traduzioni ed edizioni critiche), ma anche a scapito degli effettivi approfondimenti, spesso presenti nelle monografie ma che finiscono per così dire “affogati” nella rincorsa di una pretesa esaustività richiesta da questo genere accademico. L’ Associazione Culturale “Louis Althusser” ha dedicato al grande filosofo francese un’intera collana[1], ma ha scelto di procedere diversamente: privilegiando innanzitutto la letteratura primaria, cioè le edizioni delle opere di Althusser – di cui c’era un gran bisogno dato il modo frammentario, incompleto e dispersivo in cui sono state disponibili in Italia tra gli anni ’60 e gli anni ’80 – in traduzioni accurate e accompagnate da introduzioni pertinenti; in secondo luogo proponendo una letteratura secondaria, cioè interventi su Althusser, orientati alla ricerca e il più possibile utili agli studiosi. Il saggio bibliografico di Cristian Lo Iacono ne è un ottimo esempio. Come spiega l’autore stesso, «esso si presenta […] essenzialmente come uno strumento di lavoro» che offre agli studiosi le «basi informative che permettono di ricostruire scientificamente una vicenda e di reperirne i documenti». La vicenda, in questo caso, è rappresentata dalla ricezione italiana del filosofo francese, documentata attraverso il repertorio dei testi di Althusser e su Althusser pubblicati in Italia in un cinquantennio (dal 1959 al 2009), ordinati secondo i criteri esposti nel capitolo introduttivo, corredati da schede e indicizzati. Ne risulta certamente uno strumento prezioso per la ricerca, ma non soltanto questo. Le scelte di inclusione e di esclusione rispondono infatti a un principio ordinatore molto significativo e tutt’altro che neutrale. Lo Iacono considera infatti come “ricezione” non «la mera disponibilità di un testo ma la sua effettiva e documentabile presenza nel dibattito»: in altre parole, la produzione di effetti nella congiuntura culturale e politica. Il saggio bibliografico diventa così, a tutti gli effetti, anche un saggio di storia della filosofia – nel senso pieno e pregnante del termine, non nel senso fiacco dei manuali e delle monografie all’italiana. Direi proprio nel senso althusseriano del termine, poiché si tratta allora di interrogare di quei testi la giustezza[2], ossia il valore di posizione in una congiuntura determinata.
Intesa nel significato pregnante e specifico che si è detto, la ricezione di Althusser in Italia mostra una vicenda complessa, anzi “surdeterminata” dalle battaglie culturali e politiche che nel cinquantennio in esame investono l’Italia e la Francia. Così nella prima metà degli anni ’60 – all’inizio della ricostruzione proposta da Lo Iacono, in gran parte documentata dall’epistolario althusseriano – Althusser giudica “provinciali”, rispetto all’Italia, il marxismo francese e la politica del PCF, e proprio per questo è assai attento alla cultura filosofica e politica Italiana: «Althusser scoprì l’Italia e il marxismo italiano prima che l’Italia e il marxismo italiano scoprissero Althusser», mostrando com’è noto un particolare interesse per gli studi di Galvano della Volpe e Lucio Colletti. Segue un periodo in cui Althusser interviene direttamente nel dibattito italiano, «mediante una rete di rapporti intellettuali e personali intessuta di scambi epistolari, viaggi, pubblicazioni, partecipazione a convegni». Proprio di qui inizia la ricezione italiana di Althusser, a partire dalla pubblicazione di Per Marx, sostenuta da Cesare Luporini che cerca appoggi alla propria “svolta antistoricista”. Ma intervengono a questo punto «una serie di sfasature temporali nella pubblicazione di opere o di parte di opere […] che condizionano negativamente la ricezione stessa e l’intelligenza dei veri obbiettivi dell’impresa althusseriana». Comprendiamo così perché gli anni ’60 e ’70 lascino nel panorama editoriale italiano una presenza delle opere di Althusser tanto frammentaria per tempi, modi e luoghi di pubblicazione. L’operazione culturale condotta da Althusser su Marx e sul marxismo e i suoi effetti politici sulla concezione del partito, dello Stato, della “transizione al socialismo” (come allora si diceva) in Italia non è compresa fino in fondo[3] – come ben dimostra, a mio avviso, l’ultimo dibattito suscitato da Althusser, quello sullo Stato[4]. L’incontro del marxismo italiano – pur vivace in alcune sue componenti – con il marxismo di Althusser è per il momento un incontro mancato, o quanto meno un incontro che “non fa presa”[5].
Il saggio di Lo Iacono si conclude con alcuni cenni al “nuovo ciclo della ricezione” che si apre nel 1990, anno della “morte biologica” di Althusser che chiude il decennio buio e silenzioso della sua “morte sociale”, «l’uscita di scena, tragica come mai ci sarebbe immaginato che fosse, del filosofo marxista come uomo pubblico». La riscoperta di Althusser avviene a livello internazionale, ma la Francia e l’Italia rappresentano ancora centri di irradiamento privilegiati. La Francia, grazie ai lavori condotti sul ricchissimo fondo depositato presso l’archivio dell’IMEC che portano alla luce importanti inediti, oltre alla produzione “solitaria” degli anni ’80. L’Italia, grazie al sistematico progetto editoriale portato avanti a partire dal 2000 dall’Associazione Culturale “Louis Althusser” con la presente collana.
La rinascita dell’interesse per il filosofo francese è un fenomeno tutt’ora in corso, su cui perciò risulta difficile esprimere una valutazione: giustamente Lo Iacono sceglie di farne un resoconto, segnalando i principali filoni di interesse e documentando le iniziative editoriali più importanti. Da parte mia, azzardo semplicemente l’indicazione di alcune direzioni principali in cui mi sembra si stia orientando la ripresa degli studi su Althusser. Riemerge, in primo luogo, la grandezza di Althusser come interprete di Marx. La rilettura di Marx da parte di Althusser non mette capo a un’ermeneutica, non cerca cioè di “comprendere” Marx ma di ricostruirne piuttosto la problematica riorientandone gli effetti sul presente, con un’operazione per certi aspetti “violenta”. Si tratta, in molti passaggi, di giocare Marx contro Marx – ad esempio, il Marx che pensa la genesi del modo di produzione capitalistico attraverso una «teoria esplicita dell’incontro»[6] (nel capitolo sull’accumulazione originaria) contro il Marx che «cede […] a una concezione totalitaria, teleologica e filosofica»[7] della storia. Ho definito questa interpretazione “violenta” nel senso che conduce a trasformare più che a restituire il testo marxiano. E tuttavia occorre sottolineare che essa ha trovato significativi riscontri nei lavori di edizione critica
della nuova Marx-Engels Gesamtausgabe (la cosiddetta MEGA 2), ripresi a partire dagli anni ’90 al di fuori dell’egida sovietica grazie a un impegno internazionale, che ci stanno consegnando un Marx significativamente diverso da quello conosciuto nel secolo passato.
In secondo luogo, viene valorizzata la portata filosofica – più precisamente, epistemologica – dell’opera di Althusser, che si rivela una componente cospicua, e particolarmente importante perché centrata sulle scienze sociali, di quel filone filosofico francese che ha saputo pensare la storicità delle scienze e che oggi sta prepotentemente uscendo dai confini di una tradizione nazionale per contrapporsi efficacemente ai limiti del neopositivismo logico e della filosofia analitica – a suo tempo magistralmente criticati da Althusser nei Cours de philosophie pour scientifiques. La nostra associazione, che ha inaugurato le sue pubblicazioni proprio con l’edizione completa di questo testo althusseriano[8], ha particolarmente approfondito il legame di Althusser con questa tradizione, aprendo nel 2003 la collana Epistemologia.
Infine, trovo di grande interesse – e mi auguro abbia in un futuro prossimo adeguati sviluppi – la ripresa degli strumenti concettuali coniati e utilizzati da Althusser per l’analisi politica, quali “congiuntura”, “surdeterminazione” o l’“accumulazione di determinazioni efficaci” di cui si parla in alcuni saggi di Per Marx[9] particolarmente significativi su questo terreno di ricerca. Segnalo in proposito i lavori del Groupe de Recherches Matérialistes, che ha recentemente varato la rivista on line Chaiers du GRM (http://www.europhilosophie-editions.eu/fr/spip.php?mot113) finalizzata alla «riappropriazione critica dei significati implicati nel corpus del pensiero rivoluzionario, marxista, comunista, anarchico del XIX e del XX secolo», riproponendo a mio avviso proprio quella «concezione rigorosa dei concetti marxisti, delle loro implicazioni e del loro sviluppo», quella «ricerca rigorosa di ciò che li distingue eternamente dai loro fantasmi»[10] che Althusser riteneva urgente negli anni ’60 e che oggi appare tanto più necessaria.
[1] La collana, in realtà, non ospita solo scritti di e su Althusser, ma anche dei suoi principali allievi e collaboratori. Come ricorda Lo Iacono, «uno dei caratteri precipui del lavoro di Althusser era costituito dal fatto che egli concepiva tale lavoro come produzione collettiva». Così, oltre alla traduzione di tutte le relazioni di Leggere il Capitale, uscito a suo tempo in Italia in un’edizione che comprendeva i soli contributi di Althusser e Balibar (L. Althusser, E. Balibar, R. Establet, P. Macherey, J. Rancière, Leggere il Capitale, Mimesis, Milano 2006), sono presenti (per ora) nella collana anche scritti di Ch. Bettelheim (Ch. Bettelheim, Calcolo economico e forme di proprietà, Mimesis, Milano 2005) e N. Poulantzas (N. Poulantzas, Il declino della democrazia, Mimesis, Milano 2009).
[2] Cfr. Louis Althusser, Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati. Corso di filosofia per operatori scientifici, Unicopli, Milano, 2000, p. 53.
[3] Argomento meglio questo giudizio – in cui non voglio coinvolgere Cristian Lo Iacono – in M. Turchetto, I “due Marx” e l’althusserismo, in R. Bellofiore (a cura di), Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento, Manifestolibri, Roma 2007, pp. 101-107.
[4] Cfr. L. Althusser et al., Discutere lo Stato. Posizioni a confronto su una tesi di Louis Althusser, De Donato, Bari 1978.
[5] Cfr. L. Althusser, Sul materialismo aleatorio, Mimesis, Milano 2006, p. 70.
[6] Ivi, p. 71.
[7] Ivi, p. 72. L’importanza dei testi postumi, in particolare di quelli sul “materialismo aleatorio”, in questo senso è enorme.
[8] Louis Althusser, Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati. Corso di filosofia per operatori scientifici, cit. Questa edizione comprende anche la quinta lezione oltre al testo della lezione inaugurale di Jaques Monod al Collège de France del 1967, che Althusser esamina nella quarta lezione.
[9] In particolare in Contraddizione e surdeterminazione (note per una ricerca), in L. Althusser, Per Marx, Mimesis, Milano 2008, pp. 81-107.
[10] Ivi, p. 107.