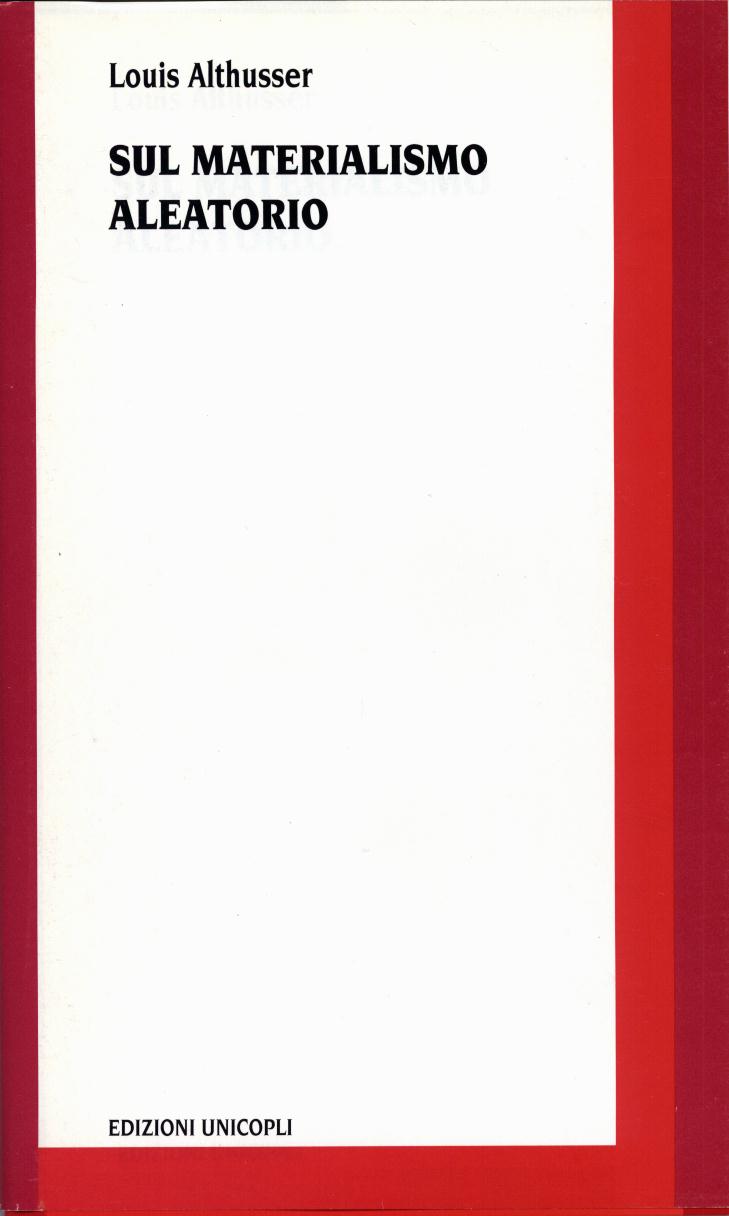
Sul materialismo aleatorio
a cura di Vittorio Morfino e Luca Pinzolo
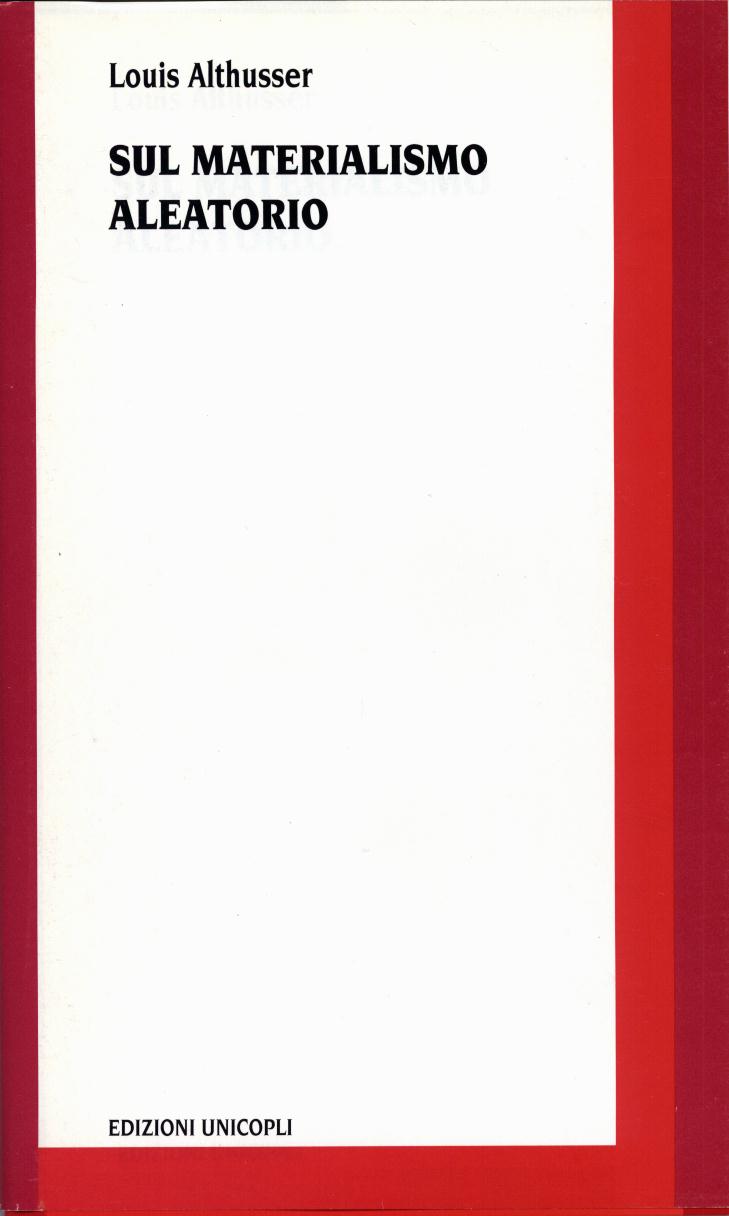 |
Louis Althusser Sul materialismo aleatorio a cura di Vittorio Morfino e Luca Pinzolo |
Introduzione
di Vittorio Morfino e Luca Pinzolo
Negli scritti degli anni '80, qui raccolti per la prima volta in unatraduzione italiana, Althusser riprende alcuni dei temi cruciali giàal centro delle grandi opere degli anni '60, Leggere 'Il Capitale' ePer Marx: quelli della temporalità, della contraddizione,della complessità. Vale quindi la pena di ripercorrerne i trattiteoreticamente più significativi.
Nell'"Abbozzo di una teoria della temporalità" Althussertratta la categoria di tempo storico in opposizione a quella hegeliana,le cui caratteristiche fondamentali sono la continuità omogenea deltempo e il presente storico come contemporaneità di un'epoca a sestessa: l'intento di Althusser è quello di produrre la "conoscenzaadeguata" del tempo storico non come reductio ad unum sottoun ritmo fondamentale, bensì come "costruzione" di temporalitàdifferenziali il cui intreccio non è dominato da alcuna prestabilitaarmonia, ma dalla necessità della contingenza.
Nei capitoli centrali del Per Marx, "Contraddizione e surdeterminazione"e "Sulla dialettica materialista", questi temi vengono affrontatisotto il punto di vista di una resa dei conti col tema della contraddizionein Hegel e Marx. In questo senso, Althusser contrappone al modello hegelianodella contraddizione semplice, possibile come tale "per la semplicitàdel principio interno che costituisce l'essenza di ogni periodo storico"(L. Althusser, Pour Marx, La Découverte, Paris 1966, p. 84;tr. it. a cura di F. Madonia, Editori Riuniti, Roma 1967, pp. 83-84), lacontraddizione marxiana nella quale la determinazione dell'economico "inultima istanza" si trova ad essere sempre surdeterminata dalle circostanzesovrastrutturali: "Non abbiamo dunque più (qualunque ne siala forma) un'unità semplice originaria, ma il sempre-già-datodi un'unità complessa strutturata" (ivi, p. 204; tr. it. cit., p. 176). Il che permette ad Althusser di affermare che gli accadimentirivoluzionari non sono inseribili in un'idea "astratta ma confortante,rassicurante, di uno schema 'dialettico' depurato, che aveva, nella suastessa semplicità, come serbato la memoria (o ritrovato l'andamento)del modello hegeliano" (ivi, p. 103; tr. it. cit., p. 85); ma al contrariobisogna pensare la situazione rivoluzionaria nei termini dell'eccezione:"Ritorniamo dunque a Lenin e attraverso Lenin a Marx. Se è vero,come dimostrano tanto l'esperienza quanto la riflessione leninista, chela situazione rivoluzionaria in Russia dipendeva precisamente dal carattered'intensa surdeterminazione della contraddizione fondamentale di classe,bisogna forse domandarsi in che cosa consista l'eccezionalità diquesta 'situazione eccezionale' e se, come ogni eccezione, questa eccezionenon illumini la regola, se non sia, all'insaputa della regola, la regolastessa. Giacché infatti, non siamo forse sempre nell'eccezione?"(ibidem).
Tutto ciò si riassume con estrema sintesi e chiarezza nella notadistinzione, proposta da Althusser, tra tutto e totalità: "Hegelpensa la società come una totalità, mentre Marx lapensa come un tutto complesso, strutturato a dominante. Se mi èconsentito essere un po' provocatorio, mi sembra che si possa lasciare aHegel la categoria di totalità, e rivendicare per Marx la categoriadi tutto. Si dirà che non è altro che una sfumatura verbale;ma io non lo credo affatto. Se ho preferito per Marx la categoria di tuttoa quella di totalità, è perché nel cuore della totalitàè sempre presente una duplice tentazione: quella di considerarlacome un'essenza attuale che abbraccia esaustivamente tutte le sue manifestazionie (ciò che è poi la stessa cosa) quella di scoprire in essa,come in un cerchio o in una sfera (metafore che ci rimandano a Hegel) uncentro che ne è l'essenza. [...] Ecco perché ho parlato diun tutto, per sottolineare che nella concezione marxista di una formazionesociale tutto è collegato, che l'indipendenza di un elemento èsempre la forma della sua dipendenza, e che il gioco delle differenze èdominato dall'unità di una determinazione in ultima istanza; ma eccoperché non ho parlato di una totalità, perché il tuttomarxista è complesso e ineguale e segnato di ineguaglianza da unadeterminazione in ultima istanza. E' questo gioco, questa ineguaglianza,che permette di pensare che ad una formazione sociale possa accadere qualcosadi reale, e che la lotta politica di classe possa aver presa sulla storiareale. L'ho detto di passaggio: non si è mai vista una politica ispirataa Hegel. Infatti, dove si può far presa sul cerchio, se si èpresi nel cerchio?" (L. Althusser, "Est-il simple d'êtremarxiste en philosophie?", in La pensée n. 183, 1975, pp. 14-15;tr. it. a cura di C. Mancina, in Freud e Lacan, Editori Riuniti,Roma 1981, pp. 143-145).
Se negli anni '60 Althusser ha insistito sul carattere della complessitàdella struttura, egli dedicherà l'ultima fase della sua riflessionead un'investigazione più dettagliata degli inizi e della genesi diuna tale complessità, premessa necessaria alla comprensione dellarealtà come Faktum di una pluralità in disseminazione.Emerge la distinzione tra congiuntura e congiunzione (questo tema ègià presente in una nota di lavoro del 1966: "1. Théoriede la rencontre ou conjonction (= genèse...) (cf. Epicure,clinamen, Cournot) hasard etc., précipitatio, coagulation. 2. théoriede la conjoncture (= conjonction)" F. Matheron, "Présentation"à L. Althusser, Ecrits philosophiques et politiques, tomeI, Stock/Imec, Paris 1994, p. 21), ma soprattutto il modello epicureo dellacaduta parallela degli atomi e del loro incontro reso possibile dal clinamen.E' importante sottolineare che questa tematizzazione di una "contingenzatrascendentale" del mondo non ha nulla a che vedere con la riproposizionedi una causalità per libertà in senso kantiano, che d'altraparte è sempre stata un oggetto privilegiato delle critiche di Althusser.Si tratta piuttosto della ripresa del tema della complessità sempre-già-datanella prospettiva non già della sua dissoluzione rivoluzionaria madella sua stessa costituzione aleatoria. In questo senso la contingenzanon si oppone tanto alla necessità, quanto alla teleologia. Il vuotoe gli atomi epicurei non fondano dunque la libertà, ma piuttostosono la garanzia dell'assenza di un piano precedente il loro incontro. Nulla,se non le circostanze fattuali dell'incontro, ha preparato l'incontro stesso:questo il senso dell'insistenza althusseriana sul vuoto e sul nulla, nonuna mistica che ne fa l'altro nome di Dio, ma il nulla di tutto ciòche non è pura fatticità.
In questa prospettiva Althusser evoca gli autori di quella che egli chiamala corrente sotterranea del materialismo aleatorio o dell'incontro: Machiavelli,Spinoza, Hobbes, Rousseau, il giovane Engels, qualche lampo del vecchioMarx, Heidegger, Derrida. In alcuni concetti di questi autori Althusservede l'esercizio di una pratica filosofica estrema, volta a pensare glielementi che costituiscono la realtà non nelle leggi teleologichedella loro riproduzione, ma nell'oscillazione sempre aperta del loro incontrosenza garanzie. Questo egli trova negli atomi epicurei, nella teoria dellafortuna e della virtù di Machiavelli, nel Deus sive natura diSpinoza, nello stato di natura di Hobbes, nell'erranza dei selvaggiroussoviani, nella descrizione della situazione della classe operaia inglesedi Engels, nell'incontro tra proprietari di denaro e proletari nel capitolosull'accumulazione originaria di Marx, nell'es gibt e nella Geworfenheitheideggeriana, nel Wittgenstein della I proposizione del Tractatus,infine nella disseminazione di Derrida.
Constatazione dell'es gibt o del Fall, la filosofia si traducenell'assalto al potere. Dove il filosofo idealista vede il "pieno"di uno sviluppo necessario della totalità, quello materialista vedeil vuoto che dalla necessità risale a congiunzioni aleatorie. Inquesto senso in Althusser compaiono due figure del lavoro filosofico auxextrèmes. Una, per così dire, dinamica: è il filosofoche registra sequenze aleatorie nel momento stesso in cui, come un guerriglieromessicano, va all'assalto di un treno in corsa. Ma l'altra corrisponde all'immaginequieta del saggio dedito all'otium, capace di una "perdita ditempo" che sospende l'incasellamento degli istanti in una freccia progressiva.E' la stupefacente immagine che Althusser dà di se stesso nel PerMarx: "Rousseau diceva che con i bambini e gli adolescenti l'artedell'educazione sta tutta nel sapere perdere tempo. Anche l'artedella critica storica consiste nel sapere perdere abbastanza tempo perchéi giovani autori si facciano grandi. Questo tempo perso non è cheil tempo che diamo loro per vivere. E' la necessità della loro vitache noi scandiamo con la nostra intelligenza, secondo i suoi nodi, i suoirinvii, i suoi mutamenti. Non ci può essere, a questo livello, gioiamaggiore che assistere così, in una vita che nasce, una volta detronizzatigli Dei delle Origini e dei Fini, alla genesi della necessità (L.Althusser, Pour Marx, cit., p. 67; tr. it. cit., p. 53).
Vittorio Morfino, Luca Pinzolo
ottobre 2000