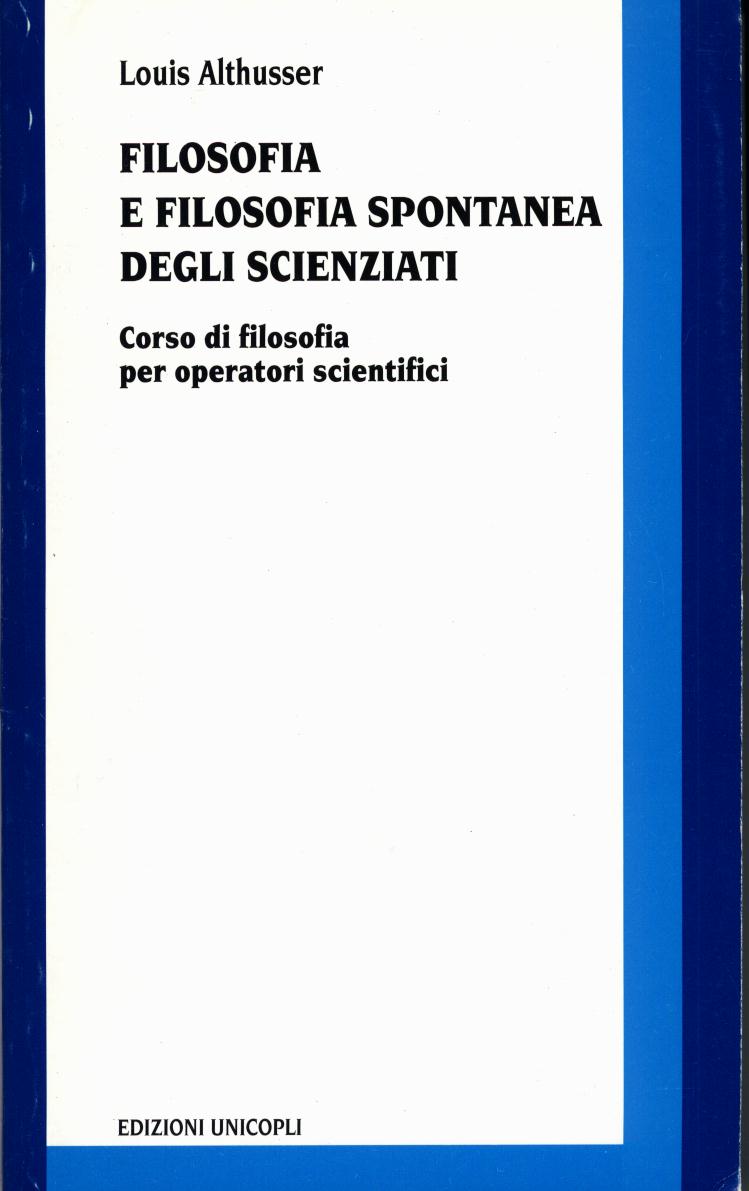
Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati
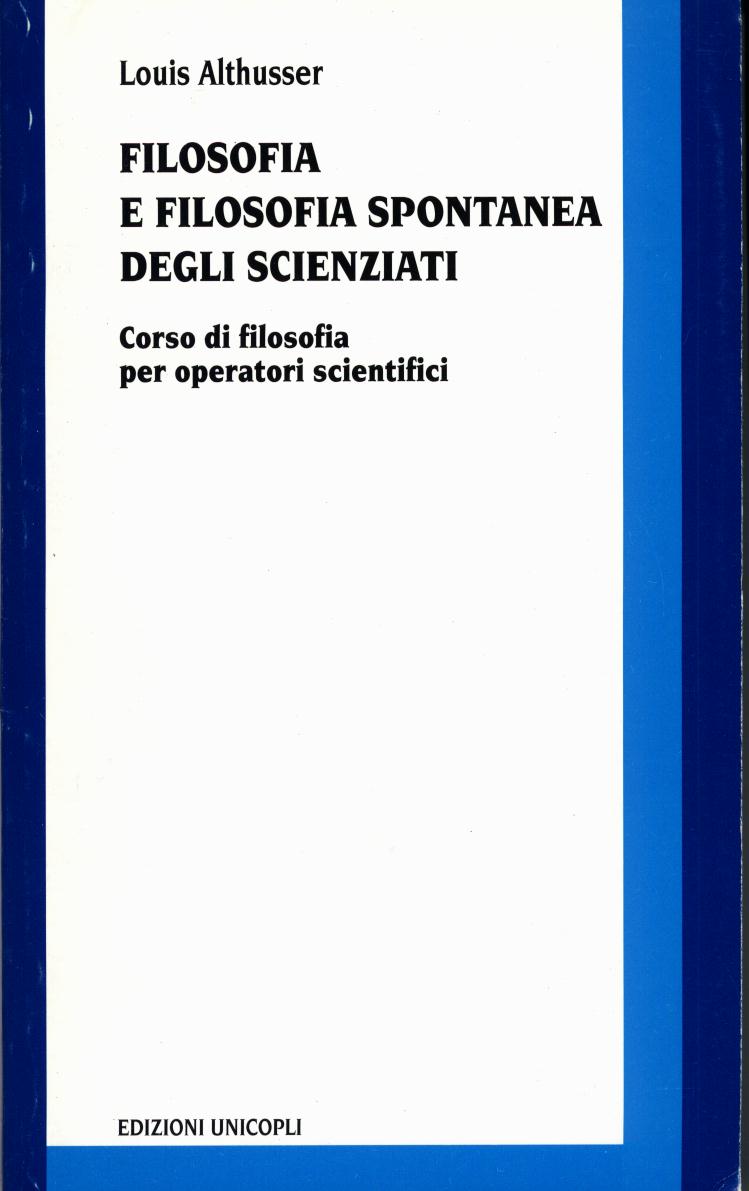 |
L. Althusser Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati |
Introduzione
di Maria Turchetto
Questo volume, che inaugura la collana "Althusseriana" curatadall'Associazione "Louis Althusser", presenta una nuova edizionedel Corso di Filosofia per operatori scientifici tenuto da Althisser pressol'Ecole Normale Supérieure di Parigi nell'anno accademico 1967-68.Nuova è la traduzione delle prime quattro lezioni, pubblicate inFrancia con il titolo Philosophie et philosophie spontanée dessavants nel 1974 e tradotte in Italia due anni dopo (Filosofia efilosofia spontanea degli scienziati e altri scritti, Bari 1976). Laquinta lezione è stata pubblicata in Francia dopo la morte di Althusser:la traduzione che qui presentiamo ne rappresenta la prima edizione italiana.Era finora inedito in Italia anche il testo della lezione di Jaques Monod,commentato e analizzato nel quarto corso althusseriano, che qui pubblichiamoin appendice.
Non sono note le ragioni per cui Althusser non incluse la quinta lezionenell'edizione del 1974. Certo, il 1974 è anche l'anno in cui uscironoin Francia gli Eléments d'autocritique (trad. it. Elementidi autocritica, Milano 1975), con la condanna del precedente "teoricismo"e l'affermazione del "primato della funzione pratica sulla funzioneteorica nella filosofia". La stessa breve Avvertenza premessa da Althusserall'edizione di Philosophie et philosophie spontanée des savantsdel 1974 si preoccupa di torcere il senso delle prime quattro lezioni pubblicate,ricche di riferimenti a Lenin e alla sua prassi politica, nella nuova direzionedella filosofia intesa come "lotta di classe nella teoria", controle precedenti opere "teoriciste" (Per Marx e soprattuttoLeggere Il Capitale) che definivano la filosofia come "teoriadella pratica teorica". In questa stagione "autocritica"dell'elaborazione althusseriana, la quinta lezione, in cui si legge che"l'intervento della filosofia ... consiste essenzialmente oggi nellasua partecipazione all'elaborazione delle Teorie seguenti: Epistemologiao Teoria dei processi di produzione di conoscenze scientifiche, Teoria dellastoria delle scienze, Teoria del Filosofico, Teoria della storia delle filosofie"(cfr. Tesi 41), poteva in effetti apparire una riproposizione forte delripudiato "teoricismo".
Eppure il quinto corso rappresenta un completamento necessario del percorsocompiuto da Althusser in questa serie di lezioni, che hanno lo scopo didefinire la filosofia in rapporto alle scienze ("il rapporto dellafilosofia con le scienze costituisce la determinazione specifica della filosofia"recita la Tesi 24), affrontando la questione dapprima "sul versantedelle scienze" (a partire dal secondo corso), successivamente "sulversante della filosofia" (titolo del quinto corso).
"Sul versante delle scienze", Althusser mette in evidenza lo "sfruttamento"che determinate filosofie (spiritualiste e idealiste) esercitano sulle scienze,con particolare accanimento nei periodi di "crisi", piegandoleal servizio di determinate ideologie pratiche (religiose, morali, giuridiche,politiche). "Sul versante della filosofia", Althusser smonta ilmeccanismo operativo delle filosofie in questione, riducendolo a due variantifondamentali (empirista e formalista) dell'invariante di ogni filosofiaidealista rappresentata dalla formula (Soggetto = Oggetto) = Verità.Le filosofie concretamente operanti nella storia sono variazioni e combinazioni(poiché non si danno un empirismo assoluto né un formalismoassoluto: "ogni rappresentazione filosofica della conoscenza scientifica,che si può trovare empiricamente nelle filosofie esistenti nellastoria della filosofia, è un compromesso tra queste due forme tipiche")storicamente determinate delle due varianti fondamentali. Questo èappunto il contenuto del quinto corso, che si conclude con l'ipotesi diuna "navigazione controvento" rispetto alle filosofie basate sulmeccanismo idealista, enunciata "sulla base non della filosofia ingenerale, ma sulla base di una filosofia particolare, che è diversadalla stragrande maggioranza delle filosofie della storia della filosofia,ma permette tuttavia di parlarne, poiché permette di comprenderlespiegandole: il materialismo dialettico".
"Comprenderle spiegandole": poiché il materialismo dialetticoha un vantaggio. Come tutte le grandi filosofie, il materialismo dialetticofa seguito a una rivoluzione scientifica: "ai metematici greci fa seguitola filosofia di Platone; alla costituzione della fisica galileiana la filosofiacartesiana; alla fisica newtoniana la filosofia kantiana; alla logica matematicala filosofia di Husserl. Aggiungo: alla scienza della storia fondata daMarx, una nuova filosofia, il materialismo dialettico". Ora, il caratterepeculiare della "scienza della storia" inaugurata da Marx consistenel nesso funzionale stabilito tra le diverse pratiche sociali (i rapportieconomici, giuridici, politici, ideologici) e i rapporti di produzione.Ciò fornisce alla "filosofia" uno strumento privilegiatoper svolgere quel compito di "tracciare una linea di demarcazione tral'ideologico delle ideologie da una parte, e lo scientifico delle scienzedall'altra" (Tesi 20), dunque per controllare, comprendendolo e spiegandolo,il nesso con le ideologie pratiche che ogni processo conoscitivo necessariamenteintrattiene. Per questo il materialismo dialettico può proporre allescienze un'"alleanza" contro le filosofie che sfruttano le scienze(terzo corso).
Il quinto corso chiarisce assai bene come la demarcazione tra scientificoe ideologico non sia assimilabile alle demarcazioni tra "Verità"ed "Errore" presente, in diverse varianti, nelle filosofie inultima analisi idealiste di cui viene mostrato il meccanismo invariante.L'elemento ideologico, ossia il rapporto con una ideologia pratica, infatti,non è eliminabile, ma semplicemente riconoscibile e in quanto talecontrollabile. Non si dà conoscenza "pura" nella misurain cui i "processi di produzione delle conoscenze" (Tesi 31) nonsi svolgono nel vuoto pneumatico ma in un contesto sociale con cui intrattengonorelazioni necessarie. E' possibile cambiare tali relazioni, agirle anzichéesserne agiti, imparare a controllare "il vento dell'ideologico"per avanzare contro di esso, per navigare controvento, come dice la metaforache chiude il corso.
Maria Turchetto
aprile 2000