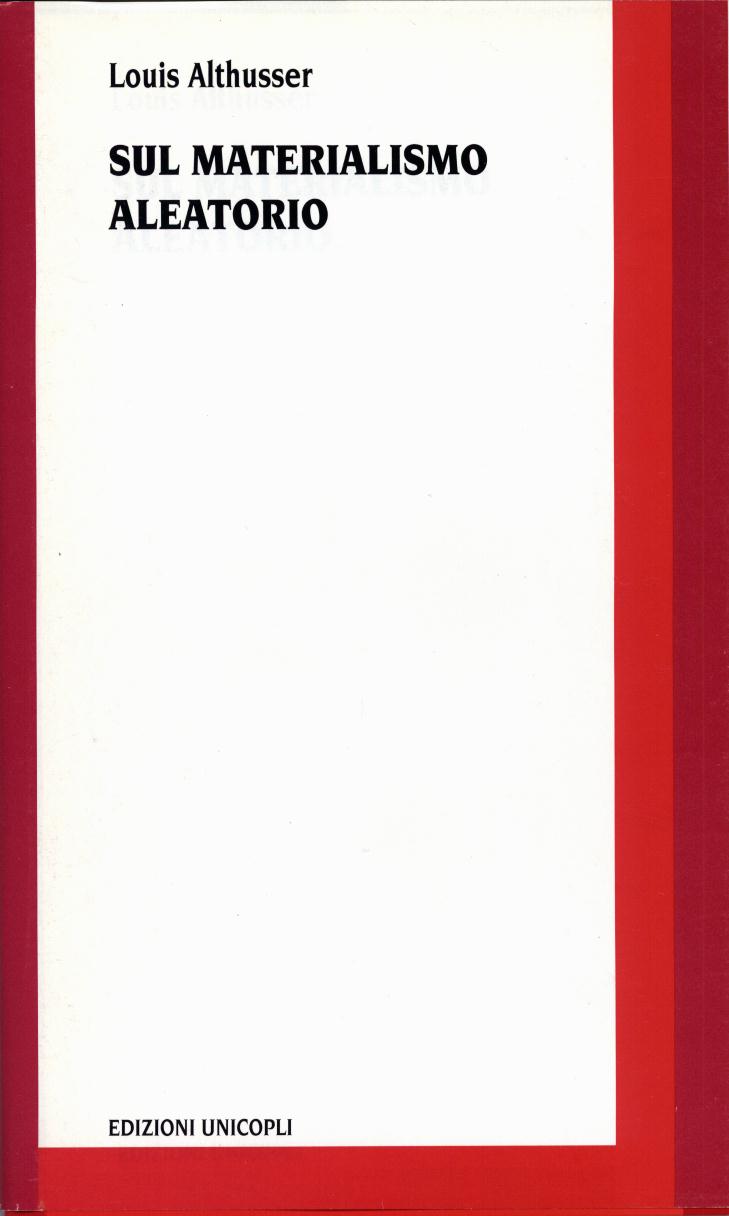
Sul materialismo aleatorio
a cura di Vittorio Morfino e Luca Pinzolo
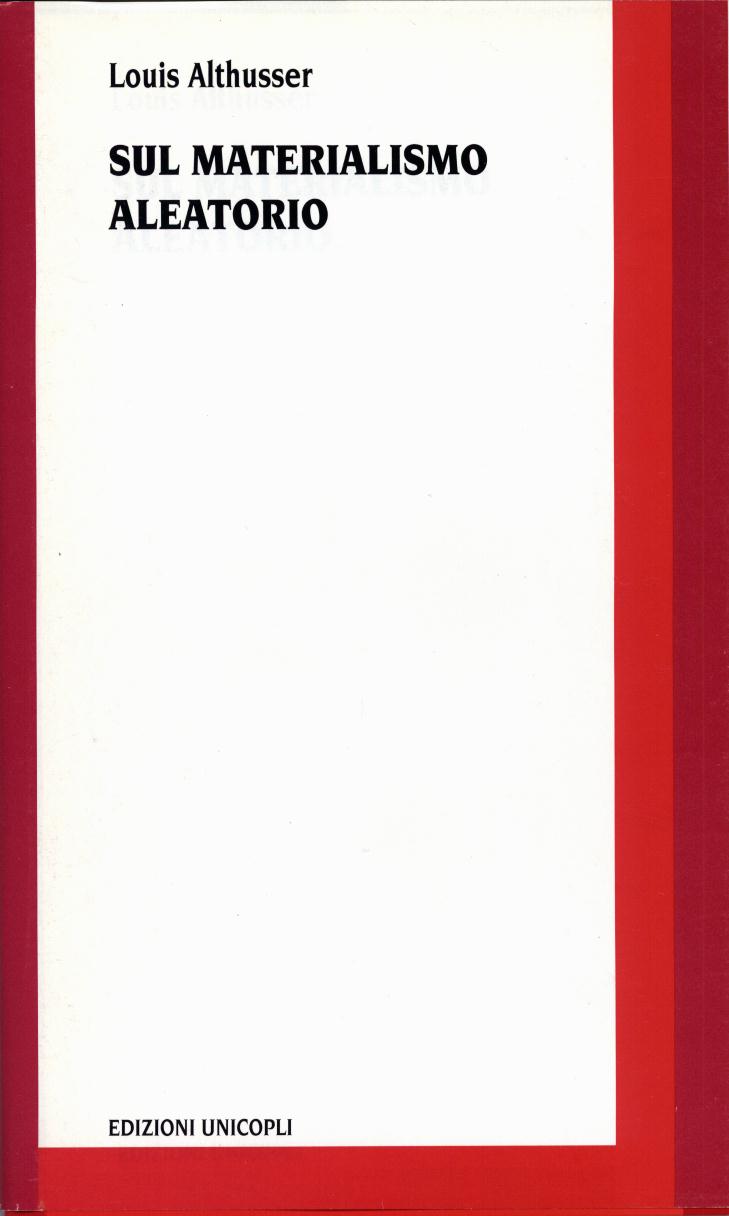 |
Louis Althusser Sul materialismo aleatorio a cura di Vittorio Morfino e Luca Pinzolo |
Recensione
di Augusto Illuminati
Gli scritti anni '80 di Louis Althusser coincidono con una fase assai
delicata della sua biografia e risentono, nelle ripetizioni e nella frammentarietà,
dello scarso controllo esercitato dall'autore sulla sua ultima produzione.
Tuttavia portano all'estremo il nucleo più innovativo del suo pensiero
e oggi entrano in sintonia esemplare con la congiuntura storica e con la
crisi, si spera produttiva, dei comunisti. La riflessione contenuta in Sul
materialismo aleatorio (Milano, Unicopli, 2000, a cura di Vittorio
Morfino e Luca Pinzolo, con un saggio introduttivo di Stanislas Breton,
pagg. 211, lire 28.000 -solo da poche settimane in libreria) corrisponde
all'infondatezza di un progetto rivoluzionario che coincide con l'apertura
massima della possibilità più che con la stringente necessità
dei modelli di un tempo. Quando, se non oggi, si potrebbe meglio recepire
la lezione machiavellica sulla fortuna? Due sono i momenti di massima consapevolezza
della casuale necessità della rivoluzione: al vertice del successo
e nell'abisso della disperazione. Un giorno prima era troppo presto, un
giorno dopo troppo tardi -disse Lenin del 7 novembre. Oggi la situazione
è rovesciata, ma la coscienza della fluttuazione impercettibile è
altrettanto viva.
Per Althusser esiste una tradizione, misconosciuta e temibile, di materialismo
aleatorio -della pioggia, della deviazione, dell'incontro e della presa.
La pioggia epicurea e lucreziana degli atomi, cui un piccolo clinamen
imprime una combinazione casuale, lo scorrere parallelo e l'intreccio
spinoziano delle serie infinite di modificazioni dei due attributi estensione
e pensiero, la capacità machiavellica di afferrare per i capelli
la Fortuna al momento giusto, realizzando nell'attimo tutta la propria virtù-potenza.
Ciò che peraltro è facilitato dalla virtù della volpe,
dalla capacità (spinoziana!) dell'individuo-principe di gestire la
trasformazione delle passioni tristi in passioni gioiose. La fortuna si
confronta senza altre garanzie con il vuoto, coglie l'occasione con un cortocircuito
che potrebbe anche mancare, quasi secolarizzando il rapporto fra mistico
e Dio nella teologia negativa.
Un materialismo dell'incontro e della contingenza che si oppone, come un
pensiero totalmente altro, ai vari materialismi della necessità e
della teleologia, forme in ultima istanza mascherate di idealismo, variazioni
sul grande tema della metafisica occidentale, del :logocentrismo che postula
l'antecedenza del Senso su ogni realtà. Il più raffinato oblio
del materialismo dell'incontro è quello che interpreta la contingenza
come lo spazio della libertà umana, sottratta al comune impero della
natura: occorre piuttosto pensare la necessità come il divenir necessario
dell'incontro di contingenti invece che la contingenza come modalità
o eccezione della necessità. La nascita di un mondo dal clinamen
della pioggia atomica va invece letto in modo radicale: l'esistenza
stessa degli atomi non sopraggiunge loro che dalla deviazione e dall'incontro,
prima del quale essi non conducevano che un'esistenza fantomatica. Il mondo
è il fatto compiuto dove a posteriori si installano Senso, Ragione,
Fine, ecc., ma esso stesso è puro effetto della contingenza: prima
di esso abbiamo soltanto l'esistenza irreale degli atomi, il non-mondo,
il non compimento del fatto. In questo senso Die Welt is alles, was der
Fall ist (L. Wittgenstein,Tractatus logico-philosophicus 1) -che
normalmente viene tradotto <<il mondo è tutto ciò che
accade>>, ma letteralmente significa: tutto ciò che (ac)cade,
tutto ciò di cui è il caso (caduta, occorrenza, casualità).
La segreta filosofia dell'incontro scorre da Epicuro a Marx in contrapposto
a ogni filosofia dell'essenza, logos, origine e fine, insomma dell'Ordine
razionale, morale-religioso o estetico, rifiuta il Tutto a vantaggio della
disseminazione e del disordine, pensa l'origine come niente e come informe,
<<prende il treno in corsa>> e a forza di braccia salta sul
vagone, che corre dall'eternità come l'acqua di Eraclito, senza sapere
da dove viene e dove va. Attraverso l'immagine althusseriana vediamo nel
filosofo materialista quasi un attivista IWW che gira l'America a scatenare
scioperi, nascondendosi dagli sbirri e battendo i centri industriali e minerari
lunga la ferrovia... La genealogia dell'aleatorio parte dall'atomismo, passa
per Machiavelli (cfr. i corsi universitari del 1962 e 1972, tradotti per
la manifestolibri con il titolo Machiavelli e noi, Roma 1999)
e Spinoza -che rifiutano ogni garanzia trascendente per la pratica e la
conoscenza-, perfino per un certo Hegel che cancella circolarmente soggetto
e fine nel processo, per Nietzsche, assertore del predominio della deviazione
sul percorso rettilineo, dello scarto sull'origine, culmina infine in Deleuze
e Derrida, con la comprensione del limite come condizione assoluta di ogni
pensiero e azione. Tutto si ripete e non esiste che nella ripetizione differenziale.
La decostruzione conclude che <<il vuoto è la filosofia stessa>>,
la sua infinita possibilità da nulla obbligata o attratta. Come la
storia, che è il risultato fattuale di una combinazione di elementi,
risultato senza causa, nato dall'incontro occasionale di virtù e
fortuna.
L'inserimento del pensiero di Marx ed Engels in questo materialismo è
assai più problematico rispetto a Per Marx e Leggere il
Capitale. Nel saggio del 1982 Sul pensiero marxista viene
rivalutato il giovane Engels della Situazione della classe operaia in
Inghilterra, fautore di una filosofia senza concetto né contraddizione,
rispetto alle marxiane Tesi su Feuerbach, apologia quasi fichtiana
della prassi identificata alla produzione soggettiva di un Soggetto. Il
cattivo residuo filosofico e l'equivoco dialettico permarrebbero in molte
parti del Capitale e alla grande nell'Antidühring, mentre
il realismo originario engelsiano trionfa nel capitolo sull'accumulazione
primitiva e nelle Glosse a Wagner, in cui scompaiono la contraddizione
fra valore d'uso e valore di scambio e la negazione della negazione. C'è
un Marx che concepisce il modo di produzione come incontro aleatorio fra
proprietario di denaro e proletario sprovvisto di tutto, incontro che ha
fatto presa e prodotto un fatto compiuto descrivibile attraverso leggi tendenziali
posteriori all'evento. E c'è un Marx che immagina in modo essenzialistico
questa combinazione come necessaria a priori, struttura che genera i suoi
elementi per riprodursi, in cui le storie individuali non fluttuano più
nella storia come atomi nel vuoto, ma la borghesia è predestinata
a scomporre il modo di produzione feudale per generarne uno nuovo, ecc.
(La corrente sotterranea del materialismo dell'incontro, 1982).
E' solo il primo Marx che ci serve politicamente nell'èra della globalizzazione,
della smaterializzazione e flessibilizzazione del lavoro (colte con grande
anticipo in uno scritto del 1985). Althusser intuisce con acutezza lo spostamento
dalla politica tradizionale all'ideologia, il primato assunto dagli automatismi
economici (di un'economia peraltro anarchica), l'assunzione degli uomini
di spettacolo sul proscenio della politica ridotta a circo (allora Reagan,
oggi c'è bisogno di nominarli?). La conclusione è assai scettica:
abbiamo qualche elemento di critica, nessuna prospettiva strategica d'insieme,
niente che permetta di fare anticipazioni sull'avvenire e di fondare un
nuovo principato. Si potrebbe diffidare di un aleatorio forse troppo ancorato
all'efficacia nel negativo, al vuoto mistico. Ma il metodo resta fecondo
proprio quando il nuovo diagramma delle relazioni fra linguaggio, lavoro
e politica ripropone l'alternativa fra comunismo e potere di controllo e
sfruttamento, alternativa non dialettica ma scandita dall'incontro degli
elementi, dalla soggettivazione su quella base di nuove figure della lotta
di classe.
(pubblicata su il Manifesto del 9/6/2001)