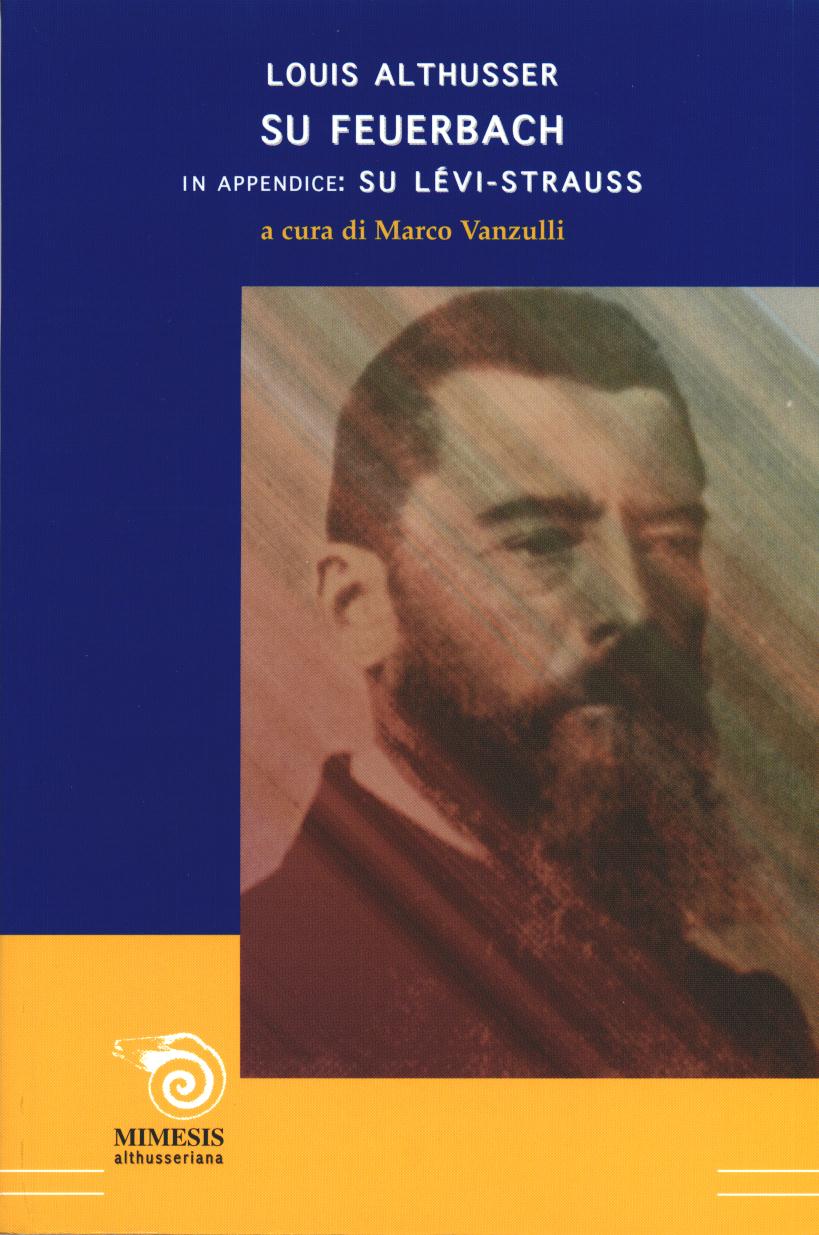 |
Louis Althusser Su Feuerbach |
Louis Althusser, Sur Feuerbach
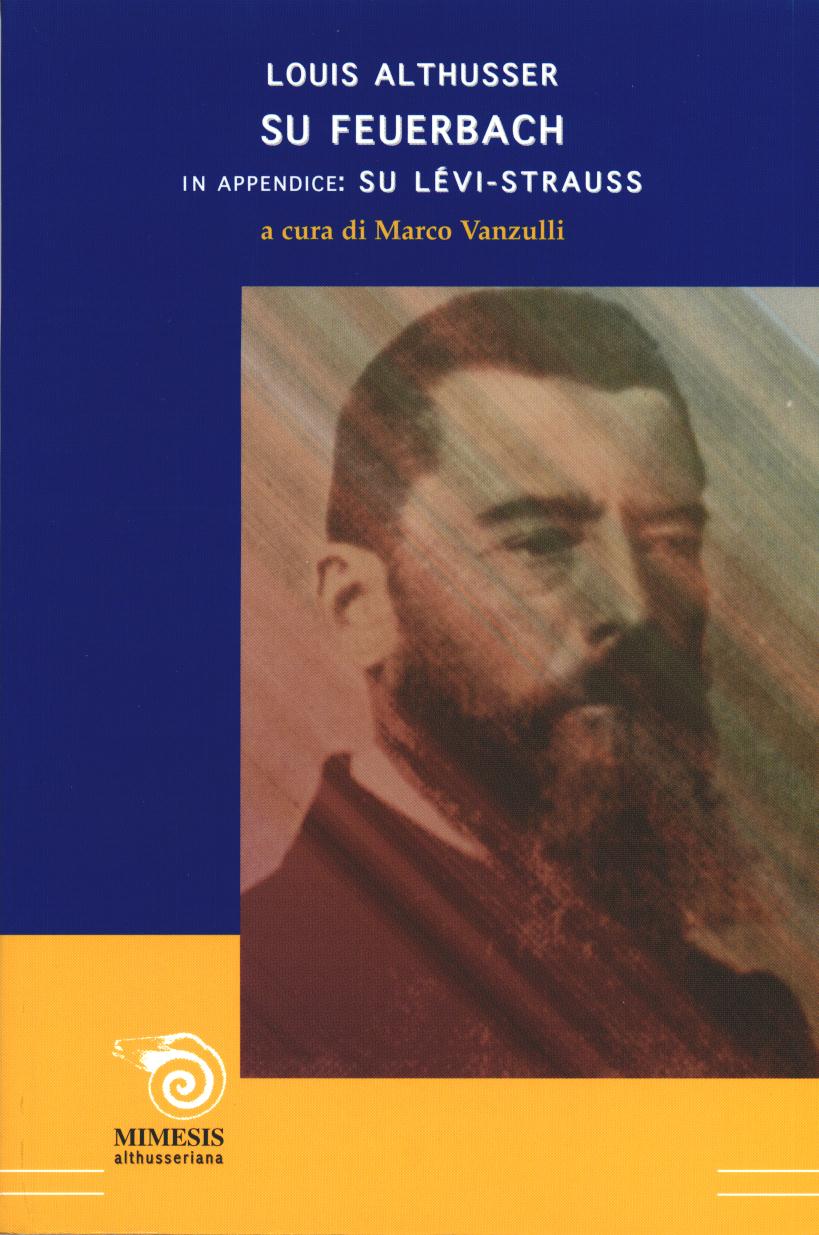 |
Louis Althusser Su Feuerbach |
Louis Althusser, Sur Feuerbach
A una prima lettura, si coglie subito che questo è un testo di
notevole impegno, certo forse un'opera "minore", ma più
per il tema trattato, che è assai specifico, che per gli strumenti
concettuali messi in atto e per le implicazioni teoriche connesse (il tema
dell'ideologia su tutti). Il contesto in cui venne elaborato - corso per
l'agrégation in filosofia - non deve perciò trarre in inganno.
Del resto, Althusser aveva pensato di pubblicare, insieme a Balibar, un'opera
su Feuerbach, di cui questo lavoro avrebbe costituito un primo abbozzo.
Per parte mia, l'esposizione che segue è svolta in corso d'opera,
e non è perciò da intendersi come complessiva e ben definita.
Mi limito soltanto a indicare i punti del testo che, in questo momento,
mi sembrano più stimolanti.
Tratto da un corso del 1967 sull'Ideologia tedesca, Sur Feuerbach
si presenta come un testo assai compatto, che non pretende di dare un quadro
generale del pensiero di Feuerbach, ma intende piuttosto approfondire, attraverso
Feuerbach, temi che stanno in un rapporto diretto con i problemi teorici
posti dai Manoscritti del '44 e da L'ideologia tedesca. Di
Feuerbach, Althusser aveva già curato un'edizione (Manifestes
philosophiques, Paris, PUF, 1960), e sono sempre e soltanto i testi
di quest'antologia ad essere adoperati anche questa volta. E anche dopo
questo corso del '67, Althusser continuerà a più riprese ad
occuparsi del contributo feuerbachiano alla questione dell'ideologia e della
sua soluzione umanistica - che "finisce sfortunatamente nell'ideologia
della Essenza Umana" (Ideologia ed apparati ideologici di Stato)
- per certi versi paradigmatica. D'altro lato, però, e sempre per
riconoscimento di Althusser in una nota di Ideologia ed apparati ideologici
di Stato - "Feuerbach è un 'teorico' sorprendente del rapporto
speculare" - a Feuerbach va il merito di aver chiarito la struttura
dell'ideologia (in lui presente come struttura dell'alienazione religiosa).
Feuerbach può essere così considerato un costante punto di
riferimento nella riflessione althusseriana intorno alla nozione di ideologia.
Conformemente al tema del corso, la lettura althusseriana di Feuerbach in
questo scritto parte innanzitutto dalla critica marxiana, in particolar
modo da quella contenuta nell'Ideologia tedesca e nelle Tesi su
Feuerbach e da quella engelsiana del Ludwig Feuerbach e il punto
d'approdo della filosofia classica tedesca. Su questa base è approfondito
il rapporto che legava l'autore dell'Essenza del Cristianesimo al
suo maestro, Hegel, secondo l'idea fondamentale per cui se da un lato Feuerbach
conduce oltre Hegel in direzione del materialismo, dall'altro però
egli non solo resta fermo ad Hegel, nella misura in cui tutto, nella critica
hegeliana di Feuerbach, rimane ancora soltanto dentro la filosofia, ma addirittura
arretra rispetto a Hegel verso le posizioni materialistiche di fine'700.
Un materialismo alla Diderot, una teoria della natura umana e dell'origine
alla Rousseau danno vita in Feuerbach ad una peculiare forma di materialismo
antropologico o umanistico.
D'altra parte, Althusser sceglie di adottare prospettive interne all'opera
fuerbachiana, di cui considera, con buone ragioni, centrale il tema della
relazione essenziale dell'oggetto al soggetto, attraverso la mediazione
delle nozioni strategiche e in buona misura coincidenti di specie ed essenza
umana; e il tema dell'alienazione come inversione di senso ed astrazione,
che conduce al rovesciamento materialistico della filosofia speculativa.
Di qui prende avvio un'analisi ricca di spunti e di suggestioni, che approfondisce
prima il significato della nozione feuerbachiana di oggetto e oggettivazione,
poi il carattere e la portata del suo metodo. Quest'ultimo in particolare,
in quanto sviluppa un'autentica teoria del significato, un'ermeneutica filosofica,
è, a parere di Althusser, tra i motivi del pensiero feuerbachiano
che, anche quando non riconosciuto, hanno avuto seguito - per esempio via
Nietzsche - nella filosofia successiva. Con la sua teoria dell'intenzionalità
della coscienza, Feuerbach anticipa - e con il linguaggio tradizionale che
parla di "facoltà" (la ragione, la volontà, l'amore)
- la fenomenologia husserliana. Althusser parte dunque dalla posizione critica
marxiana del 1845, ma la sua analisi attenta, pur non abbandonando lo sfondo
generale costituito dai problemi dei Manoscritti economico-filosofici
del '44 e dell'Ideologia tedesca, sa osservare dall'interno le
categorie operanti negli scritti feuerbachiani del periodo 1839-1845, riconoscendone
il nucleo teoretico e come questo si ritrovasse negli scritti marxiani del
1844-1845. Si può dire che, in modo del resto tradizionale, Feuerbach
serva ad Althusser per definire con chiarezza la posizione di Marx nelle
opere giovanili, al fine di riuscire a staccarlo in modo più netto
dall'autore de Il Capitale. Ciò vale innanzitutto per la nozione
di ideologia, che Feuerbach descrive con esattezza, di cui coglie il modo
del funzionamento. La concezione feuerbachiana di ideologia come svelamento
[Enthëllung] la si ritrova negli scritti del giovane Marx. Marx
si comporta coi concetti degli economisti classici come Feuerbach coi concetti
della religione: non li modifica, ma semplicemente li legge, rapportandoli
alla loro essenza nascosta, cioè l'alienazione del lavoro umano e
quindi l'essenza umana. Nei Manoscritti Marx non scopre ancora l'ideologia
nella pratica, non parla della pratica - la svolta sarà costituita
dalle Tesi su Feuerbach -, ma legge l'ideologia nel discorso economico,
così come Feuerbach la leggeva nel discorso religioso. E tutto ciò
si basa sulla teoria feuerbachiana dell'oggetto speculare al soggetto. Da
essa peraltro non ci si allontana senza prendere le distanze risolutamente
dalla "teoria genetica del sorgimento storico".
Tuttavia, dell'ideologia Feuerbach non coglie gli effetti strutturali, perché
rimane all'interno del problema del senso (ecco perché non è
capace di abbandonare il terreno della religione). Come lo strutturalismo,
con Lévi-Strauss, Feuerbach conduce un'analisi strutturale di un'ideologia,
restandone all'interno. La ripetizione isomorfica delle strutture, in Feuerbach
come in Lévi-Strauss, non fa che rinforzare le categorie ideologiche,
senza giungere mai alla vera questione: l'oggetto che l'ideologia concerne,
la natura differenziale dell'oggetto delle analisi strutturaliste stesse.
E' Freud invece ad avere indicato la soluzione della questione dell'ideologia,
mostrando che la ragione del sintomo è da ricercarsi al di fuori
del sintomo. Il non detto non è immanente al detto, l'inconscio non
è negli effetti di senso della coscienza. L'ermeneutica resta invece
sempre all'interno del campo del proprio oggetto. Come la psicanalisi, la
teoria marxista dell'ideologia deve così rompere con qualsiasi ermeneutica.