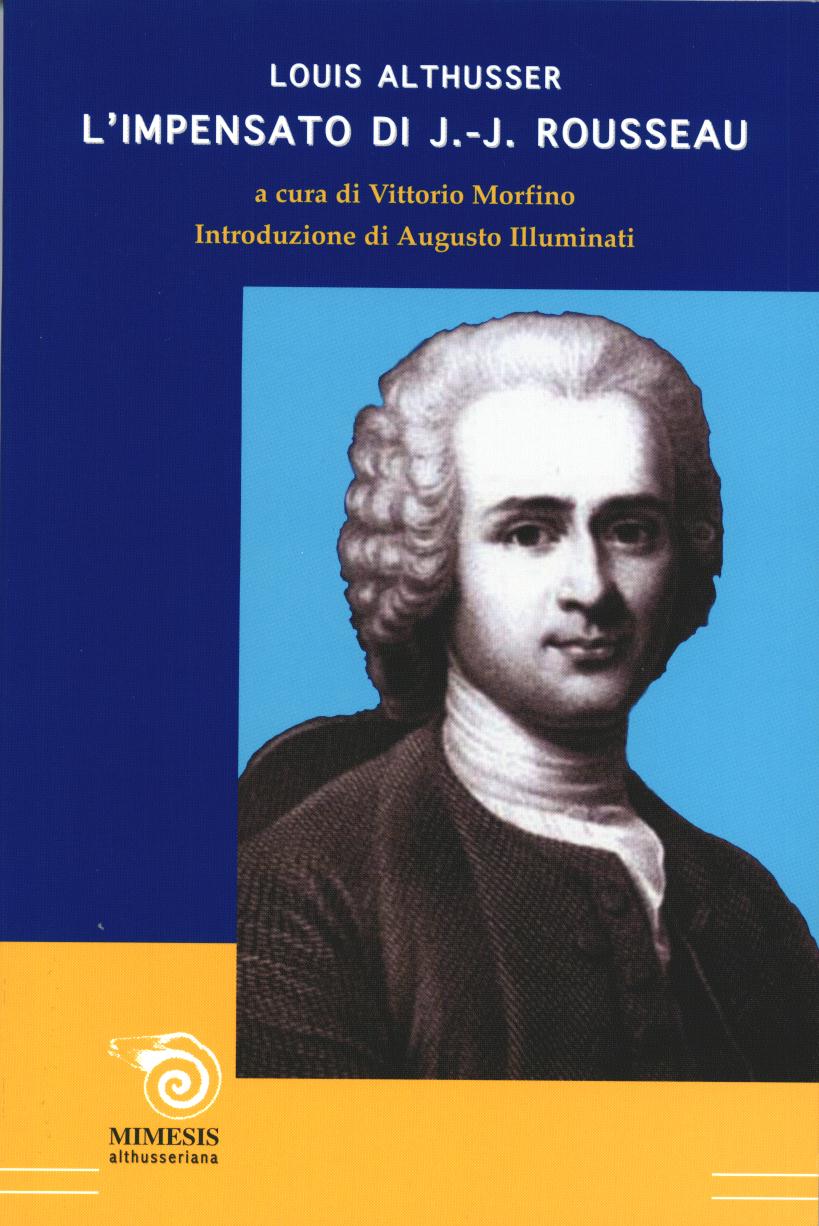
L'impensato di Jean-Jaques Rousseau
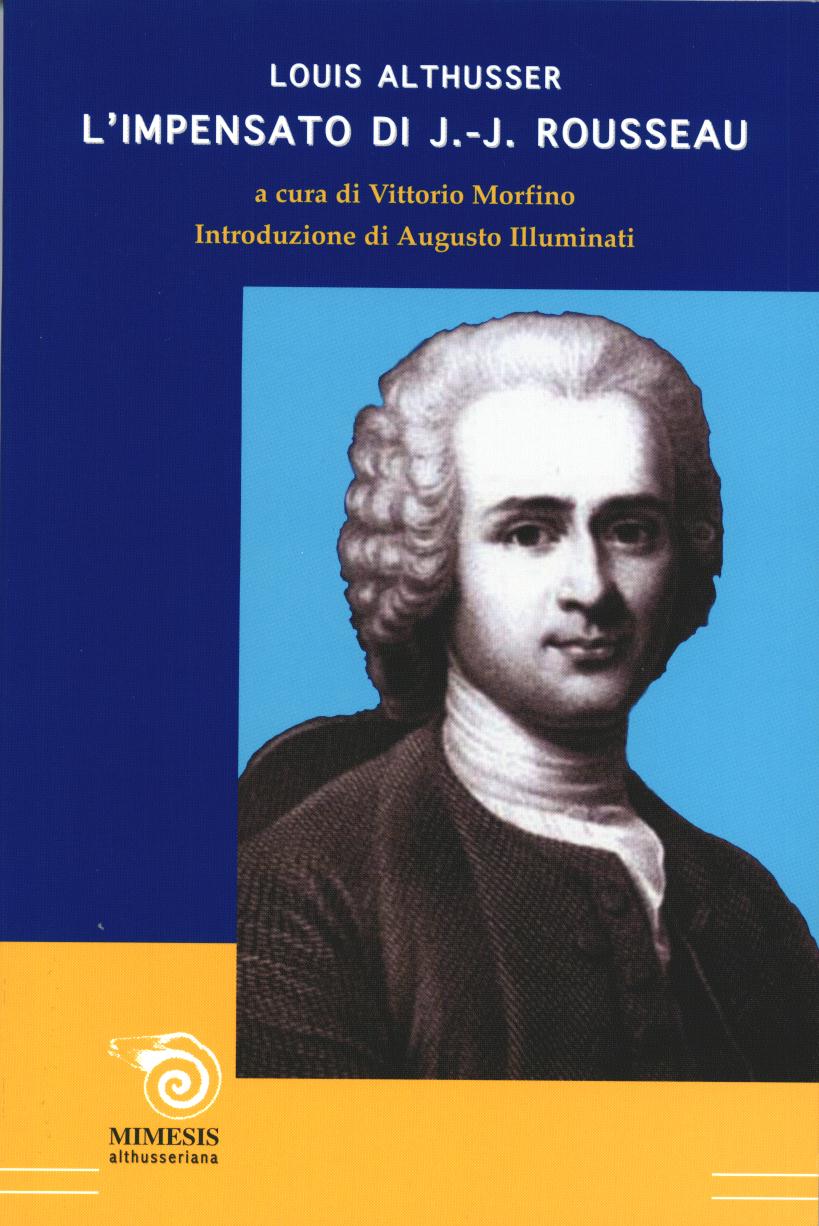 |
Louis Althusser L'impensato di Jean-Jaques Rousseau |
di Augusto Illuminati
Jean-Jacques Rousseau, la cui opera è già formalmente assai
variegata come genere (saggistica politica, antropologica e pedagogica,
romanzi, composizione musicale e musicologia, scritti autobiografici, poesie
e commedie) vive nelle sue contraddizioni interne e nell'effetto che esse
hanno prodotto sui suoi lettori. Lasciamo i più estremi - Robespierre
o Gandhi , Hölderlin o Tolstoj- e teniamoci al più freddo e
riflessivo Immanuel Kant. Nelle note marginali appuntate da partire dal
1764 sul proprio esemplare delle Osservazioni sul sentimento del bello
e sul sublime [1], egli scrive al
primo impatto: "La prima impressione che un lettore ... riceve dagli
scritti del sig. J.- J. Rousseau, è di trovarsi di fronte a una non
comune acutezza dello spirito, a un nobile slancio del genio e a un'anima
sensibile in misura tale che forse mai uno scrittore di qualsivoglia epoca
o di qualsivoglia popolo può averle possedute insieme... L'impressione
che segue è lo stupore per le opinioni singolari e contraddittorie,
che contrastano a tal punto con quanto è generalmente ammesso, che
si può nutrire il sospetto che l'autore, grazie ai suoi talenti straordinari,
abbia solo voluto dimostrare il potere magico della sua eloquenza e fare
l'eccentrico che emerge con novità accattivanti tra tutti i concorrenti
dello spirito" (43,13). Ben presto lo choc è dichiarato: "Io
stesso sono per inclinazione un ricercatore. Sento tutta la sete di conoscenza
e l'avida inquietudine di progredire in essa o anche la soddisfazione dopo
ogni conquista. C'è stato un tempo in cui credevo che solo questo
costituisse l'onore dell'umanità e disprezzavo il popolino che non
sa nulla. Rousseau mi ha rimesso a posto. Questa superiorità che
abbaglia scompare, imparo a onorare gli uomini e mi sentirei più
inutile del comune lavoratore se non ritenessi che questa considerazione
possa conferire un valore a tutte le altre per ristabilire i diritti dell'umanità"
(44,8). E' il risveglio dal sonno morale, come confermano altri passaggi
dello stesso tenore, fino alla grandiosa conclusione in termini di teodicea:
"Newton per primo ha visto l'ordine e la regolarità collegati
con una grande semplicità, laddove prima di lui si incontravano disordine
e molteplicità male accoppiati, e da allora le comete percorrono
traiettorie geometriche. Rousseau per primo ha scoperto sotto la molteplicità
delle forme assunte dall'uomo la sua natura profondamente occultata e la
legge nascosta, per cui la provvidenza dalle sue osservazioni... dopo Newton
e Rousseau, Dio è giustificato e la dottrina di Pope è vera"
(58,12). Althusser è il più recente episodio di un urto consimile
e naturalmente anche di un uso arbitrario, dal punto di vista filologico,
del retaggio russoiano. Ma tali lo sono state le interpretazioni più
innovative, comprese quelle di Hegel, Engels, Cassirer, Starobinski. Letture
d'autore, appunto.
Rousseau stesso ben sapeva, d'altronde, che l'atto stesso di scrivere lo
esponeva al fraintendimento nel momento stesso in cui esibiva i propri impulsi
contraddittori. Il primo Discorso, gesto iniziale della sua
comunicazione letteraria in cui rivelava le contraddizioni della società
moderna e insieme la criticità del rapporto dell'individuo (proprio
di Jean-Jacques) con essa, fu l'origine della fama improvvisa e delle sventure
dell'autore, cioè lo introdusse di slancio, sulla scia del successo,
in quel mondo dell'esteriorità cui pure il contenuto dell'opera prima
clamorosamente ripugnava. Nel violento, paradossale e spesso retorico pamphlet
contro le arti e la scienza Rousseau vedeva il nucleo di tutto il suo pensiero,
così come si sarebbe sviluppato nelle opere successive. Egli stesso
scriverà in una famosa lettera a Malesherbes del 12 gennaio 1762:
"se avessi potuto scrivere appena il quarto di ciò che vidi
e sentii sotto quell'albero (la cosiddetta illuminazione di Vincennes, dopo
una caduta da cavallo durante una visita a Diderot, allora detenuto in quel
castello) "con quale chiarezza avrei posto in rilievo tutte le contraddizioni
del sistema sociale, con qual forza avrei descritto tutti gli abusi delle
istituzioni, con quale semplicità avrei dimostrato che l'uomo è
naturalmente buono e che soltanto a causa delle istituzioni gli uomini diventano
malvagi". Naturalmente l'interpretazione data correntemente (e polemicamente)
dai contemporanei e anche da molti critici moderni del 1deg. Discorso
come di un rifiuto generale della cultura e della società era
erroneo. Si trattava piuttosto del rifiuto di una cultura specifica, quella
aristocratica in cui i philosophes venivano opportunisticamente a
integrarsi, una cultura dell'esteriorità e dell'utilitarismo che
lacera e nega la comunità, cui si contrappone, nelle forme retoriche
della prosopopea di Fabrizio, il mito della polis antica. È
un primo grande attacco alle istituzioni dell'Ancien Régime
e alla copertura offertagli dal riformismo moderato dei circoli illuministici,
che praticamente lo colloca all'avanguardia della polemica rivoluzionaria
settecentesca contro la diseguaglianza e al massimo ne fa un precursore
della critica alla moderna società di massa. Una valenza critica
democratica che si chiarirà bene, dopo le numerose repliche fra il
1750 e il 1752 ai detrattori e l'importante prefazione del 1753 al Narciso,
nel 2deg. Discorso, in cui i guasti della storia dell'umanità
e la corruzione stessa morale dell'uomo vengono imputate alla diseguaglianza
introdottasi nel mondo con la divisione del lavoro e l'appropriazione privata
della terra. La storia ipotetica dell'umanità scavalca qualsiasi
moralismo e si fa direttamente teoria (fintamente antropologica) della storia
e della politica. Sempre giocando sullo scarto fra paradosso e verità,
mischiando le carte tra fonti e conclusioni.
Prendiamo proprio il terreno cruciale (e allora alla moda) dello stato di
natura. Se il suo rifiuto hobbesiano (e la conseguente assunzione di una
malvagità originaria degli uomini) rimandava al pessimismo agostiniano
e valeva da vero e proprio esperimento mentale di annihilatio mundi
per giustificare l'assolutezza del potere sovrano, analogo all'onnipotenza
di Dio che ha tratto il mondo dal nulla e può rigettarvelo in ogni
momento, Rousseau riprende tale orientamento piegandolo però a un
diverso obbiettivo e tematizzando di conseguenza la socialità piuttosto
che la legalità naturale. Già nel 2 Discorso, oltre
a una critica generale del giusnaturalismo troviamo già momenti di
esplicita polemica con le classiche definizioni di Grozio, Pufendorf e Barbeyrac,
orientate anche al connesso riconoscimento della spontanea armonia degli
interessi privati e dunque a una visione non conflittuale della società.
Veniva impugnata proprio la fictio di uno stato di natura nel quale
gli esseri umani erano immaginati già pienamente razionali, liberi
ed eguali, governati da una recta ratio dettata da Dio e sufficiente
a garantire un equo sviluppo della loro istintiva socialità. In tal
modo si giustificavano surrettiziamente le presenti diseguaglianze, che
il diritto positivo si limitava a ratificare. Per il momento Rousseau si
accontenta di escludere la nozione di socialità dal diritto naturale
e correlativamente di descrivere l'uomo primitivo come vivente in condizioni
di isolamento e dispersione, senza alcun bisogno dei suoi simili se non
per fuggevoli relazioni sessuali. La stessa libertà naturale va intesa
in senso fisico-spaziale, quale solitudine, neppure ostile insocievolezza,
che è già un rapporto interpersonale seppure negativo. L'uomo
primitivo vaga muto per i boschi, senza conflitti né legami, spesso
senza alcun incontro. Da tale polemica parte la ricerca del vero stato di
natura e l'individuazione di condizioni "primitive" che non fossero
la retroproiezione e legittimazione di strutture sociali "moderne".
La metafora della statua di Glauco, cioè il riconoscimento dei tratti
originari dell'uomo sfigurati dalla storia, non è così l'usuale
ricorso a uno schema ideale composto dagli elementi più poveri e
generici dell'uomo e spacciato per sua essenza, ma un preciso rigetto degli
altri schemi vigenti, di quello giusnaturalistico ma anche della tabula
rasa lockiana e sensistica.
La doppia negazione di uno stato primitivo di guerra[2]
(Hobbes) e di una socialità naturale (Pufendorf) attraverso la definizione
della solitudine primitiva appare con particolare chiarezza in due passaggi
coordinati dell'Essai sur l'origine des langues (capitoli II e IX),
di poco anteriore o successivo al 2° Discorso:
Si pretende che gli uomini abbiano inventato la parola per esprimere i loro bisogni; questa opinione mi sembra insostenibile. L'effetto naturale dei primi bisogni fu di separare gli uomini e non di avvicinarli ... Quei tempi di barbarie erano il secolo d'oro, non perché gli uomini fossero uniti, ma perché erano separati. Ciascuno, si dice, si considerava il padrone di tutto; ciò è possibile, ma ognuno conosceva e desiderava solo ciò che aveva a portata di mano: i suoi bisogni, lungi dall'avvicinarlo ai suoi simili, lo allontanavano. Gli uomini, se si vuole, si attaccavano al momento dell'incontro, ma si incontravano raramente. Dappertutto regnava lo stato di guerra e tutta la terra era in pace[3]
Il selvaggio non ha inclinazioni spontanee alla socievolezza, non ne ha neppure bisogno nel suo stato di dispersione: essa è una creazione sociale, che non deriva necessariamente da sollecitazioni istintive. Il linguaggio (come la socialità) possiede un carattere storico-artificiale. L'istituzione sociale non è un dato immediato della natura, ma neppure privo di rapporti con essa, di cui anzi è un dono. Essa - lingua o società (che è tutt'uno) - è conseguenza differita di una disposizione primitiva. L'elemento della casualità, nel IX capitolo dell'Essai, media fra l'esistenza degli ostacoli naturali e il dispiegarsi della capacità umana di controllo sulla natura. Non nei climi di perpetua primavera, dove gli abitanti potevano fare facilmente a meno gli uni degli altri e i bisogni venivano soddisfatti senza fatica, ma nei climi più duri sorge la necessità della cooperazione e del lavoro, quindi dell'abbandono dell'isolamento:
Colui che volle che l'uomo fosse socievole, toccò col dito l'asse del globo e l'inclinò sulla faccia dell'universo. A questo leggero movimento vedo cambiare la faccia della terra e decidersi la vocazione del genere umano: odo di lontano le grida di gioia di una moltitudine insensata; vedo edificare i palazzi e le città; vedo nascere le arti, le leggi e il commercio; vedo i popoli formarsi, svilupparsi, espandersi, dissolversi, disperdersi come i flutti del mare: vedo gli uomini riuniti in qualche punto della loro dimora, per divorarsi lì reciprocamente e fare del resto del mondo un terribile deserto, degno monumento dell'unione sociale e dell'utilità delle arti[4]
Le differenze di clima e l'irregolarità dei fenomeni meteorologici
e dell'ambiente in generale sono dunque il preannuncio del funeste hasard
dell'origine della proprietà e della diseguaglianza e insieme la
molla della perfettibilità dell'uomo. Un clinamen cosmico
che introduce la casualità degli incontri e degli eventi storici.
L'autore ritorna sull'argomento in modo specifico nel II capitolo della
prima stesura del Contratto sociale, il cosiddetto Manoscritto
di Ginevra. Il capitolo, che si intitola "De la société
générale du genre humain", è una sistematica confutazione
della voce "Diritto naturale" dell'Enciclopedia, stesa
da Diderot, e forse proprio per evitare ulteriori polemiche in una fase
già di rottura venne completamente espunta dalla versione definitiva
del C. S., che si limita a conservarne implicitamente i risultati.
Sin dall'inizio si osserva acutamente che ciò che accosta gli uomini
non è (a differenza di quanto affermava Pufendorf) la conformità
di un'identica natura, bensì il profitto che si vuole ricavare dagli
altrui servizi. Lo sviluppo dei bisogni deprava gli uomini e li asservisce
mutuamente:
i nostri bisogni ci ravvicinano via via che le nostre passioni ci separano, e più diventiamo nemici dei nostri simili meno possiamo fare a meno di loro. Tali sono i primi legami della società generale; tali i fondamenti di quella fondamentale benevolenza la cui riconosciuta necessità sembra soffocare il sentimento, e di cui tutti vorrebbero raccogliere i frutti senza essere obbligati a coltivarla; infatti, quanto all'identità di natura, i suoi effetti si neutralizzano, perché rappresenta per gli uomini un motivo di disputa come un motivo di accordo, e desta tra di loro altrettanto spesso antagonismo e gelosia, o comprensione e solidarietà.
Viene qui ribadita una concezione antagonistica dell'evoluzione sociale, agli antipodi della conciliazione giusnaturalistica e della sua tranquillizzata validazione dell'esistente. Diversa invece, rispetto al 2deg. Discorso, la valutazione della perfettibilità, cioè della socialità possibile degli uomini (ricordiamo che il progresso si accompagna costantemente al loro avvicinamento stabile): senza lo sviluppo dei rapporti sociali la nostra intelligenza sarebbe restata limitata e soprattutto "non ci sarebbe stata né bontà nei nostri cuori né moralità nelle nostre azioni, e mai avremmo gustato il sentimento più delizioso dell'animo che è l'amore della virtù". La critica investe poi la concezione stessa corrente di legge naturale: riprendendo spunti già contenuti nel 2° Discorso si adduce l'inesistenza di una lingua universale a riprova dell'assenza di un disegno "naturale" per la comunicazione e l'unificazione degli uomini; anche la ragione non è affatto deputata a far riconoscere la coincidenza degli interessi particolari nel bene generale, tanto più che tali interessi si escludono reciprocamente e la fortuna dell'uno fa la disgrazia dell'altro. In ogni caso nell'uomo primitivo è assente la facoltà di generalizzazione e la razionalità della legge naturale può essere conosciuta soltanto quando lo sviluppo delle passioni la rende inoperante:
di qui si vede che il preteso contratto sociale dettato dalla natura è una vera e propria chimera; le sue prescrizioni, infatti, sono sempre o sconosciute o inattuabili, e non si può fare a meno di ignorarle o di infrangerle.
Non sono dunque i bisogni fisici o il gioco spontaneo degli interessi
a riunire gli uomini, come pensano i fautori della socievolezza naturale
o di quella che Kant chiamerà "insocievole socievolezza"
- l'antagonismo provvidenziale che sorge dalla collisione benefica delle
malvagie volontà dei singoli, radicalmente corrotti ed egoisti -
bensì un impulso che si svolge nel campo etico-teleologico. Per usare
un'espressione del Vicario savoiardo, l'uomo è "socievole per
natura, o almeno fatto per diventarlo", cioè la socievolezza
è un sentimento virtuale, innato come la ragione e che come essa
può dispiegarsi soltanto nell'ambiente sociale (cui si perviene "casualmente",
con la possibilità tanto di una degenerazione quanto di una rigenerazione).
Alla casualità della socievolezza corrisponde la corruzione acquisita
e reversibile, mentre in Kant socievolezza e corruzione sono originarie.
La sola forma di socievolezza che Rousseau ammette è quella che si
fonda sull'identità della nostra natura sensibile, alterata più
che rafforzata dall'incrocio dei bisogni artificiali e dal lavoro della
concorrenza. La reciproca dipendenza che ne risulta genera i vizi e sopprime
la libertà, così che, in alternativa, occorre cercare un sistema
politico che escluda la dipendenza personale e restituisca, a un altro livello,
l'indipendenza originaria.
La conclusione del capitolo è estremamente vigorosa e fornisce in
positivo la contropartita della negazione dell'equivoca socievolezza giusnaturalistica:
Ma benché fra gli uomini non vi sia una società naturale e generale, benché divenendo socievoli diventino anche infelici e malvagi, benché le leggi della giustizia e dell'eguaglianza non contino nulla per chi vive a un tempo nella libertà dello stato naturale e sotto il giogo dei bisogni propri della società; invece di pensare che per noi non ci sia né virtù né felicità, e che il cielo ci abbia abbandonato senza soccorso al decadimento della specie, sforziamoci dal ricavare dal male stesso la medicina che deve guarirlo. Correggiamo, se possibile, i difetti dell'associazione generale con nuove forme di associazione. Il nostro violento interlocutore cioè il méchant ipotizzato nell'articolo diderotiano, ribelle al patto sociale e che deve essere convinto non in base ad astratti princìpi razionali ma al riconoscimento del proprio interesse può giudicare i risultati da sé. Mostriamogli nell'arte condotta a perfezione il risanamento dei mali che l'arte ai suoi inizi apportò alla natura; mostriamogli tutta la miseria dello stato che credeva felice, tutta la falsità del ragionamento che credeva valido. Veda in un migliore assetto delle cose il premio delle buone azioni, il castigo di quelle cattive e l'amabile accordo della giustizia e della felicità. Illuminiamo la sua ragione di nuove conoscenze, riscaldiamo il suo cuore di nuovi sentimenti; impari a moltiplicare il suo essere e la sua felicità dividendoli coi suoi simili... che impari a preferire al suo interesse apparente il suo interesse beninteso; che divenga buono, virtuoso, sensibile, infine, e per dirla tutta, invece del feroce brigante che si proponeva di essere, il più saldo sostegno di una società ben ordinata.
Il problema, insomma, non è una mitica socialità spontanea
dell'uomo naturale, ma una corretta socializzazione dell'uomo civilizzato
mediante istituzioni artificiali e lo sviluppo della moralità e di
una cultura autentica. Dai pur combattuti giusnaturalisti di recupera l'istanza
della legge di natura (o meglio di ragione) dentro la buona socializzazione,
la socialità quale virtualità se non dato di fatto originario.
Rousseau non crede affatto alla realtà storica del contratto sociale,
ma lo considera dal punto di vista del diritto e aveva già scritto
nel 2° Discorso contro coloro che volevano stabilire il droit
mediante il fait, cioè legittimare l'esistente. È evidente
che la posizione dei giusnaturalisti non era ingenua o astorica, ma poggiava
sull'approvazione di uno stato di fatto, cui non era tanto grave sovrapporre
la fictio di un contratto tacito o esplicito. Negando la socialità
naturale il contratto non poteva essere concepito che quale patto iniquo,
macchinazione astuta, complotto dei forti, per ratificare la loro superiorità
o, viceversa, quale patto equo, uso rivoluzionario del diritto quale principio
regolativo, di universale validità regolativa: una cospirazione (rovesciata)
dei molti oppressi contro i pochi oppressori. Con letteraria solennità
l'epigrafe del Contratto sociale rimanda al mito di fondazione romano,
l'Eneide virgiliana: Foederis aequas / dicamus leges.
Il ricorso al contratto non è un residuo arcaico, ma una precisa
presa di posizione, che implica una scelta negativa (su cui torneremo subito
dopo e che costituisce l'autentico e consapevole "hobbesismo"
di Rousseau), ma opera pesantemente sullo schema di contratto. Nel passaggio
dal 2deg. Discorso al Contratto sociale viene scartato il
patto di sottomissione, mentre sussiste soltanto quello di associazione,
cioè l'esplicazione della socialità virtuale come convenzione
giuridico-rivoluzionaria, artificiale e redentrice [5].
Ha scritto felicemente Louis Althusser nel saggio su Montesquieu del 1959
[6] che "affermare che la società
umana risulta da un contratto, equivale in effetti a dichiarare propriamente
umana e artificiale l'origine di qualsiasi istituzione sociale: vale
a dire che la società non è il frutto di un'istituzione divina
né da un ordine naturale. Significa dunque innanzi tutto rigettare
un'idea antica del fondamento dell'ordine sociale e proporne una nuova".
La novità è diretta non solo contro i teorici del diritto
divino, generalmente al servizio dell'ordine costituito, ma soprattutto
contro i fautori del carattere immediato, non-artificiale della società,
"quanti pensano i rapporti umani disegnati in anticipo in una natura
che è la mera proiezione dell'ordine sociale esistente, in una natura
che vede gli uomini già in partenza iscritti in ordini e stati.
Per dirla in breve, la teoria del contratto sociale rovescia in generale
le convinzioni caratteristiche dell'ordinamento feudale, la credenza
nell'ineguaglianza "naturale" degli uomini e nella necessità
degli ordini e degli stati. E sostituisce con un contratto tra uguali,
con un'opera dell'arte umana, ciò che i teorici feudali attribuivano
alla "natura" e alla socievolezza naturale dell'uomo. A
questo punto costituisce un criterio distintivo generalmente affidabile
quello che nella dottrina della socievolezza naturale o dell'istinto
di società riconosce una teoria d'ispirazione feudale e, per contro,
nella dottrina del contratto sociale -anche quando sia al servizio della
monarchia assoluta (come per esempio in Hobbes)- una teoria d' ispirazione
"borghese"". In una certa misura, quindi, ogni teoria
del contratto contiene un elemento polemico e rivendicativo contro l'ordine
esistente. Nella misura -s'intende- in cui non spaccia per naturalmente
eterni i rapporti esistenti, di proprietà o di potere. Il rifiuto
di una concezione essenzialistica dell'uomo (buono e socievole per i giusnaturalisti,
malvagio e conflittuale per Hobbes, socievole e simultaneamente insocievole
più tardi per Kant) serve a distruggere ogni legittimazione giuridica
della feudalità. Inevitabile anche la soppressione del patto di sottomissione,
che secolarizzava (sia pure per convenzione) l'antica obbedienza divina.
Perché, tuttavia, mantenere la forma del contratto? Non c'era alternativa?
L'esempio di Spinoza ci dice il contrario. Tolti alcuni accenni nel Tractatus
theologico-politicus, il termine stesso sparisce nell'opera successiva.
Non è un caso, perché la dottrina spinoziana della potenza
e della cooperazione come estensione di essa mediante la combinazione degli
individui in complessi superiori rende superflui alienazione e patto per
costruire il collettivo: "il collettivo e lo stato vengono costituendosi
sullo sviluppo delle potenze" e dunque non v'è "genesi
giuridica del potere, ma solo sua genealogia democratica" [7]. Negando i presupposti del giusnaturalismo
-individualismo e contrattualismo- e fondando la società sul conatus
mediato dalle passioni reciproche e dalla ragione, Spinoza rifiuta ogni
trascendenza del potere e introduce l'ateismo in politica. La mossa russoiana
tiene conto (anche nei dettagli del sistema di governo, non a livello di
legislazione universalistica) del contributo spinoziano, ma se ne demarca
nettamente, trovando un'altra posizione di confronto con Hobbes, contrapponendosi
clamorosamente e tuttavia, non per paradosso, proclamando l'affinità
fra democrazia integrale e "lo hobbesismo più completo",
una volta riferiti tutti gli attributi della sovranità all'assemblea
popolare invece che a un principe (lettera a Mirabeau del 26 luglio 1767).
Primo dato fondamentale la riformulazione positiva del popolo, cioè
il mito hobbesiano dell'ordine e dell'unità del sovrano contrapposto
alla dispersione anarchica delle moltitudine, reinterpretandolo però
non secondo la tradizione monarchica autocratica bensì in versione
repubblicana assembleare. Solo così poteva affermarsi l'ordine nuovo
borghese, opponendo -senza mutarne il segno unitario e totalizzante- al
populus-rex del De cive la sovranità popolare del Contrat
social e in tal modo e ben più efficacemente esorcizzando lo
spettro spinoziano dell'incomprimibile multitudo e l'elogio machiavelliano
della produttività delle contese civili. Solo l'alienazione totale
per contratto può rimediare all'alienazione universale delle guerra
di tutti contro tutti. Cambia la natura del patto, ma resta il patto, il
deferimento (sia pure autoreferenziale) del potere, immanente al tutto ma
non più al singolo, dunque sganciato dall'impulso vitale. Il corpo
sociale non ha più a che fare con quello individuale, con la carne,
anzi con il visibile tout court. Infatti nulla è più
distante dall'unanimismo russoiano che la libera moltitudine di Spinoza,
anche se essa ducitur quasi una mente. Nel primo caso urge il mito
della trasparenza e l'orrore delle mediazioni, nel secondo domina la consapevolezza
dell'opacità dell'immediato e della necessità dell'apparire,
di una faticosa mescolanza di razionalizzazione e confronto pubblico di
istanze immaginarie. A rischio di cadere nell'utopia della democrazia diretta
assembleare, Rousseau pone invece le basi di un diritto irresistibile della
volonté générale, che deve reprimere
la volontà moltitudinaria (volonté de tous), cioè
le singolarità reali, la sfera degli affetti e dei conflitti. Vecchio
assioma platonico. Qui è illuminante la sua diffidenza patologica
verso la potenza incontrollabile della natura (tradizionalmente esemplificata
dal corpo femminile e dalle sue passioni) e si capisce perché venga
richiesto il suo sacrificio -equivalente fisico del divieto giuridico delle
coalizioni parziali entro il corpo sovrano. L'enfasi stessa posta sulla
volontà tradisce il terrore delle passioni, del loro libero gioco
(che pure l'affascina e lo travolge). Altro esorcismo, il rigetto della
"falsità" dello spettacolo nella Lettre à d'Alembert[8], pur giustificabile in polemica con
la rappresentazione feudale e barocca del potere, va contestualmente a parare
nell'incubo translucido dell'autoreferenzialità del popolo in festa,
che è insieme attore e spettatore, sovrano e suddito. Il visionario
architetto Boullée la illustrerà nei suoi progetti di un circo
per le riunioni popolari, colossale Panoptikon dove ognuno può vedere
gli altri ed esserne visto. David, più sobrio, allestirà scenografie
di massa per le cerimonie rivoluzionarie, usando i fondali già esistenti
della città. Il parsimonioso Jean-Jacques avrebbe approvato...
Pertanto, contratto equo, popolo costituito in volontà generale e
compattezza fisica della stessa, primato dell'essere (come volontà)
sull'apparire, del corpo sovrano sul corpo passionale fanno tutt'uno. I
giacobini, da bravi realizzatori borghesi dell'utopia, lo capirono benissimo
e, con la legge Le Chapelier del 14 giugno 1791, vietarono qualsiasi forma
di organizzazione sindacale, richiamando testualmente Rousseau e affermando
che
Senza dubbio deve essere permesso a tutti i cittadini di radunarsi; ma non deve essere permesso ai cittadini di certe professioni di radunarsi per i loro pretesi interessi comuni. Non ci sono più corporazioni nello stato; non c'è più che l'interesse particolare di ogni singolo e l'interesse generale. Non è permesso a nessuno ispirare ai cittadini un interesse intermedio, separarli dalla cosa pubblica con spirito corporativo... Occorre dunque risalire al principio, per cui il salario operaio è affidato alle libere convenzioni, da individuo a individuo... In una nazione libera i salari devono essere sufficienti affinché colui che li riceve sia fuori di quella dipendenza assoluta che produce la privazione dei bisogni di prima necessità e poco si discosta dalla schiavitù[9].
L'omaggio formale alla mediocrità delle fortune e alla necessità morale di evitare un'eccessiva dipendenza di un uomo dall'altro rinvia al passato, ma la repressione anti-sindacale giustificata in nome della sovranità popolare e della lotta al corporativismo anticipa discorsi di risaputa attualità.
Nel saggio del 1967, qui di seguito tradotto, Althusser affronta direttamente
le tematiche del C.S., con una complessa definizione dei successivi
scarti teorici (décalages) che l'articolano per contraddizioni,
rimozioni e spostamenti [10]. Alienazione
(generale) contro alienazione, costituzione di una delle parti contraenti
(il popolo-comunità) nel contratto, senza che gli sia anteriore,
il rifiuto di un terzo garante del patto (ovvero l'interiorizzazione dell'alienazione),
la restituzione come libertà dei diritti ceduti, la definizione dell'interesse
generale come interesse del corpo comunitario (speculare a quello particolare
come amour propre del singolo), infine l'inconcludente dialettica
fra volonté générale e volonté de
tous. Questa è risolubile soltanto assumendo l'interesse sotto
un profilo moralistico e offrendo un supporto etico-ideologico al formalismo
giuridico. Scrive Althusser: "fuga in avanti nell'ideologia come solo
mezzo per proteggere la volontà particolare dal contagio degli interessi
detti particolari, cioè sociali dei famosi gruppi intermedi. Fuga
in avanti che non ha termine. La soluzione ideologica, la chiave di volta
che sostiene nel cielo tutto il sesto politico, ha bisogno del cielo. Niente
è più fragile del cielo" (ovviamente il marxiano cielo
della politica). Quindi costumi, educazione, feste, orientamento (condizionamento)
dell'opinione, religione civile. Ma non basta. Occorre anche una
pratica per la soppressione delle classi: la soluzione è "una
regressione economica verso uno dei fenomeni di dissoluzione del modo di
produzione feudale: il piccolo produttore indipendente, l'artigianato urbano
o rurale, ciò che il 2deg. Discorso descrive sotto il concetto
di "commercio indipendente" (indipendenza economica universale
che permette un "libero" commercio, cioè libere relazioni
fra gli individui). Ma a quale santo votarsi per ottenere questa impossibile
riforma economica regressiva? Resta solo la predicazione morale, cioè
l'azione ideologica". Scacco interno del C.S. e simultaneo transfert
nell'immaginazione letteraria: il romanzo sentimentale e quello pedagogico,
l'autobiografia più o meno immaginaria delle Confessioni,
il lirismo delle Passeggiate, la monologante teatralità dei
Dialoghi. Non vi mancheranno religione, magia e sogni.
Rousseau ha appunto la sostanziale onestà di prevedere lo scacco
(almeno sul piano privato e pedagogico) del meccanismo di controllo del
concreto per mezzo dell'astratto, tanto esaltato nella teoria politica.
Per scongiurarlo dentro quest'ultima deve ricorrere a mezzi sovrannaturali,
che esorbitano dalla sfera giuridica e anzi la fondano in termini carismatici.
La figura mitica del Legislatore, che rappresenta graficamente l'impossibilità
di istituire l'unità del popolo in termini razionali, eredita una
lunga tradizione di platonismo politico, antico e medievale, soprattutto
arabo, che aveva conferito un'aura sacrale al filosofo-re [11].
Solo nell'apparato delle varianti al saggio del 1967 (cioè negli
appunti registrati del corso universitario del 1965-1966) Althusser aveva
affrontato tale figura ("che viva tutte le passioni degli uomini e
non ne provi alcuna, che non avesse alcun rapporto con la nostra natura
e la conoscesse a fondo", come la sua controparte romanzesca, il Wolmar
della Nouvelle Héloïse), solo che stranamente non la
considera in relazione al meccanismo del patto e allo schiacciamento della
calda singolarità moltitudinaria nella fredda unità del popolo,
bensì come la chiave di volta (sempre aporetica) di un altro piano
di discorso: quello della teoria della storia, del tempo storico del contratto,
cioè delle circostanze della sua irruzione (casuale, miracolistica)
nel mondo degenerato per un funeste hasard. Casualità temporale
e geografica, perché non tutti i paesi sono adatti per far germogliare
il miracolo, che rompe il cerchio apparente della necessità diseguagliante
restaurando l'eguaglianza. Il Legislatore deve anticipare rispetto
alla storia degli uomini, dando loro leggi che produrranno lo spirito sociale
necessario per produrre queste stesse leggi...Un circolo vizioso che richiede
un fondatore dall'esterno per trasformarsi in circolo virtuoso. Alla personalità
del legislatore si accompagna la funzione della religione, che (un
po' come l'obbedienza ai profeti nel TTP spinoziano) fornisce agli
uomini uno spirito sociale prima delle leggi che poi lo stabilizzeranno
e razionalizzeranno. Il Legislatore è una specie di Dio e deve invocare
Dio per farsi intendere dagli uomini. La concezione politica di Rousseau
-conclude Althusser 1965- è "temperata" dalla concezione
della storia, meglio: la sua ideologia della politica è temperata
dal suo concetto di storia, facendo intervenire (sotto specie di miracolo)
la coscienza della precarietà dell'ideologia politica e della storia,
ovvero la coscienza acuta della storia della sua precarietà.
Fin qui, potremmo commentare, il Legislatore introduce un elemento estraneo
nel rigido meccanismo giuridico autoreferenziale: il passo indietro nel
mito (dopo tutto la più confortevole incarnazione della figura sarà
il Sarastro della Zauberflöte mozartiana, l'inappariscente manipolatore
dei destini umani, così prossimo alle fantasticherie russoiane di
onnipotenza), il passo avanti verso la storia, come ben presto si realizzerà
nella congiunzione di istituzioni democratiche (ma rappresentative) e di
una leadership autoritaria nel Comitato di Salute Pubblica del Terrore e
poi nella dittatura imperiale di Napoleone. Potere costituente e magia,
Sieyès e Mesmer -i due esiti complementari di una contraddizione
insolubile, dell'impossibile ordine unificato della sovranità moderna.
Potremmo così ben spiegare anche il "realismo" russoiano,
che non traspare soltanto, nei progetti di costituzione per la Corsica e
per la Polonia, ma è ben presente nei meno frequentati capitoli dei
libri II e III del C.S., dedicati alle forme concrete di governo
più che alla statuizione universalistica della legge, laddove è
al massimo evidente l'aderenza alle condizioni politiche, geografiche e
perfino climatiche dei vari paesi e popoli. Non solo la nota convinzione
che una riforma sia possibile soltanto in paesi di mediocre e distribuita
ricchezza, scarsa popolazione e difficoltà esterne e interne di comunicazione,
ma il carattere intermedio del governo ("commisssione" revocabile
del legislativo e autore di decreti sui casi particolari) fra il cittadino-sovrano,
tutto preso della generalità cieca della legge, e il cittadino-suddito,
intrinsecamente incapace di occuparsi universalmente di casi particolari.
L'amministrazione governativa è il medio proporzionale adattato alle
diverse condizioni storiche, che meglio garantisca la prosperità
di un paese, misurato in base al benessere distribuito della popolazione
e non alle punte artistiche e scientifiche. Il governo deve essere tanto
più forte e ristretto (al limite anche un re, elettivo e non ereditario)
quanto maggiore è il numero dei sudditi, ma è sempre traversato
da una dialettica interna fra tre volontà diverse: l'interesse personale,
lo spirito di corpo dell'organo cui appartiene, la volontà generale
da cui promana. In una legislazione perfetta il primo elemento dovrebbe
essere nullo, il secondo molto subordinato, il terzo dominante. La realtà
tende a rovesciare quest'ordine. Un governo monocratico è estremamente
efficiente perché riunisce l'interesse particolare e quello di corpo
in un'unica volontà, mentre un governo assembleare dissolve la volontà
di corpo in quella generale, lasciando fluttuare liberamente gli interessi
personali dei magistrati. Tutto il discorso riguarda l'efficienza dell'azione
governativa, mentre la rettitudine della medesima è meglio garantita
dalla pluralità dei magistrati e della loro quasi dissoluzione nella
volontà generale. Un buon governo dovrebbe saper mediare fra le due
contrastanti esigenze, dato che una perfetta democrazia si addice più
agli Dei che agli uomini, tanto che essa "non è mai esistita
né esisterà mai. È contro l'ordine naturale delle cose
che la maggioranza governi e la minoranza sia governata" (III 4). Ancor
meno nella società borghese, dove non ci sono più schiavi
e ognuno si occupa prioritariamente dei propri affari e non in continuazione
di quelli pubblici. La sfera privata è, anzi, tutelata dalla flessibilità
del governo e tenuta in riserva per la fuga dalla società politica.
Siamo a Ginevra e a Parigi, mica a Sparta! Sono recuperate o meglio tollerate
di fatto le singolarità e le differenze storiche, ma non riconosciute
istituzionalmente (a parte la possibilità sempre latente dell'autoesilio).
Resta la divergenza originaria con Spinoza!
Il passo decisivo dell'interpretazione althusseriana si compie nelle pagine
dedicate a Rousseau nel saggio del 1982, La corrente sotterranea del
materialismo dell'incontro [12].
Ora i passi già ricordati del 2° Discorso dell'Essai
sono presi a testimoni di uno stato senza alcuna relazione sociale positiva
o negativa, la foresta primitiva popolata da individui senza incontro,
corrispettivo del vuoto epicureo nel quale cade la pioggia parallela degli
atomi. Un niente di società anteriore e condizione di possibilità
per ogni società, audace teorizzazione della produttività
del vuoto[13]. Il contatto sociale vi
si impone con la casualità di una catastrofe, stabilizzata dalla
ripetizione temporale che crea una natura umana socializzata per accumulazione
di passioni, commerci amorosi, atti linguistici, conflitti. Accoppiamento
di perfettibilità e pietà, società come difetto, carenza,
che non fonderà mai alcuna essenza umana, ma solo la perpetua apertura
all'incontro, a quella "presa" dell'aleatorio che è la
storia, almeno quella riuscita. Contingenza della necessità e necessità
della contingenza, senza Origine né Fine, in un'area abbastanza prossima
a quella di Machiavelli e Spinoza. Althusser, al contrario di Negri, non
fissa due linee alternative (Machiavelli-Spinoza-Marx versus Hobbes-Rousseau-Hegel),
tendendo piuttosto a ritrovare il politico moderno in ogni vicenda congiuntura
e incontro, compresa la guerra di tutti contro tutti e la lotta per il riconoscimento.
Certamente nel contratto russoiano, ancorato sull'abisso del nulla, che
deve "aggiustare una forma illegittima (la corrente) in forma legittima",
antiteleologia della storia che vi irromperà praticamente con la
Rivoluzione francese, fine anticipata di una storia della necessità
e precondizione di ogni autentica teoria della storia come incontro e scontro
di essenze singolari, individuali e collettive: persone, stati, partiti,
classi.
Il risvolto è la possibilità, soggiacente a ogni impegno pedagogico
e politico, di rifluire nella solitudine e nel silenzio di un contatto immediato
con la natura: esito biografico dell'autore, sempre in bilico fra Città
virtuosa e Regime del solitario, appunto, via d'uscita esodale anche per
altri in seguito -dalla nazione, dalla società fordista, dalla comunità
totalitaria. Singolarità e passione sono la riserva fuori dalla sfera
politica, l'altro dalla socializzazione, il privilegio incancellabile garantito
non dal contratto, ma dalla base vuota di esso, dal niente di società
sottostante all'innaturale socialità. Polarità tuttora suggestiva,
ma inadeguata, almeno in quei termini, per la moltitudine postfordista,
cui è venuta meno la divisione fra sfera pubblica e privata e si
pone piuttosto il compito di sopprimere lo sfruttamento diretto delle sue
facoltà linguistiche e relazionali, sorgente di ogni politicità
e produttività. L'unificazione nella volontà comune trascendente
e la soppressione forzata delle differenze non è più necessaria
(tanto meno auspicabile) laddove il comune è già dato, immanente
a ogni singolarità. Il pieno possibile che risponde, senza saturarlo,
al vuoto althusseriano.