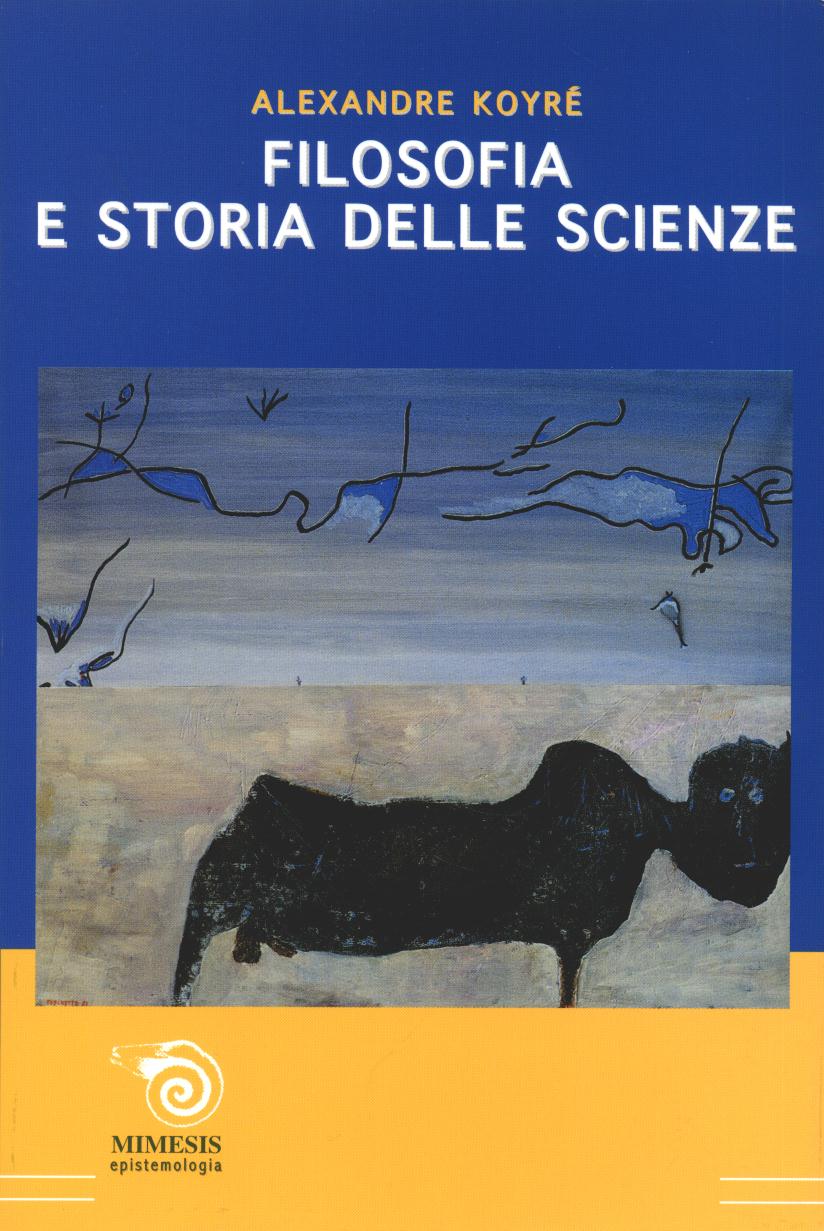 |
Alexandre Koyré Filosofia e Storia delle Scienze |
Scienza e Realtà
Lettura di Koyré
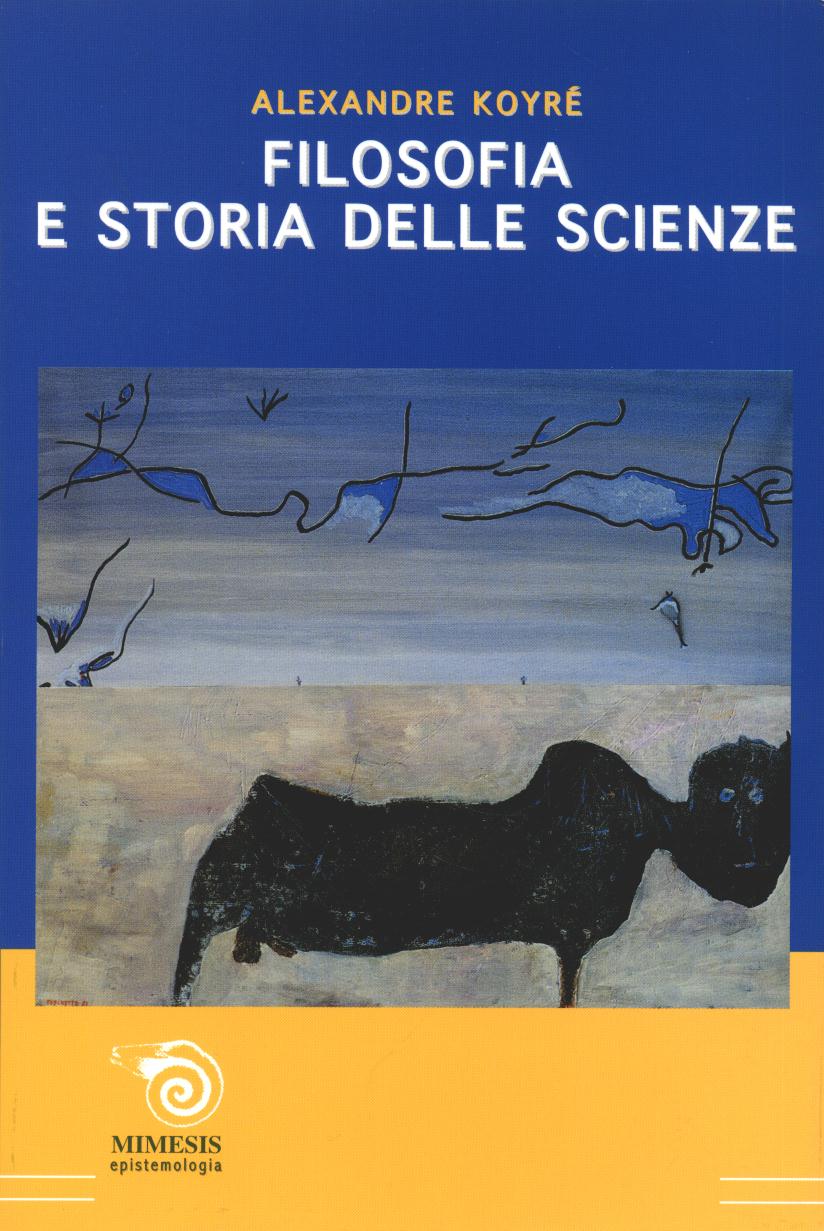 |
Alexandre Koyré Filosofia e Storia delle Scienze |
Scienza e Realtà
Lettura di Koyré
I pianetini di Giove sembrano irradiare un ultimo bagliore di Rinascimento neoplatonico,
come ignari che l'ordine impassibile delle sfere celesti si è dissolto, proprio per opera del suo scopritore
Italo Calvino
Anche la splendida prosa galileiana è luce di tramonto e noi sappiamo oggi
che la verità del tempo che sopravveniva era piuttosto nella disperata congestione della prosa di un Bruno
Franco Fortini
1)Perché è importante Giordano Bruno?
È noto che l'opera storiografica di Alexandre Koyré è
incentrata sulla rivoluzione scientifica in astronomia e fisica, ed altresì
è noto che le sue ricerche in genere mirano a rilevare le influenze
esercitate sulle concezioni ed il lavoro dei grandi protagonisti di quella
rivoluzione dalle idee filosofiche (il neopitagorismo per l'astronomia eliocentrica
di Copernico e Keplero, il teismo per la cosmologia newtoniana, il platonismo
in generale per la considerazione matematizzante della natura). Tuttavia,
non è a questa relazione che si limitano i legami tra le scienze
moderne (in specie nella loro fase aurorale) ed il mondo delle restanti
rappresentazione umane. Nell'opera di Koyré possiamo individuare
implicazioni della rivoluzione scientifica che non coincidono con il ruolo
matriciale esercitato sulle scoperte, sulla posizione dei problemi e sulle
proposte di soluzione, dagli spazi di visibilità offerti dalle filosofie
circolanti in modo più o meno elaborato nelle epoche e nelle "culture".Queste
ulteriori implicazioni emergono in primo luogo dall'ambigua valutazione
della figura di Giordano Bruno contenuta in Dal mondo chiuso all'universo
infinito[1].
Questo libro approfondisce il tentativo, già condotto nelle Ètudes
galiléennes, <<di definire i modelli strutturali della
nuova e dell'antica concezione del mondo e di determinare i mutamenti introdotti
dalla rivoluzione del XVII secolo. Questi mi sembravano riducibili a due
azioni fondamentali e strettamente connesse, che caratterizzavo come distruzione
del cosmo e geometrizzazione dello spazio, cioè la sostituzione della
concezione del mondo come un tutto finito e ben ordinato, la cui struttura
spaziale incorporava una gerarchia di perfezione e valore, con quella di
un universo indefinito, od anche infinito, non più unito da una subordinazione
naturale, ma unificato soltanto dall'identità delle sue leggi e delle
sue componenti ultime e fondamentali; nonché la sostituzione della
concezione aristotelica dello spazio -insieme differenziato di luoghi naturali-
con quella della geometria euclidea -mera estensione infinita ed omogenea
-da quel momento considerata identica allo spazio reale del mondo>>[2]. Siamo già, in queste poche righe,
prossimi a quello che cerchiamo di mettere in luce. Ma per riuscirvi dobbiamo
ritornare a queste affermazioni di Koyrè dopo aver tentato
di rispondere alla domanda: perché è importante Giordano Bruno?
Koyré parla in questi termini del Nolano: <<Giordano Bruno,
mi spiace dirlo, non è un filosofo molto buono (...) come scienziato
egli è mediocre, non capisce la matematica (...) la concezione bruniana
del mondo è vitalistica e magica (...) Bruno non è affatto
uno spirito moderno. Tuttavia, la sua concezione è tanto possente
e profetica, tanto sensata e poetica, che non possiamo che ammirarla, insieme
con il suo Autore. Ed essa ha influenzato così profondamente -almeno
nei suoi tratti formali-la scienza e la filosofia moderne, che non possiamo
non assegnare a Bruno un posto importantissimo nella storia dello spirito
umano>>[3]. La "concezione"
bruniana di cui parla Koyré è ovviamente quella di un universo
infinitamente infinito, privo di confini ed infinitamente ricco e vario
in ogni singolo punto, vertiginoso profluvio di possibilità che,
per assenza di una gerarchia tale da imporre distribuzioni diseguali alle
cose, sono tutte presenti ovunque allo stesso titolo. Come si vede, in Bruno
troviamo appunto la concezione di un mondo infinito ed agerarchico che in
esordio Koyrè associava alla rivoluzione scientifica. Ma questa concezione
di Bruno è irrimediabilmente non-scientifica. E d'altronde non la
si può salvare nemmeno facendone lo sfondo non-scientifico di qualche
scoperta scientifica, ché i contemporanei autenticamente sciéntifiques
non saranno influenzati da Bruno. Peraltro, come spiega Koyré,
proprio Copernico e Keplero si riveleranno fautori di un universo finito.
Dunque Bruno non "influì" né sulle scoperte né
sulle filosofie degli scienziati "veri" della sua epoca. Non fu
né scienziato né "mago" o filosofo arcaico tuttavia
condotto dall'astuzia della ragione a suggerire vie e percorsi agli "spiriti
moderni". Eppure, non possiamo che ritenerlo -con lo stesso Koyré-
protagonista d'eccezione della rivoluzione scientifica. Perché? In
cosa lo fu?
A quanto pare, lo fu proprio come elaboratore di quella "concezione
del mondo"[4] che per Koyré
è sorta dalla rivoluzione scientifica: l'universo infinito, senza
centro né principii gerarchici. Ma tale concezione è legata
alla scienza in modo diverso da come lo fu la concezione pitagorica di Copernico.
Quest'ultima è valutata da Koyré in funzione della scienza,
del sorgere di un'impresa scientifica. Questo non vale per ciò che
trova espressione nella filosofia di Bruno: qui è la pratica scientifica
ad essere compresa in funzione dell'idea dell'universo infinito, in quanto
cioè stimolo alla costruzione di un'idea extra-o meta-scientifica
dei rapporti tra l'uomo e il mondo, tra il pensiero e la realtà.
Questa "idea", il suo statuto, è incommensurabile con quello
di qualsivoglia filosofia religione o Weltanschauung destinata a
giocare un ruolo di ostacolo o agevolazione del lavoro scientifico. Essa
piuttosto estrapola dalle scienze elementi che userà in un gioco
ben differente da quello intrascientifico. Dobbiamo ora definire meglio
questo "gioco". Lo faremo non prima di un lungo détour.
2) Scienze e Concezioni del Mondo
Definire "la scienza" è un'impresa disperata, e forse
nemmeno desiderabile. L'approccio più consigliabile ai suoi "misteri"
sembra essere quello di lavorare su esempi paradigmatici e cercare di illustrarne
il funzionamento (o, se si preferisce un termine meno "ingegneristico",
la razionalità immanente). Qualcosa come "la scienza" appare
interrogabile solo attraverso lo smontaggio di esperimenti, teorie, leggi,
difficilmente riconducibili ad unità, cioè difficilmente considerabili
in termini di specie di un unico genere sommo, ma piuttosto come paradigmi
di realizzazioni particolari di un telos ideale: la ragione scientifica,
appunto.
Secondo Louis Althusser questi procedimenti eterogenei che compongono le
scienze (irriducibili al genere sommo della Scienza) non mancano, seppure
al livello "regionale" che comunque è la loro dimensione
propria, di un momento riflessivo: la filosofia spontanea degli scienziati:
<<Le F.S.S. verte solamente sulle idee ("coscienti" o no)
che gli scienziati si fanno della pratica scientifica delle scienze>>[5]. Questa filosofia spontanea è "composta"
di due elementi, in reciproco conflitto. Innanzitutto: <<un elemento
di origine interna "intrascientifico", che chiameremo ELEMENTO
I. Nella sua forma più "diffusa", questo Elemento rappresenta
"convinzioni" o "credenze" sorte dall'esperienza della
stessa pratica scientifica, immediata e quotidiana: "spontanea"
(...) Queste convinzioni sono di carattere materialista ed oggettivista.
Possono essere scomposte come segue: 1) credenza nell'esistenza reale, esterna
e materiale dell'oggetto della conoscenza scientifica; 2) credenza
nell'esistenza e nell'oggettività delle conoscenze scientifiche
che offrono la conoscenza di questo oggetto; 3) credenza nella giustezza
e nell'efficacia delle procedure della sperimentazione scientifica, o metodo
scientifico, capace di produrre conoscenze scientifiche. Ciò
che caratterizza il corpo di queste convinzioni-tesi consiste nel fatto
che esse non danno spazio a quel "dubbio" filosofico che mette
in questione la validità della pratica scientifica, scartando (...)
la questione dei titoli di diritto dell'esistenza dell'oggetto conosciuto,
della sua conoscenza, e del metodo scientifico>>[6].
L'elemento II antitetico a tutto questo consiste, si sa, in domande extrascientifiche,
che pongono alle scienze problemi di diritto per rispondervi conformemente
ad ideologie religiose o morali, sottomettendo le scienze a istanze extrascientifiche.
Questo elemento risponde alle direttive impartite dalle "concezioni
del mondo extrascientifiche" degli scienziati: <<Una concezione
del mondo è centrata su una cosa diversa dalle scienze, su ciò
che abbiamo chiamato i valori delle ]ideologie pratiche. Una concezione
del mondo esprime le tendenze che attraversano le ideologie pratiche (religiosa,
giuridica, politica, ecc.) (...) Ogni C.D.M. esprime infine una certa tendenza
di carattere o di orientamento politico>>[7].
Si noti che la difesa dell'autonomia delle scienze da parte di Althusser
è un capolavoro di astuzia teoretica. Egli nega semplicemente che
alle scienze si possa sensatamente applicare un dubbio iperbolico che ne
cancelli l'effettualità allo scopo di ricostruirla conformemente
a criteri di garanzia tali da soddisfare il dubbio stesso. In realtà,
questo dubbio è sempre suscitato da esigenze extrascientifiche, cioè
dalle "concezioni del mondo", che invocano le scienze -con il
pretesto di garantirne la validità- a garanzia di alcune posizioni
pratiche. Perché è così sicuro che il dubbio
sulla validità delle scienze non sia mai un dubbio intrascientifico?
Semplicemente, perché nell'ottica del lavoro scientifico, non ha
alcun senso porre un simile dubbio. Negli aforismi di Della Certezza
Wittgenstein afferma che ha senso dubitare solo di ciò per cui dispongo
di una regola che mi consenta di togliermi il dubbio. Non so se il teorema
di Pitagora è vero: allora lo dimostro e sono soddisfatto. Ma non
posso mai dubitare di ciò che fonda le soluzioni dei miei dubbi:
<<Le questioni, che poniamo, e il nostro dubbio, riposano
su questo: che certe proposizioni sono esenti da dubbio (fa parte della
logica delle nostre ricerche scientifiche, che di fatto certe cose
non vengano messe in dubbio>>[8].
In altri termini, il dubbio iperbolico, quale preludio ad una fondazione
assoluta, cioè a sua volta infondata, del sapere, è una costruzione
meramente verbale, ma di fatto ineseguibile: <<Lo stesso giuoco del
dubitare presuppone già la certezza>>[9],
e cioè presuppone quelle credenze esenti da dubbio che formano l'impalcatura
che regge, o i perni su cui ruotano, le nostre ricerche quando mettiamo
in dubbio qualcosa e cerchiamo di accertare come stanno le cose.
Tornando ad Althusser, si vede subito qual è il nocciolo (non importa
se "cosciente") della sua tesi: la validità dei metodi,
l'esistenza degli oggetti, la solidità delle conoscenze, sono i perni
su cui ruota la pratica scientifica. Uno scienziato può certo mettere
in dubbio che esista una tale entità, che un dato metodo sia adeguato,
che certe conoscenze non siano erronee: ma non può mettere in dubbio
per "fondarla" l'intera pratica scientifica; chi dicesse: "dubito
di tutta l'articolazione del lavoro scientifico" direbbe qualcosa del
tipo: "non so se la Terra esisteva prima che io nascessi". Chi
dichiarasse di non sapere questo, evidentemente starebbe scherzando, oppure
i suoi giochi linguistici non sarebbero tali da essere compresi dall'interno
dei nostri. Così per chi mettesse in dubbio tutto il sapere
scientifico: crederemmo di capire il senso delle sue parole, ma in realtà
non potremmo fare alcun uso di un simile dubbio. Infatti, se io dubito di
un risultato scientifico, cosa faccio? Rivedo i calcoli, ripercorro i ragionamenti,
invento degli esperimenti, ecc. E queste azioni[10]
presuppongono qualcosa, che può essere compendiata nelle tre "convinzioni"
relative all'oggetto, ai metodi, ed alle conoscenze citate da Althusser,
convinzioni che fondano ogni domanda posta a risultati specifici. La F.S.S.
è quindi la cornice dei discorsi scientifici in quanto è
imbricata in quella Lebensform che è la pratica scientifica.
Ogni domanda o dubbio che pretenda di attingere ad un livello più
profondo di fondazione in realtà si regge sul vuoto, e nasconde (in
quel vuoto, che in verità è appunto "pieno") interessi
extrascientifici.
Ma a questo punto ci si può chiedere: il rapporto delle scienze con
le pratiche extrascientifiche è solo questo? Dopotutto, se
volessimo dare una lectio facilior di queste posizioni dovremmo concluderne,
in modo un po' deprimente, che l'unico discorso non direttamente scientifico
ma al tempo stesso legittimo dal punto di vista della scienza stessa, è
il commento alla F.S.S. ed alle sue presupposizioni. Oltre alla scienza,
e in rapporti non illeciti con essa, vi sarebbe solo l'antropologia degli
scienziati. Tutto il resto, sarebbe un tentativo abusivo di normativizzare
le pratiche date "deducendole" alle norme di una razionalità
universale e sovraordinata. Con il che, nuovamente non capiamo cosa ci sia
di tanto interessante in Giordano Bruno, anzi, in realtà non sappiamo
nemmeno, secondo queste coordinate, dove collocarlo, dato che solo con molta
fatica si può ritenere la sua filosofia una "fondazione"
erkenntnistheoretisch dell'astronomia, mentre di "filosofia
spontanea" nel senso althusseriano non è nemmeno il caso di
parlare. Ovviamente, si può anche pensare che appunto non vi sia
niente di importante nel Nolano; riteniamo invece che qualcosa vi sia: e
precisamente un discorso non-scientifico il cui legame con le pratiche scientifiche
non è uno "sfruttamento" veicolato da una fondazione ineseguibile
e pretestuosa, ma neppure si riduce al sistema dei presupposti impliciti
della sola pratica scientifica. Una lectio difficilior delle tesi
di Althusser (e Wittgenstein) dovrebbe leggere queste ultime come altrettante
occasioni per cercare un rapporto filosofia-scienze non tradizionale; cioè
dovrebbe indagare la possibilità di un interesse filosofico-extrascientifico
per le scienze differente da quello che si realizza nel nesso fondazione/sfruttamento.
3) Il Senso della Realtà
La visione bruniana di un universo infinitamente infinito è il
risultato di un'operazione inversa rispetto a quella con cui una
"concezione del mondo" precostituita sottomette le scienze e le
usa come puntello delle proprie preferenze. Qui si tratta invece di estrapolare
dalle scienze qualcosa di nuovo, un orizzonte di pensiero inedito e perciò
polemico nei confronti delle concezioni del mondo date. L'operazione bruniana
consiste nell'introdurre un'anomalia nel sistema delle presupposizioni teoriche
e pratiche in merito al nesso uomo-mondo che orientano l'agire umano, configurando
così una nuova possibile forma di questo stesso agire. Lo sfruttamento
denunciato da Althusser consiste nell'asservire i risultati delle scienze
al rafforzamento di pratiche esistenti: l'introduzione di questa anomalia
mira invece a distruggere e riorganizzare le pratiche in vigore. Evidentemente,
quali contenuti particolari si prestino ad un'operazione anziché
ad un'altra, lo può decidere solo il contesto in cui l'anomalia interviene
polemicamente, cioè è una questione pratica. Per distinguere
ciononostante le due operazioni, diremo che se la prima implica una "concezione
del mondo" dai cui principi pretende di dedurre le scienze,
la seconda implica l'introduzione di un inedito senso della realtà
(Wirklichkeitssinn), che viene piuttosto indotto dai quadri
concettuali delle scienze. La concezione del mondo ed il senso della realtà
sono ambedue strutture extrascientifiche, che coinvolgono piuttosto il rapporto
tra "uomo" e "mondo", tra "mente" e "realtà"[11]; solo, la concezione del mondo mira
a riassorbire le pratiche scientifiche (e non solo) in una gerarchia preesistente,
aprioristica e "chiusa" di valori e significati; mentre il senso
della realtà indotto dalle scienze e dalle altre pratiche tende alla
disgregazione degli ordini costituiti, e pertanto è riconoscibile
dalla sua tendenza a non stabilizzarsi in gerarchie ideali. La concezione
del mondo cerca di ricompattare il rapporto esistente tra uomo e mondo,
mentre di un nuovo senso della realtà si può parlare quando
a disposizione di un'epoca storica si dà un surplus inatteso di possibili
configurazioni di questo medesimo rapporto [12].
Da questo punto di vista, si può apprezzare la differenza tra Keplero,
che associava all'idea di un universo infinito un senso di orrore, e Bruno,
per il quale invece l'affermazione dell'infinità permette di moltiplicare
la varietà e la ricchezza dei possibili e deve appunto perciò
essere fatta valere in contrapposizione al Cosmo antico-medievale. Come
rileva Koyré, le obiezioni di Keplero si appunteranno sul fatto che
la cosmologia bruniana oltrepassa i dati dell'osservazione astronomica:
un'obiezione apparentemente mossa dalla scienza positiva contro la
speculazione selvaggia; in realtà, a Keplero preme, più che
il rifiuto delle costruzioni inverificabili, l'affermazione della natura
strutturata dell'universo per reperirvi l'impronta della struttura interna
di Dio, cioè la Trinità. Koyré ravvisa dunque in Keplero
l'opposizione protestante a Bruno, analoga a quella cattolica, anche se
non identica. Ambedue in ogni caso, mirano a scongiurare il pericolo che
l'affermazione della relativa insignificanza della Terra rispetto ad un
Universo infinito e ad un Dio immanente ad esso invalidi la plausibilità
dell'elezione divina del genere umano mediante l'Incarnazione, ciò
che invaliderebbe anche i fondamenti "storici" delle confessioni
in questione. In entrambi i casi, dunque, le teorie scientifiche vengono
combinate con un discorso extrascientifico, la funzione del quale però
è nei due casi opposta all'incirca come opposte potrebbero essere
un'insurrezione ed una carica della polizia, pur comportando entrambe atti
violenti. Ma una violenza che mira a conservare un Ordine, uno status
quo, differisce toto coelo da quella che interrompe una continuità,
spezza la ripetizione dell'identico e libera dalle macerie gli elementi
di nuove costruzioni.
Allora, "l'importanza di Giordano Bruno" relativamente alle
scienze consiste proprio nel fatto che la sua filosofia è un
effetto non-scientifico della rivoluzione scientifica; ma la non-scientificità
di alcuni effetti del sorgere delle problematiche scientifiche non significa
che tali effetti siano di "seconda classe", abusivi, o inevitabili
ma nondimeno indesiderabili: la non-scientificità di parte degli
effetti che le scienze portano con sé è indizio del fatto
che le pratiche scientifiche esistono in una totalità di pratiche
organizzata in modo complesso ed ineguale; totalità i cui legami
interni, complessi e differenziati, consentono che si diano fenomeni extrascientifici
sia a monte che a valle delle pratiche scientifiche, e perfino all'interno
di queste ultime, sempre secondo una logica specifica. Ed è appunto
questa forma di esistenza della scienza legata in molteplici modi al non-scientifico-forma
necessaria e non casuale o difettiva- a costituire l'oggetto della "storia
delle scienze" fondata da pensatori come lo stesso Koyré o Georges
Canguilhem. La ragione è sempre impura, e questa impurità
è costitutiva, non accidentale. Se l'unica conoscenza è quella
scientifica, è anche vero che essa può esistere e produrre
effetti di conoscenza solo in un reticolo di effetti risalenti a pratiche
non-conoscitive. La pratica filosofica di Bruno, volta a trasformare il
rapporto dell'uomo con il mondo, non è a stretto rigore nulla che
appartenga alle scienze; tuttavia, poiché la sua struttura e la sua
strategia decostruttiva nei confronti delle rappresentazioni consolidate
incorporano elementi della rivoluzione astronomica, e poiché essa
stessa si è a sua volta imposta nella discussione relativa alle scoperte
astronomiche e cosmologiche dell'epoca, possiamo dire che questa filosofia
appartiene alla rete di relazioni che costituisce la storia delle
scienze moderne. Storia quanto mai complessa, se è vero, e possiamo
trarre da Koyré appunto questa verità, che la rivoluzione
scientifica è stata costituita da: 1) pratiche scientifiche,
rette come da un'impalcatura (secondo una metafora che troveremo in Koyré
stesso) da: 2) "concezioni del mondo" teologico-filosofiche
fondamentalmente conservatrici, e capace di sviluppare: 3) un "senso
della realtà" audacemente rivoluzionario. La "storia",
la storicità intrinseca al sorgere delle scienze moderne, è
strutturalmente costituita dagli intrecci, dalle combinazioni specifiche,
di queste tre serie reciprocamente eterogenee se non addirittura antagoniste.
Tanto basta per far vergognare qualunque genericità sulla "storia
dell'essere", a quanto pare molto meno articolata di quella, magari
un po' meno paludata, degli "enti". Alle tortuose concatenazioni
di questa storia, del tutto essoterica ed intelligibile, ma non per questo
ovvia e agevolmente decifrabile, ai suoi snodi lungo i quali l'uomo ha guadagnato
una nuova immagine di sé e del proprio mondo, si è rivolta
l'indagine di Koyré, che possiamo definire una critica storica della
ragione pura.
4) Dalla Scomparsa di Dio alla Ragione Strumentale
È certo che Koyré sia stato uno studioso estremamente sensibile
proprio al nodo costituito dall'imporsi di un inedito senso della realtà:
l'Età Moderna, dal XVI al XVIII secolo, che Koyré ha eletto
ad oggetto di ricerca privilegiato (senza trascurare, grazie all'enciclopedica
erudizione che lo contraddistingueva, i necessari complementi dell'Antichità
e del Medioevo), è l'epoca in cui il pensiero occidentale destruttura
e ristruttura completamente l'immagine dell'uomo e del mondo, delle possibilità
dell'agire umano e del pensiero razionale. I testi raccolti in questo volume,
in specie quelli trascritti da corsi e conferenze, delineano un articolato
processo di destrutturazione e ristrutturazione del senso della realtà,
un processo l'esito del quale consiste nel proiettare su piani inediti di
problematicità il "mondo", questo spazio che si scopre
indeterminato, e l' "uomo", questo essere che nel torno di tempo
analizzato da Koyré perde la garanzia della propria collocazione
nell'universo.
Possiamo ravvisare in questi ed altri studi di Koyré una problematica
fondamentale, che ritorna in modo discreto ma costante in diverse configurazioni,
e che possiamo considerare un cardine del senso della realtà sviluppato
a partire dalla Rivoluzione scientifica nell'Età Moderna: si tratta
del tema della scomparsa di Dio dal mondo, un processo di immanentizzazione
della realtà che, movendo dalla profetica visione bruniana, si assesta
nell'esito meccanicistico del modello newtoniano della realtà fisica.
Particolarmente sintomatica è la conclusione di Dal mondo chiuso
all'universo infinito: <<Alla fine del secolo la vittoria di Newton
era completa. Il Dio newtoniano regnava supremo nel vuoto infinito dello
spazio assoluto in cui la forza di attrazione universale legava insieme
i corpi atomisticamente strutturati dell'universo infinito e li faceva ruotare
in accordo con strette leggi matematiche. Si può tuttavia arguire
che questa fu una vittoria di Pirro e che il suo prezzo fu disastrosamente
alto>>[13]. Perché questo
giudizio così lapidario? Koyré mostra che il modello newtoniano
del mondo fu sviluppato in modo tale da rendere superflua la presenza di
Dio al suo interno; della gravità si fece una proprietà della
natura anziché una manifestazione dell'intervento divino, e, soprattutto,
la materia fu fatta coincidere con l'infinità dello spazio assoluto:
<<Quanto alle dimensioni dell'universo materiale che i newtoniani
avevano opposto per prima cosa all'infinità attuale dello spazio
assoluto, la pressione incessante dei principi di pienezza e di ragion sufficiente,
coi quali Leibniz riuscì ad infettare i vittoriosi rivali, rese questo
universo coestensivo allo spazio stesso. Dio, anche quello newtoniano, non
poteva ovviamente limitare la propria azione creativa e trattare una certa
parte dello spazio omogeneo infinito (...) in modo tanto profondamente diverso
dalle altre. Così l'universo materiale, a dispetto di colmare soltanto
una parte supremamente piccola del vuoto infinito, divenne infinito proprio
come quest'ultimo. Lo stesso ragionamento che preveniva Dio dal limitare
rispetto allo spazio la propria azione creativa poteva parimenti essere
applicato al tempo. Un Dio infinito, immutabile e sempiterno non
poteva essere concepito come comportantesi in modi differenti in tempi diversi
e come limitante la propria azione creativa ad un lasso di tempo tanto piccolo.
Inoltre un universo infinito che esiste solo per una durata limitata pare
illogico. Sicché il mondo creato divenne infinito sia nello spazio
che nel tempo. Ma, come aveva (...) obiettato Clarke a Leibniz, un mondo
infinito ed eterno può difficilmente ammettere la creazione. Non
ne ha bisogno: esiste in virtù della sua stessa infinità>>[14]. Se a ciò aggiungiamo la considerazione
che le leggi meccaniche dell'universo funzionano automaticamente, sì
da non aver bisogno dei periodici interventi dell' "orologiaio",
arriviamo all'affermazione di Koyré che chiude la sua opera principale:
<<L'universo infinito della nuova cosmologia, infinito in durata come
in estensione, in cui la materia eterna, in accordo con leggi eterne e necessarie,
si muove senza fine e senza scopi nello spazio eterno, eredita tutti gli
attributi ontologici della divinità. Ma solo questi - tutti gli altri
Dio li portò via con sé>>[15].
Ciò che è iniziato con la distruzione del Cosmos, con la negazione
di un privilegio della Terra dovuto ad una speciale destinazione affidata
da Dio all'uomo, si conclude con l'esclusione di Dio dal mondo, ormai completamente
immanente a se stesso. L'esito finale del percorso tracciato nelle ricerche
di Koyré realizza ciò che le religioni rivelate temevano nel
sistema di Bruno, vale a dire nientemeno che l'impensabilità
di una presenza divina nel mondo, posto che si pensi quest'ultimo nei termini
fin qui descritti, e quindi l'assurdità dei fondamenti delle religioni
tradizionali. Il mondo infinito, autosussistente ed omogeneo, si oppone
tanto al Dio dei Filosofi, l'impassibile entità che regola l'armonia
e l'ordine del Cosmos, e ne scandisce in base alla maggiore o minore prossimità
a sé i livelli gerarchici, quanto al Dio della Rivelazione, l'essere
personale che si manifesta all'uomo per mezzo del miracolo, e che ha eletto
il genere umano a terminus ad quem delle proprie preoccupazioni,
della propria ira o benevolenza, del merito o del castigo[16].
Infatti, come spiega Koyré nella conferenza su Teologia e Scienza,
tutti i tentativi di fondare lo statuto della conoscenza teologica (da
quella che l'autore definisce "gnosi cristiana" all'aristotelismo
tomista) ricorrono al miracolo: il miracolo come manifestazione volontaria
di Dio all'uomo. Ma, come sappiamo, una realtà strutturata attorno
all'idea dell'infinito universo omogeneo rende difficile poter pensare che
Dio si preoccupi di manifestarsi agli abitanti di una palla di fango persa
nell'infinità dello spazio; e, d'altra parte, ed è ciò
che conta di più, la scienza ci vieta e si vieta di accettare i miracoli,
i miracoli cioè non tanto in qualità di singolarità
inesplicabili (anche se per un meccanicismo stretto alla Laplace si tratta
appunto di postulare un mondo regolato da leggi ferree e quindi totalmente
prevedibile), ma soprattutto in qualità di interventi di natura personale,
in qualità di eventi prodotti dall'agire di una volontà titolare
di fini e progetti, nella trama oggettiva delle cose della natura.
Il Miracolo, l'Elezione, l'Ordine, i luoghi naturali: tutto questo non fa
parte del senso della realtà indotto dalla scienza moderna, il che
significa qualcosa di più della semplice obsolescenza di alcune ipotesi
fisico-cosmologiche: significa che, dopo il pieno dispiegamento del processo
analizzato da Koyré, non possiamo più veramente credere -e
al limite nemmeno concepire- che gli esseri siano ordinati in una scala
di luoghi naturali, o che Dio abbia dato a noi uomini una destinazione particolare
che è nostro dovere realizzare; e significa che questa impossibilità
di credere non è dell'ordine delle teorie o delle ipotesi che siamo
disposti a vagliare, accettare o rifiutare, ma si radica in quella zona
di intersezione tra il nostro comportamento in atto e l'idea che abbiamo
di noi stessi e della nostra Umwelt, tra l'intreccio delle nostre
pratiche e le rappresentazioni significative che le attraversano; una zona
faute de mieux nominabile come spirito oggettivo, e che per
gli uomini dell'Età Moderna semplicemente possiede una struttura
incompatibile con una concezione religiosa o "cosmica" del mondo.
L'uomo moderno non pensa più come l'uomo antico o quello medievale:
ma dire che "non pensa più..." non è sufficiente;
l'uomo moderno non funziona più come l'uomo antico e medievale,
non solo e non tanto a livello delle idee e dei postulati teorici o morali,
ma a quello delle pratiche, delle forme di vita: è su questo piano
"antropologico" fondamentale che Dio è scomparso. La
sua presenza, la sua vigile sollecitudine verso l'uomo, la sua stessa Legge,
anche qualora vengano affermate o rimpiante da teologi, pubblicisti, filosofi
e letterati, non sono più in grado di orientare l'agire. Le pratiche
entro le quali gli uomini menano la propria esistenza vengono innervate,
nel mondo moderno, dalla struttura delle scienze naturali (e poi, in un
ulteriore passaggio storico, dalla tecnologia), e non più dai postulati
della fede. L'outillage mental a disposizione dell'uomo, cioè
la matrice che decide di cosa sia o non sia credibile e pensabile in una
certa epoca e in una data formazione sociale, è cambiato nell'Età
Moderna, ma lo è perché cambiate in primo luogo sono quelle
che Hans Blumenberg chiamerebbe le Wirklichkeiten, in denen wir leben,
cioè le strutture pratico-vitali che sostengono le possibilità
del nostro pensiero, che sono il nostro pensiero in quanto tutt'uno
con il nostro mondo, così come per Pascal il rito, la liturgia, i
suoi simboli, fino al gesto ad un tempo fisico e simbolico dell'inginocchiarsi
a mani giunte da parte del singolo credente, sono immediatamente
la fede, il "credere"[17].
Si comprende allora l'originalità della storia delle scienze praticata
da Koyré. È una storia il cui statuto non può venire
definito solo in termini di mobilitazione dell'erudizione contro le ristrettezze
delle vedute dell'epistemologia. La ricerca di Koyré prende (almeno
tendenzialmente) ad oggetto piuttosto una combinazione di ambiti, stili
di pensiero, credenze, filosofie, tecniche matematiche e sperimentali, tali
da delineare una totalità articolata ma non delimitabile apriori
e che non rientra in nessuna partizione disciplinare, ma piuttosto sorge
al crocevia, nelle intersezioni, nelle contaminazioni ai margini, degli
oggetti dati dei saperi esistenti[18].
E lo studio di questo oggetto possiede un rilevante risvolto antropologico:
si tratta di cogliere la totalità in trasformazione delle forme della
vita umana, cioè di estendere, fino a comprendere una critica filosofica
della razionalità, l'obiettivo di conoscenza di quell'uomo, ad un
tempo "tutto intero" e "esistente nel tempo", posto
da Lucien Febvre e Marc Bloch a riferimento dell'impresa del sapere storico.
Ecco dunque perché le ricerche di Koyré non possono ridursi
allo studio delle "influenze" esterne sulle scienze: sì,
le scienze sono intrecciate alle mentalità, ma le mentalità,
nella logica delle Annales, che è anche di Koyré, non
sono semplici "idee", non le possiamo trovare nella testa di qualche
individuo particolarmente geniale e facondo; esse esistono e sono comprensibili
solo nell'intreccio, nella articolazione, delle pratiche e delle forme di
vita le più disparate; è appunto questo intreccio ad essere
destrutturato e ristrutturato dall'introduzione di un nuovo senso della
realtà; ed in quanto tale intreccio incorpora in più modi
le scienze, ma non è riducibile ad esse, è proprio al suo
interno, mediante i suoi processi e le sue relazioni strutturali, che la
non-scienza si trasforma in scienza e viceversa, che la filosofia e la religione
diventano le impalcature su cui si regge il rigore del discorso scientifico,
e che una scoperta scientifica può dar vita alla contestazione di
venerabili postulati metafisici e teologici. È attraverso queste
relazioni ramificate tra pratiche, questi rapporti "cespugliosi",
tali da escludere ogni causalità lineare ed ogni sviluppo prevedibile,
in una parola, è attraverso questi rapporti surdeterminati
che pensatori mistici o addirittura praticanti la magia possono occupare
ruoli fondamentali nella trasformazione complessiva della vita umana da
parte delle rivoluzioni scientifiche, e che Giordano Bruno ed Henry More
possono essere trattati degnamente accanto a Galilei e Keplero, che la mistica
di Boehme può essere concepita come un frutto -in altro ambito-di
una rivoluzione nella scienza, e la rinascita umanistica del platonismo
può apparire come un fattore di quella stessa rivoluzione.
Queste considerazioni, che crediamo documentate dai materiali qui tradotti,
vorrebbero suggerire che l'erudizione storica in Koyré fa parte di
un ampio disegno teoretico e storico, all'interno del quale il privilegio
accordato all'indagine del pensiero astronomico e cosmologico non implica
alcun culto angustamente scientistico dell'esattezza matematica: al contrario,
l'importanza della rivoluzione astronomica sta appunto nell'ampiezza del
suo orizzonte di implicazioni. Il rilievo cosmologico dei "sistemi
del mondo" investe e permette di indagare tutte le questioni relative
al rapporto tra uomo, natura e razionalità. La storia delle scienze
di Koyré incorpora quindi questa gamma di problematiche la cui relazione
non è immediata, ma va "costruita" mediante la proiezione
che lo storico opera sull'intreccio dei temi a partire da un problema particolare
assunto come paradigma.
In proposito, cioè tenendo fermo a questa molteplicità di
aspetti dell'oggetto delle indagini koyreane, ed alla conseguenza che se
ne trae dell'inesistenza di un "positivismo" del filosofo russo,
si dovrà notare che la tesi della scarsa importanza attribuita a
Francis Bacon da un Koyré interessato unilateralmente alla matematizzazione
del discorso scientifico (e perciò in comprensivo verso i problemi
tecnici, antropologici e "ideologici" che la rivoluzione scientifica
suscita nel pensiero moderno) è largamente una leggenda. Poiché
nell'ottica dell' "uomo tutto intero", della ristrutturazione
delle forme di vita complessive, come può essere trascurabile il
ruolo dell'apologeta del dominio sulla natura? Rispetto al dibattito scientifico
o metafisico-cosmologico, Bacon rappresenta ed inaugura un tema parallelo
a quello della struttura dell'universo, e non certo meno importante: nel
pensiero del Lord Cancelliere, il crollo del Cosmos e la scomparsa di Dio
vengono elaborate direttamente nell'ottica del progetto -che ora si rende
disponibile per l'uomo- di dominio tecnico su una natura sconsacrata. Con
Bacon inizia un processo che sfocerà nell'idea di un uomo capace
di dominare la natura, di padroneggiare le proprie condizioni di esistenza,
in ultima analisi di autocostruirsi ed autoaffermarsi aldilà e aldifuori
di ogni ordinamento naturale o divino. L' "età della ragione"
è dunque l'epoca in cui la ragione si immanentizza compiutamente,
ed elegge a sua unica preoccupazione l'edificazione scientifico-tecnica
del mondo umano, cioè dell'uomo e per l'uomo. La Storia e la Società
vengono ora concepite come "natura", ma non più nel senso
aristotelico di ciò che si muove per una dinamica spontanea ed interiore,
bensì appunto nel senso di ciò che è a disposizione
dei progetti e delle costruzioni dell'uomo.
Questo lato del processo di immanentizzazione comporta anche un mutamento
nella stessa idea della razionalità. Koyré illustra il passaggio
mediante il quale lo scetticismo deriva, dall'analisi dei limiti imposti
alla conoscenza umana, la conclusione che solo quanto si trova entro
questi limiti è degno di attenzione. La ragione si qualifica dunque
come strumento pratico, strutturalmente esclusivo di tutto ciò che
non è possibile padroneggiare, produrre e riprodurre. Questo esito
segna la nascita della cosiddetta "ragione strumentale": il pensiero
non è più interessato all'indagine sulla struttura del mondo,
né ai fondamenti teoretici della propria validità e verità,
ma solo all'intervento tecnico sui fenomeni manipolabili. La scienza diventa
tecnica, la razionalità sinonimo di applicabilità ad operazioni
trasformative, ciò che era solo un aspetto dell'originaria
intenzione teoretica della rivoluzione scientifica.
5) La Teoria e La Tecnica
Lo scarto tra teoria e tecnica strumentale è in se stesso molto
problematico. Infatti, sebbene i due fenomeni non possano essere pacificamente
identificati, nemmeno si può trascurare il loro rapporto: la tecnica,
nonostante ciò che può suggerire il malvezzo di chiamarla
téchne sottintendendone l'origine antica, comincia infatti
a diventare un problema ineludibile solo allorché incorpora la scienza
moderna, che pure appare originariamente diretta ad una pura razionalità
teoretica. In altri termini, solo da quando è in stretto rapporto
con la scienza, la tecnica è diventata capace di creare mondi vitali
a propria immagine, di ricostruire a partire da sé lo spirito oggettivo.
L'aporia sta in ciò, che la scienza in quanto teoreticità
pura appare mossa da una teleologia rivolta alla progressiva razionalizzazione
dell'esperienza, e non direttamente alla trasformazione dei fenomeni ridotti
a substrato indifferente di una strumentalità altrettanto pura: sebbene
solo l'unione di scienza e tecnica possa produrre un mondo, gli effetti
di ristrutturazione dello spirito oggettivo seguono tendenze che, dall'uno
all'altro fenomeno, sono essenzialmente differenti, e talora antitetiche-la
teleologia interna alla teoresi implica direzioni antropologiche, cosmologiche
e epistemologiche differenti dalla teleologia del comportamento tecnologico.
Questo nesso contraddittorio è ciò che Koyré ha intravisto
contrapponendo Bacone a Galilei ed al tempo stesso rintracciando nella rivoluzione
scientifica di cui è protagonista il pensiero matematizzante dello
scienziato italiano il punto di insorgenza di un processo che condurrà
alla realizzazione del progetto epocale del Verulamio.
Cerchiamo allora di determinare quali siano le direzioni antitetiche rispettivamente
della tecnica e della teoria, almeno per quanto riguarda il torno di tempo
indagato da Koyré. Emerge in primo luogo che la razionalità
strumentale - le cui radici sono, non scordiamolo, localizzate nella critica
scettica alla conoscenza - è una razionalità essenzialmente
finita. Con ciò intendiamo che essa è caratterizzata
da due limiti strutturali, il primo relativo all'oggetto della razionalità
teoretica, il secondo relativo alle sue finalità ed al suo sviluppo
immanente: in primo luogo, abbiamo il limite posto dalla limitazione del
campo delle conoscenze legittime agli oggetti accessibili alle operazioni
di una coscienza empirico-sensibile; in secondo luogo, abbiamo il limite
posto dalla funzione strumentale della conoscenza, che, facendo di essa
il mezzo di un fine posto dall'esterno, ne nega la sussistenza e lo sviluppo
illimitato per assegnarle un terminus ad quem nella realizzazione
di un apparato tecnico capace di rendere obsoleto il sapere stesso. Dal
punto di vista strumentale, la teoria né può occuparsi dell'infinito,
né può essa stessa caratterizzarsi come compito infinito,
cioè come illimitato sviluppo delle proprie operazioni, illimitata
trasformazione delle proprie strutture, e illimitato lavorìo di fondazione
del proprio discorso a pretesa di validità razionale. Eppure questi
due riferimenti ad un oltrepassamento dell'orizzonte della singola coscienza
empirica e della sua esperienza sono immanenti alla struttura della scienza
moderna, che non può accontentarsi di essere uno strumento, né
di limitare i suoi interessi agli obiettivi plausibili di una manipolazione
"poietica". Blumenberg vede nello stesso Descartes la perorazione
di questa "cattiva finità": <<IL difetto della creazione
cartesiana, è la sua mancanza di idealità, il suo puntare
alla finitezza e a una funzione intermediaria della teoria. Per Cartesio
lo studio della natura doveva servire a preparare la morale definitiva e
una medicina utile alla vita. La purezza della conoscenza esatta non costituiva
per lui l'Idea per un cammino storico infinito della teoria. Col
lavoro di alcune vite si sarebbe pervenuti a prolungare la vita e ad assicurarne
la felicità: la ricerca scientifica era destinata ad essere non meno
provvisoria della moral par provision>>[19].
L'antropocentrismo della razionalità strumentale ha un esito inquietante:
qualora le scienze assicurino il benessere dell'uomo, il loro compito svanisce
ed esse possono scomparire -un perfetto stato di felicità garantito
tecnicamente rende superfluo il sapere e la stessa razionalità teoretica.
La realizzazione della felicità umana, se posta come fine della conoscenza,
coinciderebbe allora con l'avvento di un'umanità post-razionale,
e l'utopia cartesiana somiglierebbe, più che ad una repubblica dei
dotti, all'incubo filosofico con cui Alexandre Kojéve ammalierà
i protagonisti della cultura francese del Novecento. Da questo antropocentrismo
si tiene appunto lontano Koyré, al centro del cui pensiero c'è
invece l'infinito, l'infinità del cosmo, e l'infinità del
compito della ragione. In questo, Koyré segue ancora una volta Giordano
Bruno, la cui posizione è stata magistralmente descritta come segue
da Blumenberg [20]: <<Bruno non
è il mediatore di uno stato di acquietata contemplazione di fronte
alla scena celeste, che ora è solo in apparenza chiusa. Quasi nello
stesso istante in cui, grazie a Copernico, la terra è diventata eccentrica
e quindi problematica come sede di un'immobile contemplazione, la fantasia
teoretica si fa venire l'idea di abbandonarla. Nel suo grado massimo l'autodeterminazione
della teoria è il massimo di mobilità (...); se ogni stato
del mondo è diventato equivalente ad ogni altro e, quindi, ogni contemplazione
equivalente ad ogni altra, allora il guadagno può consistere solo
nell'incessabilità delle realizzazioni di queste. Il discorso della
ragione liberata dai suoi ceppi, il metaforismo dell'attraversamento dello
spazio annunciano la fine della teoria come pacificazione, come eudaimonia,
come vita appagata, sostituite dal processo infinito come forma dell'esistenza
dell'umanità. La ragione (...)si trasforma in organo del concetto
di infinità>>[21].
L'infinitismo teoretico e cosmologico di Bruno ridimensiona la posizione
dell'uomo, dei suoi bisogni e delle sue possbilità, come terminus
ad quem della teoresi: l'oggetto del sapere è la struttura della
realtà, la forma razionale delle cose, la fondazione infinita dei
processi di risoluzione dei fenomeni in quella forma, non la massimizzazione
degli utili umani, ma questa conclusione implica e ad un tempo presuppone
che l'eccellenza umana venga sostituita nell'ordine degli scopi ultimi dalla
teleologia immanente della teoria stessa. L'infinità dell'universo
e l'infinità della conoscenza di esso possono venire affermate in
se stesse, come finalità autonomamente valide, solo come correlato
di un certo misantropismo cosmico, che Blumenberg attribuisce senz'altro
al Nolano. Dopo Althusser potremmo parlare di antiumanesimo teorico, che
resta la formula migliore. Infatti, la foucaultiana "morte dell'uomo"
può far pensare -certo contro le intenzioni di Foucault- ad un decesso
sopraggiunto per compimento di un fine intrinseco alla specie umana; e l'imputazione
di misantropismo sembra incongrua rispetto ad una tendenza che esordisce
annunciando la dignificazione derivante all'uomo dall'abbattimento della
chiusura del cosmo. In realtà, l'uomo non "muore", né
subisce una denigrazione come effetto del proprio decentramento. Al contrario,
la possibilità che la storia umana non si concluda in una sorta di
serraglio tecnicamente garantito e gestito sta proprio nel fatto che l'uomo
è il Trager del processo della conoscenza, il quale è
infinito, e quindi aperto di diritto a configurazioni tali da eccedere qualsiasi
chiusura. L'infinità dell'universo scaglia l'uomo in una realtà
estranea cui deve far fronte razionalmente, anche qualora ciò non
potesse tradursi in una riduzione tecnologica delle fonti di rischiosità.
L'estraneità nei confronti del reale connessa al gioco infinito di
aumento delle conoscenze e parallela crescita delle sfide e dei problemi
per cui le soluzioni non sono prefabbricate, ma richiedono una creatività
infinita della ragione, è ciò che può trattenere
l'uomo dal ridursi ad un animale d'allevamento foraggiato dai propri sistemi
di protezione, proprio in quanto quel gioco obbedisce a tendenze non antropocentriche.
Così Koyré può affermare che l'itinerarium mentis
in veritatem costituisce quanto vi è di più alto nello
spirito umano. Appunto, ciò che vi è di più eccellente
nello spirito umano è la sua capacità di fare dell'altro da
sé il proprio tema, cioè di rivolgersi a regioni in cui le
esigenze immediate dell'uomo tacciono. Per Blumenberg questo approccio sta
alla base delle speculazioni naturalistiche di Anassagora: l'uomo non è
stato fatto per contemplare i cieli, né i cieli per essere spettacolo
ad occhi umani, ma la possibilità di indagare una realtà indifferente
e impossibile da dominare, il fatto che sia possibile cercare di comprenderne
il meccanismo, nobilita l'intelligenza umana rivolta a questo compito infinito.
Questa estrema fedeltà alla teoria è forse la stessa che vediamo
intessuta nell'insistenza di Koyré sul significato di operazione
teoretico-razionale della scienza. In effetti, questo tema rivela solo una
volta di più il carattere intimamente paradossale e problematico
del pensiero di questo erudito commentatore di antichi testi, che può
essere variamente definito un'antropologia non-antropocentrica, un razionalismo
puro che si affida alla storia delle idee e della cultura, una filosofia
della storia senza teleologia, un'esaltazione della specificità della
scienza che ne indaga gli effetti extrascientifici più disparati,
una teologia dell'impossibilità di una forma di vita realmente religiosa.
A suo modo, il dotto studioso russo è stato altrettanto rivoluzionario
e iconoclasta dell'eretico di Nola cui attribuiva tanta importanza. Anche
Koyré è stato un distruttore di sfere, delle sfere disciplinari
che imprigionano i saperi e ne limitano le feconde contaminazioni reciproche,
e questa distruzione è avvenuta nel segno di una fedeltà alla
tensione verso la razionalizzazione dei fenomeni.
Come abbiamo visto, le implicazioni dell'opera di Koyré si spingono
fino alla problematizzazione delle forme contemporanee di vita, definite
dal nesso tra scienza e tecnologia. Ci si può chiedere se oggi la
caratterizzazione della tecnica come progetto incentrato su una coscienza
empirica finita regga ancora: nelle realizzazioni odierne dell'apparato
tecnologico che regge la nostra esistenza, non vediamo continuamente infranto
il limite di ciò che è disponibile e comprensibile ad una
coscienza fenomenica quale quella che Hume voleva porre a fondamento non
riducibile del sapere? Probabilmente, oggi non è più solo
la teoria, ma la stessa tecnologia, ad eccedere le prestazioni misurate
sulle esigenze umane: i fini dell'ente uomo non circoscrivono più
le possibilità di creazione e di esperienza accessibili tecnologicamente.
Il problema allora consiste in questo: questa infinitizzazione della tecnologia,
in quale misura dipende dalla continua incorporazione della scienza, dunque
dall'infinità della teoria stessa? A quanto pare, la tecnologia si
apre all'infinità delle proprie prestazioni solo allorché
si unisce alla teoria in quanto fenomeno extratecnologico, privo di intenzionalità
funzionali. Si può allora ipotizzare che un approccio capace di unire
l'analisi delle implicazioni e degli effetti antropologici, sociologici
e culturali delle scienze al riconoscimento dell'autonomia della teoresi,
quale troviamo esemplificato dalle ricerche di Koyré, possa costituire
un importante strumento critico per orientarsi nel mondo attuale, importante
quanto lo fu un tempo per istituire un senso della realtà adeguato
alle scienze nascenti il pensiero di un Giordano Bruno.