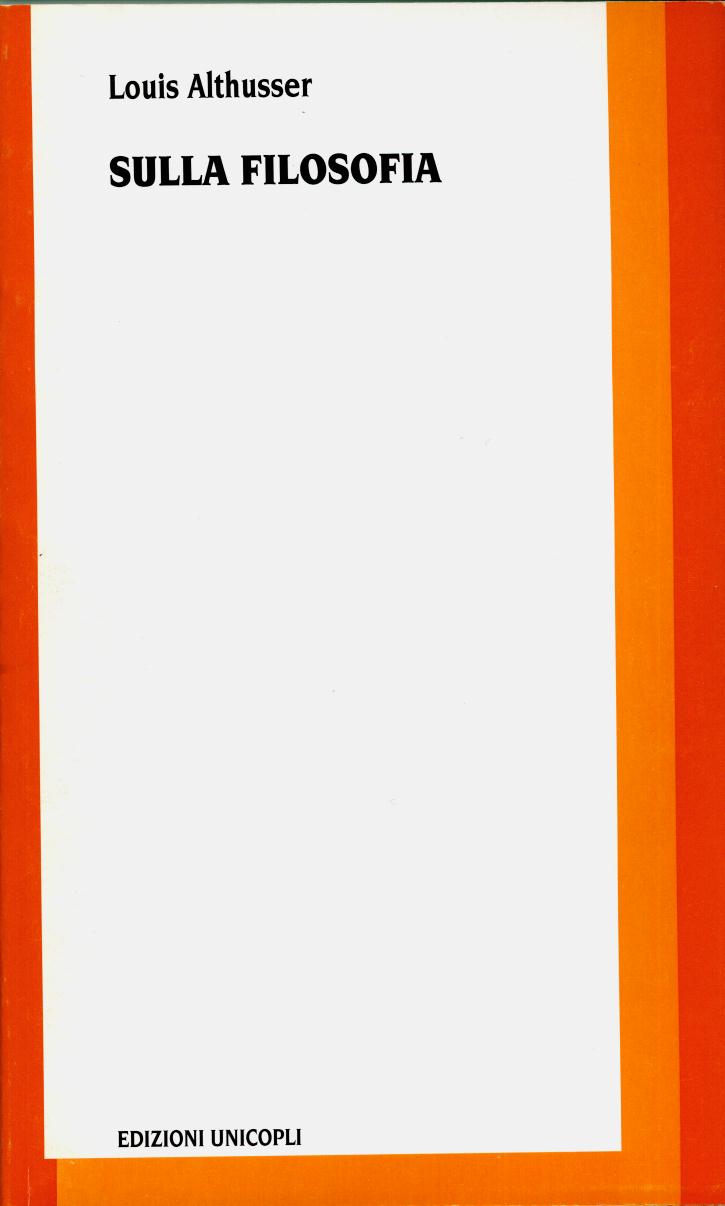 |
Louis Althusser Sulla filosofia |
Introduzione
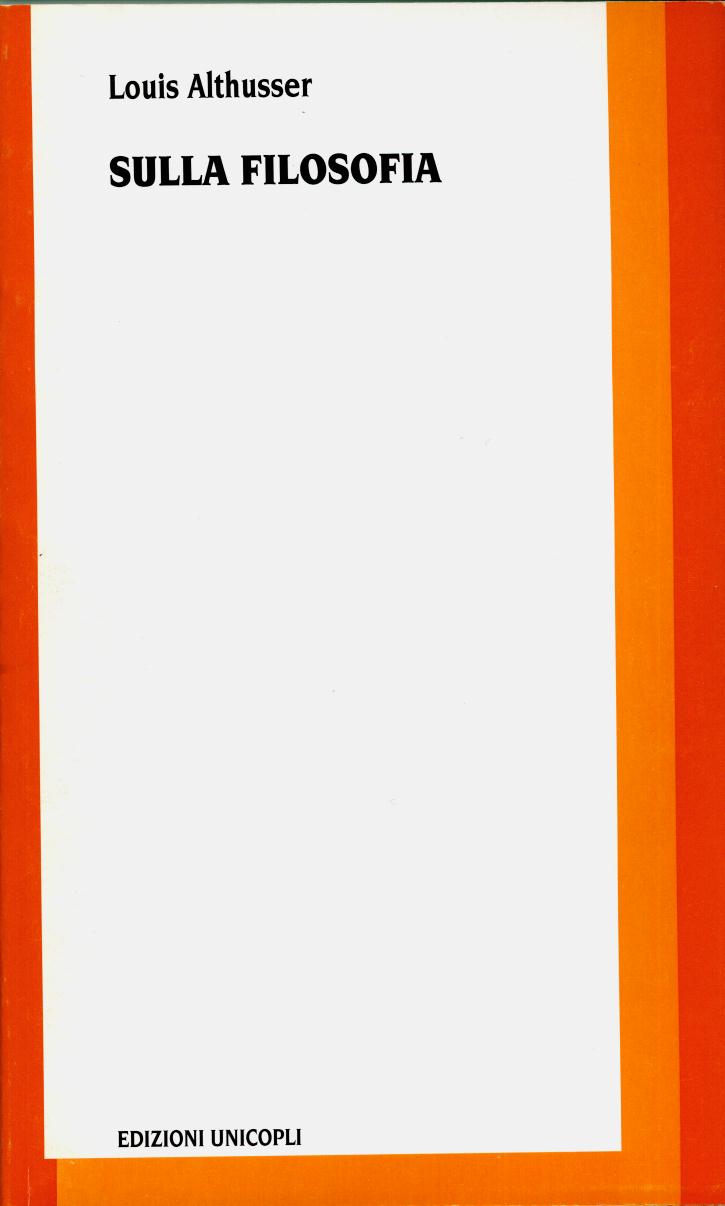 |
Louis Althusser Sulla filosofia |
Introduzione
Il nomade non è forzatamente qualcuno che si muove: ci sono viaggi sul posto,
viaggi in intensità, e anche storicamente i nomadi non sono quelli che si muovono alla maniera
di quelli che migrano, al contrario sono quelli che non si muovono, che diventano nomadi per restare allo stesso posto sfuggendo ai codici.
Gilles Deleuze
La riflessione sul tema della filosofia è presente in tutto il
corso dell'opera di Althusser. Il filosofo francese prende
le mosse da due differenti concezioni: quella marxista, che identifica la
filosofia con il materialismo dialettico, e quella hegeliana, che pensa
la filosofia come dialettica, presenza a sé del concetto e del processo
(storico) di riduzione dell'esistente alla totalità del sistema.
Althusser affronta queste definizioni, a loro modo classiche, della filosofia,
per giungere alla produzione di un nuovo pensiero, sia della conoscenza
filosofica, sia della storia. Althusser pone due problematiche fondamentali:
ha senso l'esistenza della filosofia se la storia è completamente
necessitata da un movimento dialettico della materia che ne determina ogni
manifestazione? E, quindi, è la filosofia produzione di conoscenza,
e quindi una disciplina storica, o si pone come scienza a priori? Seguendo
questa duplice polarità di temi Althusser si pone diversi compiti
teorici, che qui elenchiamo in ordine sparso: restituire alla filosofia
la sua dimensione storica, in quanto parte di un intero sociale strutturato,
anch'esso storico; elaborare categorie finalizzate alla comprensione dei
processi sociali di produzione della filosofia, e sottolineare come tale
conoscenza possa emergere solo dal marxismo, depurato dalle derive finalistiche
e meccanicistiche; identificare ruolo e funzione della filosofia nel processo
di riproduzione del sistema sociale; affermare l'autonomia di un pensiero
filosofico marxista all'interno del marxismo stesso, e ribadirne la necessità
rispetto alla lotta di classe. A partire da leggere "il Capitale"[1], Althusser ha dato a queste questioni
soluzioni differenti. In quest'opera, la filosofia è considerata
come meta - epistemologia, come scienza delle scienze, massima disciplina
conoscitiva, incaricata di valutare la scientificità o la non scientificità
dei concetti, dei metodi e degli oggetti delle varie scienze, essendo la
filosofia strumento con cui il marxismo, la scienza della storia, disciplina
prima e onnicomprensiva, separa il campo delle scienze da quello delle ideologie.
Passo successivo, che porterà all'autocritica [2]
del 1972 (ma pubblicata nel 1974), è una serie di ricerche
( da filosofia e filosofia spontanea degli scienziati[3]
a Lenin e la filosofia[4]
) in cui appaiono le posizioni che caratterizzeranno sempre più le
tesi di Althusser sulla filosofia. La filosofia, si avvicina maggiormente
ad un ambito a lei più consono: concetti, immagini, segni, le relazioni
tra questi, dotati di valore di realtà in quanto sistemi di validazione
della realtà stessa. La filosofia agisce sugli schemi di significato,
le ideologie. Cambia il rapporto tra la filosofia e le scienze. Se precedentemente
la filosofia deteneva un potere sulla scientificità delle scienze,
ora non più. Le filosofia non decide nulla rispetto alle scienze.
É all'interno stesso del progresso della scienza che si stabilisce
cosa è scientifico e cosa no. Però, la scienza fa riferimento
a principi generali di comprensione/fondazione, che sussistono al suo interno,
non arrivando ad esplicitarsi direttamente se non nei momenti di crisi dei
paradigmi dominanti. Essi sono l'ideologia spontanea degli scienziati. Esempio
ne possono essere la categoria di <<materia>>, o quella di <<legge>>.
La scoperta dell'esistenza e della funzione conoscitiva delle ideologie
sposta decisamente l'ambito d'intervento della filosofia dalle scienze alle
ideologie.
Althusser abbandona in questi scritti l'idea di una natura unica e integrata
del discorso filosofico. Come le ideologie fanno riferimento ed oscillano
tra tendenze materialiste e idealiste, così la filosofia è
attraversata da questa lacerazione, per cui le tendenze materialiste e quelle
idealiste combattono una lotta per la supremazia su cui l'ordine di costruzione
dell'edificio filosofico cerca di imporre una pacificazione provvisoria.
Ugualmente, si manifesta la differenziazione ed il conflitto all'interno
delle scienze, portato dalle ideologie, istanze significanti espresse dalla
società divisa in classi. Althusser comincia ad indagare in questi
testi la dinamica di riproduzione del capitalismo, ed inizia a leggere,
anche se in modo rigido e ortodosso, sia la scienza che la filosofia come
apparati di produzione del processo di riproduzione della società.
Nei suoi ultimi scritti Althusser concentra il suo interesse sul tema delle
ideologie, per la ricerca, esplicita, di una teoria della filosofia. Anche
negli scritti sulla psicanalisi, a più riprese, aveva approcciato
queste tesi. In essi il continente - inconscio si nutriva dell'insieme di
contenuti - segno socialmente acquisiti nei costrutti ideologici. Da lo
Stato e i suoi apparati[5], alla
conferenza di Granada, alla corrispondenza con Fernanda Navarro, all'intervista
- saggio sulla filosofia a lei concessa, testi raccolti da Gallimard nel
volume sur la philosophie,[6]
e che presentiamo qui per la prima volta in traduzione italiana, Althusser
indaga i sistemi e le funzioni dell'ideologia. Le ideologie, complesse,
diversificate e articolate al loro interno, sono insiemi di segni ed immagini
che raccolgono l'intero sociale in ambiti di senso capaci di orientare e
fondare l'azione dei singoli individui. che dell'ideologia . Althusser chiama
<<effetto di soggettività>> il processo in cui gli individui
si fanno portatori delle ideologie, pensandosi come <<soggetti>>.
La filosofia lavora sulle ideologie, per riunificarle in categorie e relazioni
concettuali. La filosofia, prendendo a prestito dalla scienza modelli di
razionalità logica e criteri di validazione, piega le diverse tendenze
ideologiche nell'organicità dei suoi costrutti speculativi, sanzionando
la primarietà dell'una o dell'altra ideologia. Questo significa che
la filosofia segue, ed é trascinata, dal movimento costante e fluido
delle ideologie, che a loro volta sono parte di un generale dinamismo della
società storicamente esistente. La filosofia è attraversata
dalle tendenze di cui sono portatrici le diverse ideologie, in particolare
da quella materialista e da quella idealista. Però, a differenza
di quello che aveva affermato in Lenin e la filosofia,[7],
ora Althusser non distingue due filosofie contrapposte, portatrici dell'una
o dell'altra tendenza. La filosofia è un campo complessivo, attraversata
nelle sue diverse e singolari manifestazioni da elementi dell'una e dell'altra
tendenza, in un conflitto che si svolge nel suo stesso seno. Non esiste
una filosofia pura, sia materialista che idealista, e non esiste un contesto
speculativo sgombro dalla complessità dei livelli di contraddizione
e conflitto. Mentre nella società, e di riflesso nelle ideologie,
si presenta un quadro costante di fratture e scissioni, di aggregazioni
e disarticolazioni, la filosofia tenta di mettere ordine, definendo e cristallizzando
il contesto di un'epoca in termini di concetti. Nello stesso tempo, viene
trascinata nuovamente nel flusso aleatorio e nella polarizzazione antagonistica
della storia concreta.
Centrali per comprendere quest'ultima fase del pensiero di Althusser sulla
filosofia sono le tesi sul materialismo aleatorio, di cui anche negli scritti
qui presenti si fa costante riferimento.
UN DIVERSO STATUTO DEL PENSARE
Da questo sguardo di insieme sulle varie fasi del pensiero di Althusser
sulla filosofia, possiamo ora tornare alle due problematiche che erano state
accennate all'inizio: la messa in discussione della concezione hegeliana
della filosofia (idealista), e la messa in discussione della concezione
marxista della filosofia (il materialismo dialettico come compimento della
filosofia). Seguiamo allora il percorso compiuto da Althusser per il superamento
delle due concezioni. Se è vero, infatti, che Althusser si
è servito a lungo di entrambe, e ha con esse a lungo mediato, in
ogni caso possiamo indicare alcuni punti centrali che attestano come nelle
sue argomentazioni ci sia l'articolazione di un diverso statuto del pensare.
Essi sono, schematicamente:
1) la filosofia è una pratica. La filosofia è un fare concreto
che lavora su - <<mette in produzione>> - realtà
storiche e come tale è un entità materiale, connessa al contesto
storico - sociale dato, ai suoi apparati, con una funzione propria;
2) la filosofia non produce la storia, ma è prodotta dalla storia.
La storia concreta della società è il <<di dietro>>
della filosofia, ne decide le forme, la funzione, le linee e gli obiettivi
tattici e strategici, generando le ideologie su cui si esercita <<l'effetto
filosofia>>;
3) la filosofia non ha compimento. Così come la storia non procede
per stadi e fasi, a partire da principi e tendendo ad un fine, così
la filosofia è il divenire eterno dei concetti, dei sistemi di integrazione
e organizzazione delle ideologie. Se la filosofia non muore, d'altra parte
non è neppure la scienza del compimento, di ciò che è
(o arriva) ultimo;
4) la filosofia è un campo di battaglia. Nonostante l'aspirazione
della filosofia a pacificare il conflitto tra le diverse tendenze ideologiche,
è parte e frutto di uno scontro che coinvolge l'insieme della società,
a diversi livelli ed in forme diverse;
5) La filosofia non è sul <<ponte di comando>>. La filosofia
non è la scienza dei fondamenti ultimi, né è la scienza
dei fini ultimi, né ha una preminenza rispetto alla definizione degli
oggetti e degli strumenti conoscitivi. La scienza, prima, e la storia stessa
e le ideologie, poi, sono i continenti in cui sorge ciò che è
reale, ciò che è possibile e ciò che é necessario.
La filosofia arriva sempre dopo, portando alla parola ciò che già
è presente ed attivo nel teatro della storia, disponendolo, in modo
non unitario, in contesti di senso organici e complessivi;
6) la filosofia non ha un oggetto. La filosofia non è la rappresentazione
razionale di entità concettuali o fondative, è l'ininterrotta
azione di elaborazione delle ideologie mediante il continuo fluire di concetti;
7) la filosofia produce distinzioni. La filosofia pratica cesure che distinguono
i diversi ambiti e <<continenti>> (le ideologie, la scienza,
la storia, ecc.), ognuno dotato di autonomia relativa, all'interno del contesto
storico dato Per questo, parlare in termini di totalità del discorso
filosofico è un'assurdità.
Althusser ha ispirato il dibattito filosofico che in Francia ha studiato
i processi di costituzione della razionalità[8],
riponendo la verità della filosofia nell'agone delle ideologie. Ha
immerso la filosofia nel decorso infinito, plurivoco e segmentato della
storia, indagando la costituzione materiale del discorso filosofico. Per
Althusser la filosofia ha il ruolo centrale di riunificare le ideologie.
Questo non significa che è il potere che assicura ad una società
la sua permanenza, poiché sono le istituzioni economiche e gli apparati
ideologici a farlo, ma che è depositaria dell'immagine complessiva
di un'epoca: nei suoi concetti, anche i più astratti, sono i tratti
fondamentali di una fase storica che arrivano alla parola, e diventano testo.
In questo testo, sempre da riscrivere, le istanze del dominio e quelle della
liberazione, le tendenze idealiste e quelle materialiste, si agganciano
in costrutti mobili e diversi, seguendo il divenire al limite indeterminato
della società. Vero è che la filosofia pretende di essere
ordinatrice e regolatrice, portando a compimento definitivamente la storia
con la validazione per l'eternità delle ideologie egemoniche. Il
dominio è carattere intrinseco della filosofia. Proprio per questo
ne è attributo inscindibile la guerra. Nella filosofia si svolge
incessantemente il conflitto tra le tendenze, idealiste e materialiste,
che rappresentano il dominio, e le tendenze, dai molteplici contenuti, che
invece lottano per la liberazione, per la continua produzione di vita.
Althusser di fronte alla filosofia contemporanea
Decentrare e decostruire la filosofia è l'operazione teorica di
Althusser. In direzione esattamente opposta procede gran parte della filosofia
contemporanea. In essa, possiamo distinguere cinque posizioni principali:
- il pensiero poetante. Attraverso l'uso improprio del linguaggio heideggeriano
dell'ascolto dell'essere, si riduce la filosofia l'immagine a un puro succedersi
di suggestioni fini a se stesse, a cui poi viene assegnato un valore fondativo[9];
- la filosofia della complessità, in cui l'azione ermeneutica e decostruttrice
produce effetti neo scettici, in cui il gioco casuale dei contenuti e dei
linguaggi impediscono la posizione di qualsivoglia contenuto che non sia
semplice frammento[10];
- le scuole della fine della storia. La chiusura della storia nel capitalismo
di fine/inizio secolo è dedotta per conseguenza logica da principi
generali di natura ontologica [11];
- la metafisica del linguaggio. La filosofia è l'analisi delle serie
linguistiche e delle loro regolarità logiche o strutturali, considerate
le uniche realtà effettivamente conoscibili[12];
- il neo pragmatismo, e il contrattualismo, sua variante. La filosofia definisce
le regole e i processi regolativi razionali in cui i soggetti stipulano
legami di natura essenzialmente giuridica[13].
Gli argomenti di Althusser permettono di ricostruire il rapporto tra tali
filosofie e questa fase dello sviluppo capitalistico, con la prospettiva
di una proposta filosofica che rispecchi la produzione di pratiche di emancipazione
nella composizione continua di concetti aperti.
L'unica tradizione materialista
Una corrente di pensiero ha praticato la medesima strategia filosofica:
la tradizione materialista[14]. Althusser
cita Epicuro, Machiavelli, Spinoza, Nietzsche, Marx, Heidegger, ed, in ultimo,
Derrida. Althusser sembra procedere con il metodo di Georges Politzer[15], autore che Althusser ha citato come
suo possibile maestro[16], che aveva
contrapposto la tradizione del razionalismo europeo a quella dell'oscurantismo.
Politzer incarnava in alcuni pensatori, di diverse periodi, lo sviluppo
della giusta linea teorica, contrapposta a quella delle posizioni dei dominanti.
In Althusser la tradizione materialista rappresenta non tanto una razionalità
valida, che avrebbe nel marxismo il suo compimento, quanto l'espressione
della materialità storica del pensiero, il suo far riferimento al
corpo diveniente della società, e l'infinita, molteplice e plurivoca
azione costruttiva e decostruttiva della filosofia, liberata dalle rigidezze
ed unilateralità. Essere materialisti significa abbandonarsi al flusso
della storia, all'infinita possibilità dei suoi componenti di incontrarsi
in figure differenti e di differente durata, e di dar loro voce nel pensiero.
La filosofia materialista quindi combatte il dominio attaccando le categorie
che riducono la storia ad eterno presente: l'origine, il fine, il soggetto.
Spinoza e Marx
La filosofia che Althusser delinea non rinuncia ad una intensità
antagonista ed emancipatrice. La filosofia è un corpo concettuale
vivente che è parte del corpo materiale della società.
La filosofia esprime i diversi quadri tattici in cui si posizionano le ideologie,
assumendo e trasfigurando nel concetto la capacità significante dei
corpi viventi. Althusser sposa il contenuto centrale del pensiero di Spinoza:
non esistendo distinzione ontologica tra pensiero e materia, non è
possibile una filosofia al di fuori della società che la esprime.
Althusser non separa il pensiero dalla solidità del corpo sociale,
li distingue, come Spinoza, riconoscendone l'intima connessione.
Spinoza non riconosce l'esistenza di un corpo senza idea corrispondente.
Dunque, ciò che agisce sul corpo agisce parimenti sull'idea per conseguenza
diretta. Althusser consegna la filosofia alle azioni e reazioni che accadono
nella società, sottolineandone il carattere aperto e diveniente,
complesso, dipendente da molteplici fuochi, i cui risultati non sono univoci
e stabili, ma innescano sempre nuove evoluzioni definibili solo a posteriori,
e sempre parzialmente. Althusser così legge lo spinoziano terzo genere
di conoscenza alla luce del carattere finito della filosofia, in termini
di <<costanti o invarianti generiche che dir si voglia, le quali affiorano
nell'esistenza dei "casi" singolari e ne permettono il trattamento>>[17].
La filosofia finora ha interpretato se stessa come conoscenza totalizzante,
mettendosi al potere sulle ideologie e le scienze. Althusser nega alla filosofia
tale potere, dando la preminenza a ciò che è alle spalle della
filosofia, all'operato e al significato delle pratiche, ed è a Marx
che si fa nuovamente riferimento ora.
Marx ha infatti dimostrato che dietro la filosofia esiste la pratica. La
pratica limita la filosofia, sia in termini conoscitivi, che fondativi.
La pratica, l'azione storica degli aggregati e delle istituzioni sociali,
è un oggetto del tutto peculiare che esige categorie proprie. Marx
ha scoperto questo continente, la storia, e la scienza corrispondente, con
i concetti di rapporto di produzione, di forze produttive, di plusvalore,
ecc. La filosofia non verte su quest'oggetto, ma ne subisce l'azione: istituisce
l'immagine di una fase storica componendo i significati espressi dalle pratiche
in sistemi di relazioni concettuali. La filosofia rivendica la sua assolutezza,
poiché sostiene tesi (eternamente) vere, (eternamente) stabili, (eternamente)
ultime, ma la pratica la costringe a riposizionamenti continui, all'elaborazione
di nuove categorie, di nuovi schemi teorici. Conseguentemente, è
la storia che fonda la filosofia, e non viceversa. La filosofia, non lavora
su oggetti propri, entità ultime, principi che starebbero alle spalle
della storia. La filosofia dispone nel concetto i caratteri che definiscono
un'epoca o una determinata fase storica, non è la scienza delle cause
prime, né delle leggi eternamente valide, né della soggettività
trascendentale.
Marx, spodestando la filosofia, restituisce la storia a se stessa, ai rapporti,
ai processi e al movimento dei suoi costituenti. È nel processo di
riproduzione della società capitalistica che va cercata la funzione
della filosofia., essendo una pratica sociale al pari delle altre. La filosofia
crea ideologie, nozioni false che impediscono la cognizione dello sfruttamento
capitalistico: la filosofia è parte degli apparati repressivi dello
Stato. Ogni filosofia nasce con un preciso mandato politico. Per Marx la
storia è la storia del conflitto di classe, dove la filosofia partecipa
attestandosi sul proprio fronte, quello dei concetti. Althusser fa reagire
le posizioni marxiane con quelle di Spinoza. Il significante è attributo
degli individui e della società. L'ideologia è un dato eterno
che è tutt'uno con la materialità delle pratiche, parte della
costituzione stessa della realtà. L'ideologia non è riducibile
al suo significato negativo. Di conseguenza, <<l'effetto filosofia>>
è il frutto necessario della tendenza delle ideologie a fondare la
propria verità in aggregati articolati di concetti.
D'altra parte, ogni architettura concettuale è soggetta alla azione
disgregatrice dei conflitti che dalla società si traspongono al suo
interno. Marx, piuttosto che focalizzare una modellistica dei sistemi, ha
portato alla luce lo scontro che è organicamente parte della struttura
del capitalismo. La differente collocazione nell'ambito dei rapporti di
produzione provoca fratture che attentano alla stabilità del sistema.
Ogni filosofia, sia essa progressista o reazionaria, porta in sè
lo scontro che è alla base della società capitalistica. Traspare
in controluce dalle sue categorie, a volte viene fatto proprio esplicitamente,
ma più spesso ne è il non - detto.
Nel campo di battaglia filosofico si fanno strada le istanze della liberazione.
Come nella storia si organizzano e si mobilitano le forze che spingono per
il cambiamento della società, così nascono filosofie che mettono
in discussione la filosofia stessa, decostruendone i principi totalizzanti,
l'origine, il fine ed il soggetto, e <<mettendosi al servizio>>
della libero e mutevole divenire della storia. La prassi della trasformazione
sociale ha in esse, il cui avvento è stato preannunziato da Spinoza,
in termini teorici, e da Marx, in termini storico - pratici, il suo orizzonte
filosofico.
Heidegger e Nietzsche
Althusser cita più volte nei suoi ultimi scritti Heidegger e Nietzsche.
Dopo la morte della moglie e le gravi sofferenze morali e psicologiche che
ne seguirono, progressivamente Althusser si riavvicinò alla filosofia,
proprio leggendo delle opere di Heidegger e Nietzsche. Vi fa esplicito accenno
nelle lettere a Fernanda Navarro scritte nell'estate del 1984. Fu fortemente
colpito dalle opere dei due autori. Althusser, in alcune frammentarie osservazioni,
inserisce Heidegger e Nietzche nella tradizione materialista. Sembra alludere
al fatto che tramite loro, avesse potuto mettere a fuoco dei nodi problematici
che precedentemente non aveva considerato. Costante, almeno dagli anni '60,
era stata in Francia l'attenzione ai due autori tedeschi. Nell'ambiente
frequentato da Althusser la lettura di Nietzsche, fatta spesso attraverso
le categorie heideggeriane, aveva portato a sviluppi teorici importanti,
come la critica radicale alla fenomenologia. Facciamo riferimento qui a
Deleuze, a Foucault, a Derrida, ma non solo. Pur nella lontananza e all'inattività
cui era costretto dalla malattia, Althusser prende parte al dibattito in
corso, rivedendo le sue posizioni. É in questo periodo che elabora
il concetto di materialismo aleatorio.
In questi testi non ci sono riferimenti sufficienti per attestare un'influenza
di Nietzsche ed Heidegger. Althusser afferma nelle lettere, in alcuni stringati
passaggi, che Heidegger ha mostrato i principi fondanti il pensiero metafisico
occidentale, l'origine, il soggetto ed il fine. Di Nietzsche, accenna solo
di averlo capito facilmente.
Vorremmo proporre alcuni spunti per un confronto tra Althusser, Heidegger
e Nietzsche, che potrebbe trovare maggiore approfondimento in studi specifici.
[18]
L'ultimo Althusser, Heidegger e Nietzsche sono accomunati dalla ricerca
di alcuni obbiettivi teorici:
- una teoria della trasformazione che, prendendo spunto dalle categorie
del venire alla presenza e dell'evento, da una parte sia alternativa
al determinismo meccanicistico e dello storicismo, e dall'altra renda conto
del divenire sovradeterminato e complesso della storia e delle sue istituzioni[19];
- una teoria del pensiero che ne metta in luce l'appartenenza ad un contesto
epocale dato, quello che Heidegger chiama l'ascolto dell'essere,
essendo il depositario dei suoi tratti fondamentali[20];
- un'ontologia del presente, i concetti che rappresentino il modo d'essere
complessivo di una fase storica specifica, nei contenuti culturali, relazionali,
produttivi, da cui traggono origine il vero e il non vero. Heidegger chiama
alétheia e Nietzsche valore la particolare economia
della presenza di un'epoca[21];
- un pensiero del libero divenire, della infinita produzione di vita frutto
delle libere aggregazioni dei corpi, la volontà di potenza[22];
- mettere in questione i fondamenti del pensiero occidentale, svelandone
i rapporti intrinseci con la società capitalistica matura dell'età
della tecnica.
Al di là del debito nei confronti di Heidegger e Nietzsche, questi
sono i temi che occupano Althusser nei suoi ultimi interventi filosofici.
Invece di un autore rigidamente attaccato agli schemi canonici del marxismo,
da essi emerge un pensatore per l'oggi, che non rimuove i problemi
della società tecnologica e mediatica attuale, in cui gli apparati
di diffusione di valori - immagine costituiscono nuove forme di oppressione
e controllo. Gli strumenti che ci offre, ed in particolare una teoria non
dialettica della trasformazione, aprono la prospettiva di un sapere della
libertà.
Sulla filosofia
Il presente volume è la traduzione italiana del testo pubblicato
in Francia nel 1994 per i tipi di Gallimard, collana l'infini, e
curato dall'Institut mémoires de l'édition contemporaine (IMEC).
In esso sono raccolti l'intervista - saggio concessa da Althusser a Fernanda
Navarro, e pubblicata nel 1988 in Messico per le edizioni Siglo XXI Editores.
La corrispondenza che Althusser ha tenuto con Fernanda Navarro nel periodo
1984 - 1987, a cui è stata aggiunta una lettera a Mauricio Malamud,
professore argentino amico di Althusser, del 1984. Queste lettere sono particolarmente
preziose non solo per le informazioni che ci danno sulla condizione e il
travaglio di Althusser in quel momento, ma anche perché ci permettono
di seguire la gestazione del testo poi pubblicato in Messico. Si noterà
la sua estrema puntigliosità nella cura del testo, e i suoi, a volte
sorprendenti, ripensamenti.
Il terzo testo è la conferenza di Granada, pronunciata nel 1976 con
il titolo la trasformazione della filosofia, dove vengono preannunziati
i temi poi sviluppati negli anni '80.
Per più approfondite informazioni editoriali e storiche rimandiamo
alle avvertenze e alle note d'edizione, oltre alla presentazione di Fernanda
Navarro.