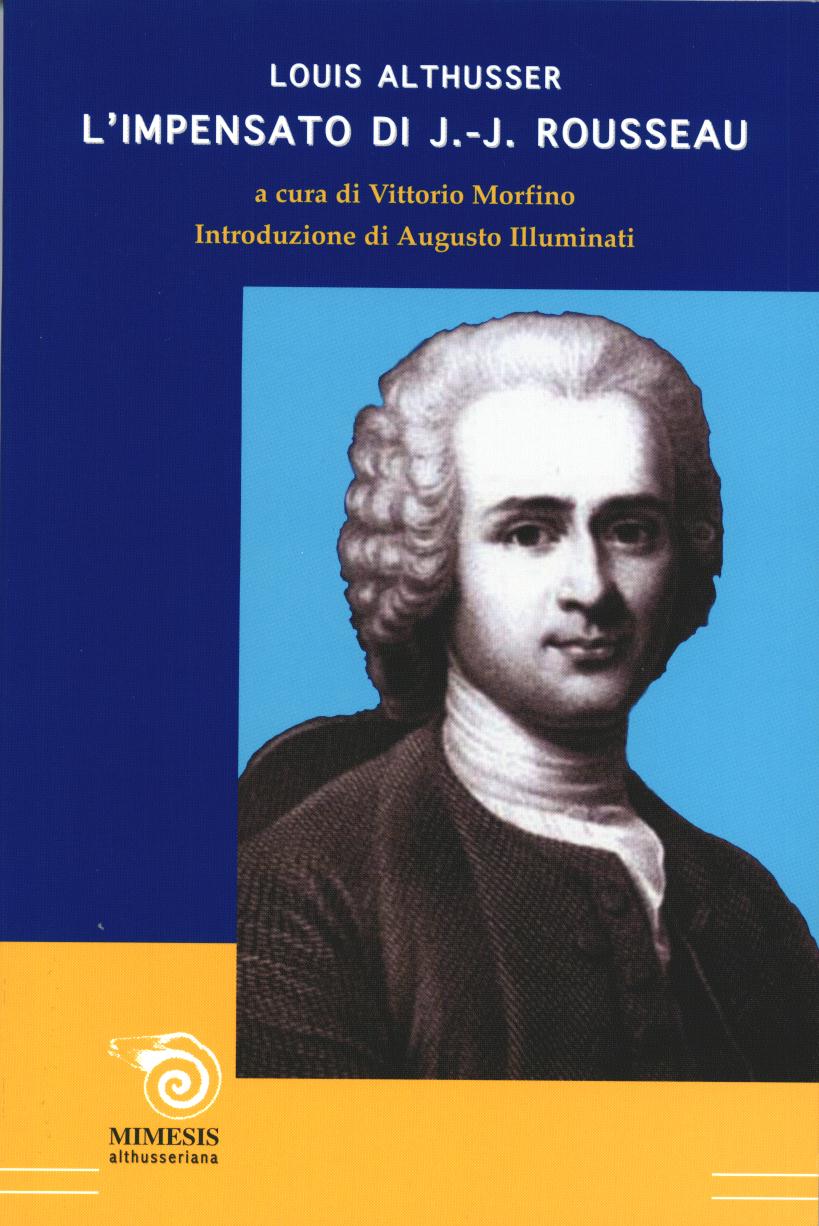
L'impensato di Jean-Jaques Rousseau
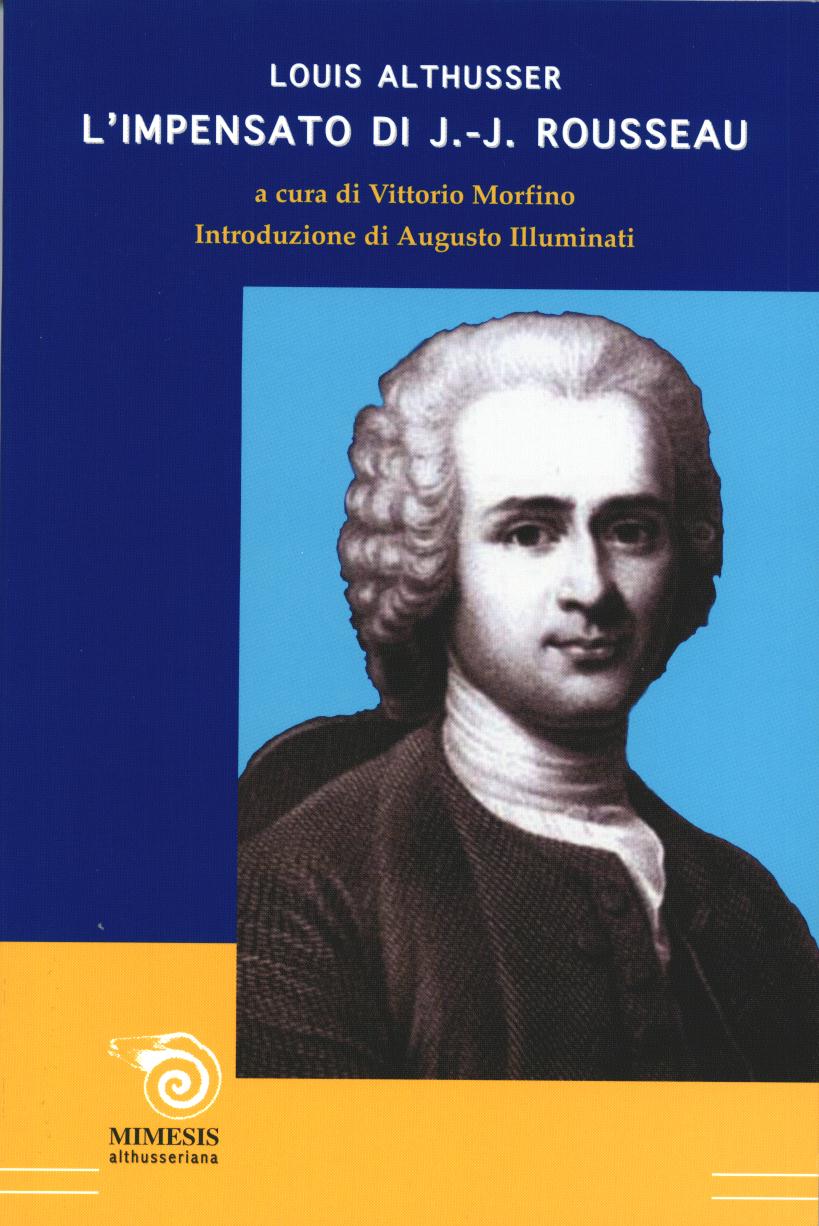 |
Louis Althusser L'impensato di Jean-Jaques Rousseau |
Louis Althusser, L'impensato di Jean-Jacques Rousseau
recensione di Andrea Cavazzini
Il volume è la prima traduzione italiana di due contributi althusseriani
sulla filosofia politica dell'età classica: il primo è un
lungo saggio sul Contratto Sociale apparso nei Cahiers pour l'analyse, il
secondo una breve recensione di un libro di Raymond Polin su Locke. Qui
limiteremo la nostra attenzione al saggio roussoviano, che dà il
titolo al volume.
Althusser legge il Contratto Sociale attraverso l'analisi dei suoi "scarti"
(décalages) teorici, i quali organizzano il dispositivo concettuale
dell'opera ed al tempo stesso segnano la presenza delle aporie oggettive
da cui essa è attraversata: aporie che rilevano da ultimo dal rapporto
tra la realtà storica e la razionalità teoretica. Se in un'ottica
hegeliana la realtà è contenuta senza residui nella razionalità,
che ne è lo specchio fedele, nella prospettiva sintomatologica (marxista
e psicanalitica) di Althusser la storia resiste alla riscrittura concettuale,
e la teoria deve elaborare strategie di contenimento per occultare questa
resistenza. La realtà diventa il reale, e la razionalità diventa
razionalizzazione. La razionalità pretende di offrirci la visione
della realtà in trasparenza, ma il reale può apparire soltanto
nei sintomi, cioè nelle crepe della razionalizzazione che vorrebbe
occultarne l'irriducibilità all'esplicitazione nell'ordine simbolico
della teoria. I sintomi sono gli scarti stessi della costruzione teorica.
Il Contratto Sociale si vuole soluzione di un'aporia storica. Le forze
a disposizione dell'umanità sono cresciute a dismisura nel corso
della storia e nel cammino della civilizzazione. Poiché questa crescita
ha avuto luogo in condizioni di disuguaglianza, ad un certo punto essa minaccia
la conservazione stessa del genere umano. L'accaparramento esclusivo delle
terre ha prodotto la divisione conflittuale tra gli uomini (ricchi/poveri,
padroni/schiavi), ed ha al tempo stesso costituito l'uomo come titolare
di un interesse particolare (sviluppo sociale dell'amor proprio naturale),
opposto ad altri interessi particolari. L'interesse particolare è
prodotto da rapporti sociali conflittuali che, generalizzati in uno stato
di guerra universale, minacciano la vita, la libertà, la proprietà,
quindi l'interesse particolare stesso. Questa contraddizione può
condurre all'estinzione del genere umano se quest'ultimo non cambierà
la propria "maniera di essere".
Partendo da tale problema (la risoluzione della conflittualità
sociale), il Contratto Sociale produce una serie di scarti che costituiscono
l'architettura della trama concettuale con cui Rousseau cerca di dominare
le contraddizioni reali. Althusser individua quattro scarti; gli scarti
I-II si danno tra livelli puramente teoretici, gli scarti III-IV tra il
livello teorico come tale e il reale. Questi ultimi governano i primi due.
Lo Scarto I riguarda il contratto che dà vita al Corpo Sovrano mediante
l'alienazione totale dei singoli alla comunità, da cui ognuno riceve
in cambio la sicurezza di cui non godeva nello stato di guerra. Lo scarto
qui è tra la forma-contratto e il contenuto dell'alienazione. Un
contratto è un do ut des tra soggetti indipendenti, già dati
prima dell'atto contrattuale. Ma qui un contraente (il Corpo Sovrano) non
esiste prima che gli individui gli alienino tutti i loro diritti. Eppure
questa alienazione viene espressa come uno scambio tra gli individui e la
Comunità, la quale dovrebbe nascere solo come effetto del Contratto.
In realtà, l'alienazione dei singoli nel Corpo Sovrano non è
un contratto. Gli individui si annichiliscono per rinascere come Comunità:
per questa alienazione non c'è contropartita, non esiste un do ut
des perché non c'è reciprocità. In effetti, non ci
sono nemmeno due soggetti coinvolti: l'alienazione è puramente interiore:
le categorie giusprivatistiche dello scambio e del contratto non sono adeguate
al contenuto dell'atto.
Lo Scarto II reintroduce lo scambio: è uno scarto tra il contenuto
teorico della costituzione del Corpo Sovrano e l'affermazione che, nell'alienazione
totale, l'individuo vede garantito il proprio interesse. A rigore, se l'alienazione
è questo atto privo di controparte e dunque di contropartita, gli
interessi dei singoli non possono essere garantiti: il darsi alla comunità
dovrebbe trascenderli ed esser loro incommensurabile. Lo scarto che li reintroduce
di fatto nega l'assolutezza dell'alienazione, e vincola la costituzione
ed il primato della comunità alla tutela degli interessi privati.
I primi due scarti hanno per effetto la conciliazione (teorica) tra universale
e particolare, tra individuo e comunità. Le condizioni di questo
effetto sono date dal "gioco" sulla natura del Contratto. È
però negli scarti III e IV che si trovano le ragioni per cui è
necessario tentare questa armonizzazione forzata.
Lo scarto III riguarda il rapporto tra interesse (volontà) generale
e interesse (volontà) particolare: l'interesse particolare, "la
preferenza accordata a se stessi", è il fondamento del generale.
Senza di esso, non vi potrebbe essere l'alienazione che, come sappiamo,
istituisce la comunità per proteggere l'interesse dei singoli. Ma
l'interesse particolare è anche l'ostacolo alla formazione della
volontà generale, tanto che il Corpo Sovrano, per esistere, deve
cancellare ogni differenziazione al proprio interno, eliminando gruppi,
partiti, sindacati, sette, ecc. Althusser sostiene che qui Rousseau chiama
con un stesso nome due oggetti differenti: l'interesse particolare di ogni
singolo individuo isolato, e l'interesse particolare di un gruppo sociale
concreto sottomesso a specifiche condizioni sociali di esistenza. Il primo
"interesse" non è realmente in contrasto con la volontà
generale, anzi, ne è il presupposto; il secondo, invece, la mina
irreparabilmente. Questa scissione nel concetto è sintomo di uno
scarto tra la teoria ed il reale. Rousseau costruisce una "particolarità"
compatibile con la volontà generale, mentre la reale particolarità
degli interessi resta un impensato e come tale affiora in uno sintomo.
Il risultato è che la realtà del conflitto sociale viene occultata
dalla polarità di due costruzioni mitiche che si sostengono a vicenda,
(l'interesse dell'individuo isolato e la volontà generale), la cui
funzione è appunto quella di nascondere che non vi sono individui
isolati, né una volontà generale, ma solo conflitti di classe:
che, come tali, non sono né individuali né generali, ma transindividuali.
Rousseau demonizza la "particolarità" reale dei conflitti
e concilia quella immaginaria dei singoli con un altrettanto immaginario
interesse generale. Questa conciliazione riproduce esattamente ciò
che Rousseau individua come la strategia di dominio propria agli originari
accaparratori delle terre: la dialettica tra l'individuo atomico, originariamente
padrone di se stesso, e l'interesse generale nasconde il fatto che alcuni
uomini sono padroni di altri, e quindi hanno interessi oggettivi differenti.
Il Contratto Sociale finisce con la stessa mistificazione (l'occultamento
di una conflittualità immanente ai rapporti sociali) da cui ha avuto
inizio lo stato di cose che vorrebbe risolvere. L'ultimo scarto istituisce
due soluzioni immaginarie al problema del conflitto sociale: la piccola
proprietà indipendente per assicurare l'autonomia dei singoli, e
l'educazione (la religione civile) per garantire l'unità della Volontà
Generale. Il velleitarismo di queste proposte denuncia che la teoria politica
qui incontra i suoi limiti, cioè l'incoercibilità della lotta
di classe quale impensato di ogni teoria delle condizioni di equilibrio
della vita sociale.
Secondo Althusser, la soluzione ideologica dell'educazione popolare "va
all'infinito". Qui possiamo trovare una chiave per l'interpretazione
"totalitaria" di Rousseau, che Althusser non tratta direttamente.
L'ideale di una coesione sociale impossibile si muta nell'ossessione di
una pratica di indottrinamento supposta produrre l'unità e l'uniformità
del popolo. Poiché si tratta di un'unità immaginaria, la realtà
le è sempre inadeguata, e ciò produce una tensione verso un
controllo sempre più stretto su costumi, azioni, parole e pensieri.
La tentazione totalitaria sembra dunque immanente al misconoscimento della
lotta di classe: è una fuga in avanti volontarista mossa dalla negazione
di un conflitto immanente alla società. Più che un prodotto
delle "ideologie", il totalitarismo sembra essere il sogno proibito
di ogni teoria (anche "democratica") della composizione armoniosa
degli interessi.
Tuttavia, Althusser nota (in una variante espunta dall'articolo definitivo)
che Rousseau fornisce anche un contravveleno all'assolutizzazione dell'ideologia
in cui sfocia il Contratto Sociale. Perché per il Ginevrino la storia
è sempre alcunché di precario e contingente, un tessuto di
rapporti di forza e di congiunture singolari e irriducibili. Quindi, le
possibilità di instaurare realmente un ordine sociale quale quello
descritto nel Contratto sono quanto mai scarse: le condizioni a ciò
favorevoli non saranno mai riunite tutte assieme al momento giusto in un
unico luogo. Nella storia, dobbiamo cavarcela con i materiali offerti dalle
circostanze. Questo è l'ultimo irrompere del reale nella teoria,
tanto più radicale in quanto esso determina un'altra teoria. La teoria
della politica rimuoveva il reale in una totalizzazione immaginaria, provocandone
il ritorno sintomatico; la teoria della storia esplicita il contenuto del
sintomo, che è la resistenza del reale alle conciliazioni teoriche.
Ma con ciò appunto entriamo in un altro universo teorico quello
marxista, in cui la ricerca delle istituzioni "giuste" e durature
è sostituita dalla conoscenza del rapporto tra le forme politiche
e le condizioni storiche del conflitto sociale. Alla ricorrente accusa secondo
cui il marxismo non ha una teoria politica, Althusser sembra aver risposto
che infatti è così, ma che non per questo il marxismo non
ha nulla da dire sulla politica il marxismo è una teoria della
storia, e la storia, come mostrano le aporie di Rousseau, è l'anomalia
del Politico.