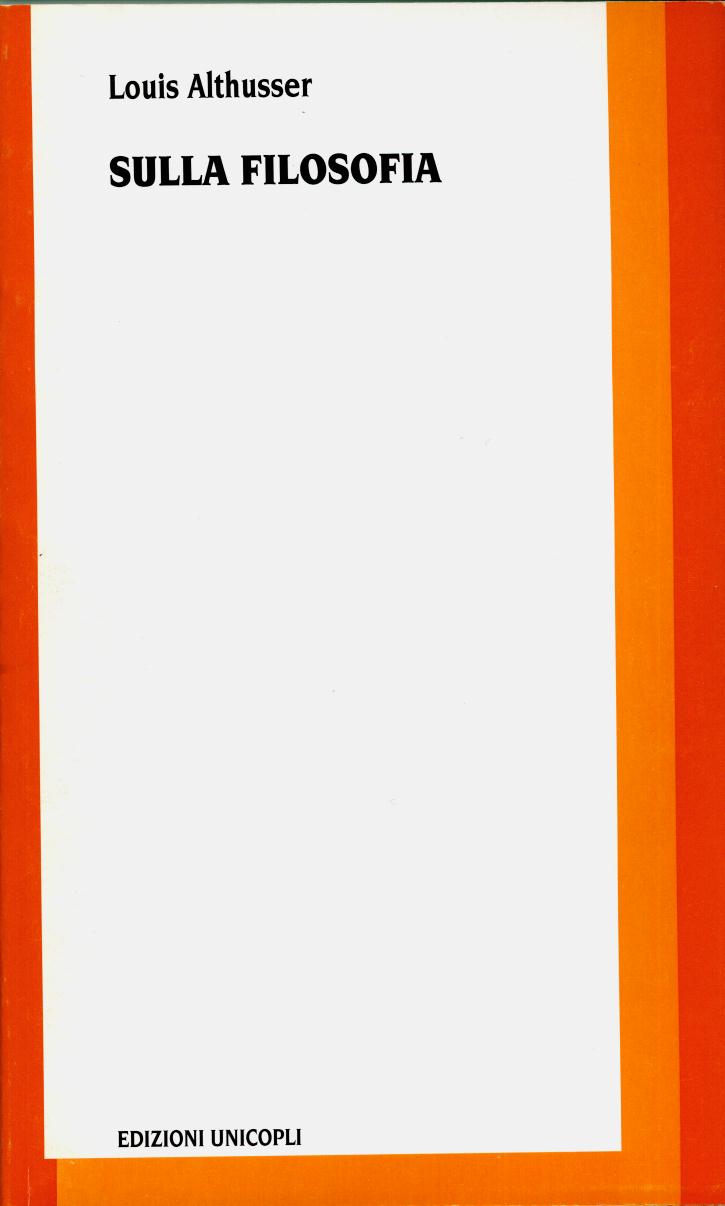
Sulla filosofia
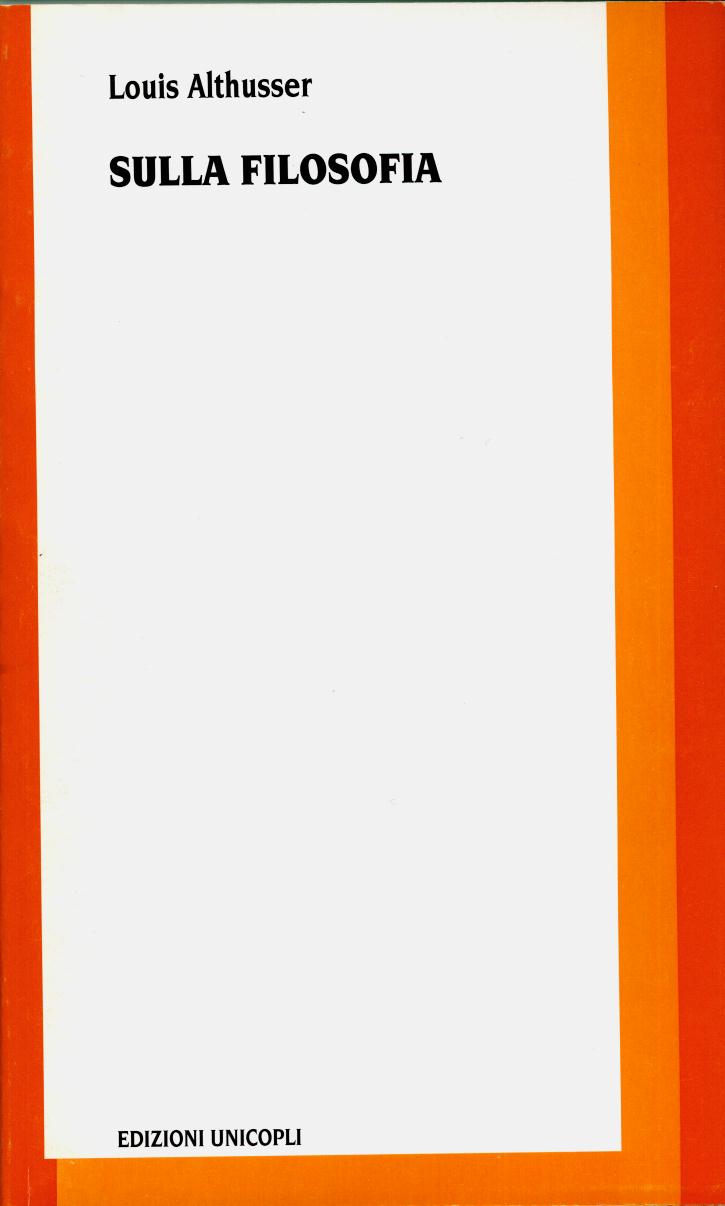 |
Louis Althusser Sulla filosofia |
Questo volume si compone di materiali eterogenei: alcuni "testi messi in forma di dialogo", come avverte la quarta di copertina, in cui Althusser espone, tra l'84 e l'87, alla filosofa messicana Fernanda Navarro le sue vedute; una serie di lettere dello stesso periodo concernenti l'edizione delle conversazioni tra i due (più una a Mauricio Malamud, responsabile del loro incontro); infine, una conferenza del 1976 a Granada sulla "Trasformazione della filosofia". Nonostante la detta eterogeneità (aggravata dalle condizioni di Althusser, che lo costringeranno a rettificare più volte le proprie formulazioni), l'unità dei testi è data in maniera massiccia dal fin troppo ingombrante tema suggerito dal titolo: il tema dello statuto della filosofia. Ovviamente, ciò rende il volume qualcosa di più di un documento dal valore puramente antiquario; conoscere questi lavori di Althusser ha un valore storico, ma nel senso della nicciana "storia critica", portatrice di un'attività discriminante orientata alle esigenze dell'oggi. Ed è appunto un'esigenza attuale quella di interrogarsi sul senso dell'attività filosofica. Come rileva il curatore Aldo Pardi nell'Introduzione ai testi, Althusser caratterizza la filosofia come un'attività immersa nella storia e nei rapporti sociali; questo però non comporta nessun "sociologismo", innanzitutto perché essa non "rispecchia" le proprie condizioni storiche, ma piuttosto consiste nel portarle ad uno stato di pensabilità razionale (altro presupposto della filosofia è infatti il linguaggio teoretico, astratto e oggettivo); inoltre, perché questa pratica di riflessione conosce due modalità che corrispondono a diverse posizioni verso le forme storiche "riflesse" in essa. Nella prima, si tratta di dominare ed unificare queste forme, ponendo domande sulla loro ragion d'essere, sul Fine cui servono raddoppiato nell'Origine da cui provengono. La filosofia allora elabora il concetto di un Principio delle cose in grado di unificare le pratiche umane "deducendole" da esso: tale è il concetto di soggetto da Descartes in poi, operante nella teoria della conoscenza, nel diritto, nella politica, nell'economia - pratiche unificate dal richiamo presunto fondante all'unità ed alla trasparenza a sè del soggetto. Questa è la via della filosofia che si è voluta discorso critico fondativo, imbricato in pratiche di dominio e controllo sociale. La seconda modalità, invece, rifiuta ogni domanda sul Fine, non cerca di dedurre "le cose" dai Principi; si limita a registrare sequenze aleatorie di eventi, ad analizzare comportamenti e combinazioni delle "cose" stesse, portandole alla vita razionale del linguaggio - un linguaggio che rinuncia alla pretesa di far coincidere in sé stesso pensiero e realtà, ma si vuole radicalmente convenzionale, in quanto una realtà fatta di occorrenze singolari in teoria potrebbe essere solo indicata. Questo modo di filosofare, il cui rifiuto della totalizzazione finalistica mina le basi ideali del dominio, si è incarnato nelle correnti eretiche della storia del pensiero: accanto ad Epicuro, Spinoza, Marx ed agli altri citati negli scritti sul "materialismo aleatorio" (editi come secondo volume di "Althusseriana"), qui troviamo anche i Sofisti e Guglielmo di Ockham. Protagora viene elogiato per il suo mito della nudità umana - che deriverebbe la società e le tecniche non da un atto volontario, né da una Bestimmung des Menschen che la Civiltà dovrebbe realizzare, ma dall'esigenza umana di "esonerarsi" dalla propria fragilità. Il "mito materialista" è peraltro comune a quasi tutti gli autori che Althusser iscrive nella propria genealogia: dal Dio "geometrico" alla pioggia cosmica, dal Principe sorto dal niente al bellum omnium al buon selvaggio; aggiungiamo sulla scorta di Hans Blumenberg che in Ockham l'onnipotenza assolutamente incausata ed arbitraria di Dio serve a pensare la proliferazione indefinita degli enti in un mondo strutturalmente difforme dalla ragione umana, rispetto alla multiformità del quale è poi necessario economizzare radicalmente le pratiche linguistiche. In tutti questi casi vediamo l'esigenza di sostituire all'Origine un'Antiorigine. La posizione iniziale di un'indeterminatezza assoluta, da cui nulla può essere dedotto secondo ragione, garantisce di poter pensare ogni sviluppo come imprevedibile. Il Principio garantisce l'identità sostanziale delle cose che da esso si generano in una processione predeterminata; al contrario, il Vuoto mostra quanto la storia lavori e corroda ogni permanenza, mostrando all'inizio delle cose uno stato da cui un gioco di forze avrebbe potuto derivare qualsiasi risultato, e rispetto al quale ogni risultato appare un allontanamento radicale ed indeducibile: il "mito materialista" ha così compiuto il détournement dell'esigenza fondativa della ricerca di una ratio rationis. Riconducendo la filosofia alla vita storica, Althusser non ha potuto fare a meno di elaborare un concetto di storia adeguato alle esigenze della filosofia. In questo circolo virtuoso, la pratica storica, e il pensiero che la riflette, appaiono come compiti destinati a ricominciare immer wieder.